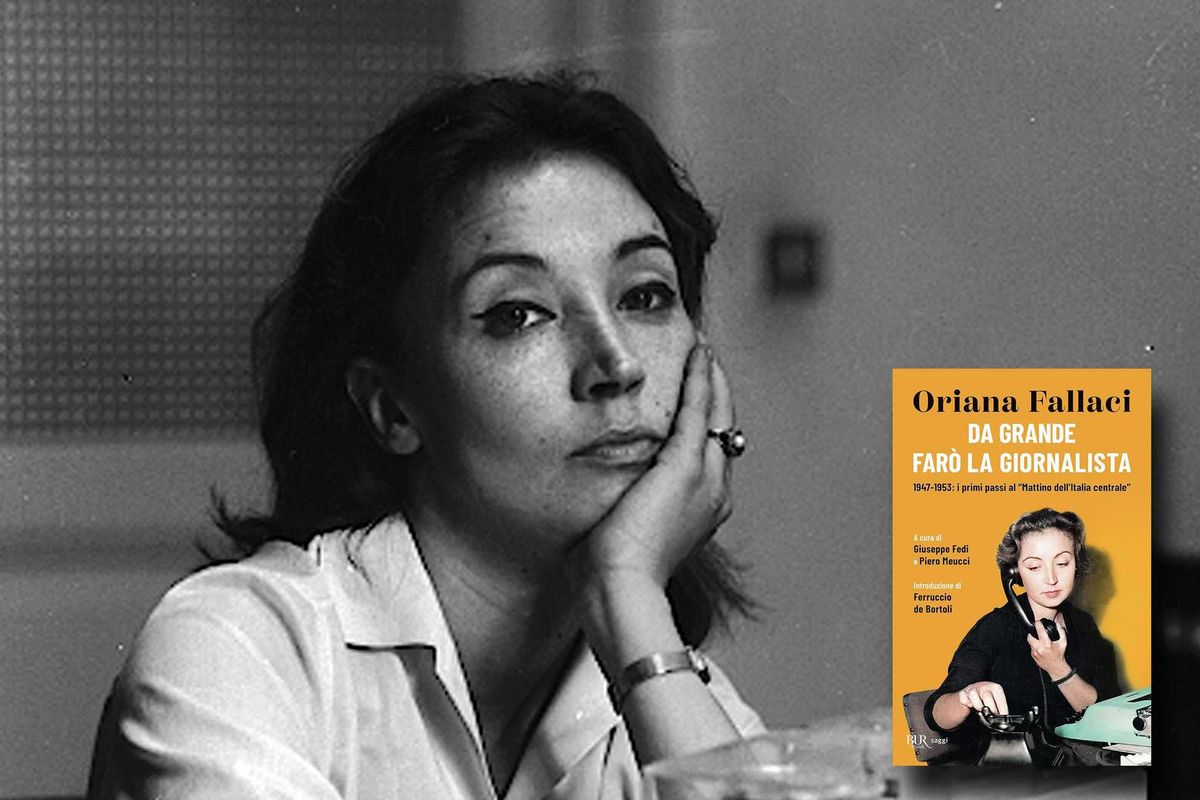True
2018-12-10
Una vita... «pepata». Saper usare le spezie fa stare meglio e aiuta a conoscere la nostra storia
Spezie: si tratta dell'ingrediente considerato meno importante in dispensa, perché, diciamoci la verità, la spezia è il puntino sulla i, non la i. La spezia completa un piatto, ma non può costituire da sola una pietanza, a parte l'eccezione del cioccolato realizzato con il cacao (con le fave, non con la polvere che usiamo come spezia) che, comunque, è un fine pasto, non un pasto intero. Eppure, le spezie meritano assolutamente di essere svestite degli abiti da Cenerentole della cucina che le caratterizzano oggi e ricoperte con il mantello regale che è sempre stato loro proprio. Possiedono, infatti, un peso letteralmente fondamentale: nella cucina e nella storia, gastronomica e in generale. Ricordarcelo vuol dire ricordare anche parte della nostra storia. Spezie deriva dal latino species, con il significato di specie, probabilmente intendendo le specie (vegetali) per eccellenza. Percepite come una sorta di verdure concentrate e utilizzate per lo più in polvere, previe seccatura e polverizzazione, le spezie erano utilizzate da Sumeri, Egizi, Fenici, Assiro-babilonesi, Cinesi, Persiani, Greci e Romani come aromi alimentari, innanzitutto. Poi, come ingredienti di rituali sacri, profumi e medicine. Arrivavano in Occidente da India, Indonesia, Malesia e Cina. Il monopolio del trasporto delle spezie da Oriente a Occidente era in mani arabe. Le spezie, con il loro sapore particolare e le proprietà medicamentose che le facevano considerare alla stregua di polveri quasi magiche, erano uno status symbol, preziose come l'oro e il prodotto perfetto: piccole dimensioni, altissimo prezzo e domanda costante. I mercanti di spezie arabi riuscivano a mantenere l'esclusiva della distribuzione del pregiato prodotto orientale in terra occidentale raccontando, in verità, grandi balle sulla pericolosità del loro reperimento, che dissuadevano i consumatori dal procurarsele da sé (pensate che le spezie, come le gemme e la seta, si pagavano in oro e i Romani, per esempio, importavano talmente tanto pepe che si rese necessario costruire appositi depositi denominati horrea pipearia).
Erodoto scrive, riguardo al cinnamomo, ossia l'attuale cannella: «Tali uccelli lo porterebbero nei loro nidi fatti di fango su montagne scoscese e inaccessibili all'uomo. E così gli Arabi hanno escogitato una astuzia: tagliano a pezzi, grossi il più possibile, le carcasse di buoi, di asini o di altri animali da tiro morti, e li portano in quei luoghi, posandoli non lontano dai nidi; poi si allontanano. Gli uccelli scendono velocemente in volo sulle carni e le trasportano nei loro nidi, i quali però non essendo in grado di reggere un tale peso, si rompono e precipitano al suolo; gli uomini accorrono e provvedono a raccogliere il cinnamomo; il cinnamomo lì raccolto arriva poi in tutti gli altri paesi». Insomma, scenari da supereroi, di cui poi si scoprì lo status di fake news. La qual cosa fece sì che nel VII secolo Carlo Magno emani l'editto Capitulare de villis vel curtis imperii, contenente un copioso elenco di spezie che dovevano essere coltivate su terre imperiali e monasteri, dalla senape al papavero, dal coriandolo al cumino, dall'aneto alla nigella. All'incirca nell'anno 1000 assume rilievo la figura dello speziale, il farmacista ante litteram che utilizza spezie e non molecole spesso sintetiche come oggi.
Il Medioevo sancisce la familiarizzazione di ogni categoria sociale con le spezie. Nei secoli successivi si profila un nuovo tipo di commercio speciale di stampo prettamente coloniale: nel XVII secolo si affermano le
Compagnie di Inghilterra, Olanda e Francia, che le distribuiscono in esclusiva da India, Ceylon, Malesia, Molucche, Cina e Giappone. Successivamente, altri prodotti esotici - dallo zucchero al cacao, dal tè al caffè, interesseranno le rotte di importazione: le spezie, pian piano, si avviano al tramonto, si radicano a gruppi in ciascuna cucina connotandone il gusto (per esempio il curry in quella indiana, il basilico in quella italiana). Solo oggi, con l'avanzamento di una cucina globale e con l'interesse sempre più vigoroso per le proprietà anche curative del cibo, le spezie, tutte, anche le più esotiche, stanno tornando ad attirare la nostra attenzione. Le spezie, insomma, possono perdere temporaneamente, ma mai per sempre, il loro fascino. Le decantava il Cantico dei cantici nella Bibbia, che nel quarto poema fa dire allo sposo, rivolto alla sposa: «Giardino chiuso tu sei, / sorella mia, mia sposa, / sorgente chiusa, fontana sigillata. / I tuoi germogli sono un paradiso di melagrane, / con i frutti più squisiti, / alberi di cipro e nardo, / nardo e zafferano, cannella e cinnamòmo, / con ogni specie di alberi d'incenso, / mirra e àloe, / con tutti gli aromi migliori». Con un balzo temporale assai lungo, planiamo nel 1966: Paul Simon e Art Garfunkel intitolano Parsley, sage, rosemary and thyme il loro terzo album e così canta un verso ricorrente della prima traccia, Scarborough fair/canticle, una ballata inglese del XVI secolo la cui citazione ripetuta dell'elenco di spezie prezzemolo, salvia, rosmarino e timo è al centro di varie tesi.
Quello delle spezie è un vero e proprio universo, difficile da conoscere fino in fondo. Nell'interessante libro Le spezie della salute in cucina, Natasha MacAller le organizza in base alle proprietà terapeutiche. Le spezie che aiutano le difese immunitarie sono la curcuma, il cumino, il cumino nero, i chiodi di garofano, il pimento, la scorza di agrumi, l'anice stellato, l'aglio, il fieno greco, la melagrana, il rosmarino, la senape e il wasabi. Alla curcuma, la gustosa spezia indiana immancabile nei piatti al curry, sono riconosciute proprietà antiossidanti, antisettiche, antinfiammatorie - in particolar modo nei confronti delle malattie antinfiammatorie croniche dell'intestino come morbo di Crohn e colite - e analgesiche. Ridurrebbe, poi, il colesterolo cattivo e i trigliceridi. Il cumino è invece utilizzato per combattere i batteri responsabili di intossicazioni alimentari, come cataplasma per la gola e gli organi digestivi infiammati, come aiuto antistress e per abbassare la glicemia. I chiodi di garofano sono antinfiammatori, antiossidanti, antisettici e anestetici locali, tanto che l'eugenolo è stato usato a lungo in odontoiatria come anestetico locale e antisettico. La scorza di agrumi, che tipicamente grattugiamo nelle ricette dolci e non soltanto, contiene più vitamina C del succo e della polpa, oltre a sostanze chimiche vegetali che potrebbero avere effetto protettivo nei confronti della formazione del cancro, come d-limonene, esperidina, naringina e auraptene. L'anice stellato - che non deve mai essere dato ai bambini - viene usato nella medicina tradizionale cinese contro infiammazioni, nervosismo, insonnia e dolore, in più possiede proprietà antibatteriche, antimicotiche, antiossidanti e, infine, antinfluenzali grazie all'acido scichimico. Le spezie disintossicanti sono la cannella, il rosmarino, l'origano, l'alloro, l'ibisco. Disintossicano nel senso che sostengono i naturali sistemi di detossificazione dell'organismo. La cannella sarebbe in grado di abbassare la glicemia e la pressione sanguigna e interviene sui recettori dell'insulina, così alterando il modo in cui il fegato metabolizza lo zucchero nel sangue. Contenendo però molta cumarina, assunta in grandi quantità (ma le spezie vanno assunte sempre in piccola quantità) può essere dannosa per il fegato.
Del rosmarino mangiamo gli aghi - che poi sono le foglie - e il suo uso più sorprendente è sulla carne: «Quando la carne cotta alla griglia o ad alte temperature viene precedentemente marinata con del rosmarino si determina, oltre all'abbattimento della quantità di batteri, anche la riduzione del rischio di tumori all'intestino e al seno. Il rosmarino essiccato in polvere ha dato prova di diminuire sensibilmente (fino al 77%) la formazione di ammine eterocicliche (composti organici cancerogeni che si sviluppano quando la carne cuoce ad alte temperature) in hamburger di manzo cotti alla griglia a 200 gradi centigradi», spiega John La Puma. L'origano è un buon rimedio per le infezioni delle vie respiratorie e dell'apparato gastrointestinale: i suo oli volatili, timolo e carvacrolo, inibiscono la crescita di molti batteri, compreso l'Helicobacter pylori. L'alloro contiene, nelle sue foglie, enzimi che favoriscono la digestione e l'assimilazione di nutrienti e per questa ragione è consigliabile aggiungerlo ai piatti ad alto contenuto proteico difficili da digerire. Le spezie energetiche sono il pepe nero, il coriandolo, il cacao, la noce moscata, il tamarindo. Il pepe nero contiene piperina, potenziatore di biodisponibilità, che accresce le proprietà di altre spezie come ad esempio la curcuma. Inoltre, aumenta nell'organismo citochine antinfiammatorie, migliorando la salute polmonare, articolare e il dolore ed è un perfetto antimicrobico. La noce moscata è utile in caso di diarrea, nausea, dolori addominali e gas intestinali e le si riconoscono proprietà microbiche. Le spezie riscaldanti sono il peperoncino, lo zenzero, i semi di senape, il rafano, il wasabi. Il peperoncino aiuta nella cefalea a grappolo, nel dolore neuropatico diabetico e nella sindrome dell'intestino irritabile. Possiede anche capacità antiossidanti e sembra che le nazioni nelle quali si consuma molto peperoncino il tasso di malattie cardiovascolari sia più basso rispetto a quelle che ne fanno un uso minore. Lo zenzero è un antibatterico, ma gli sono riconosciuti anche effetti tonico-cerebrali e di sollievo dal dolore. Le spezie rigeneranti sono l'aglio, il cardamomo, la melagrana, il fieno greco, il timo. L'aglio tagliato o schiacciato rilascia allinasi, enzima che attiva l'effetto antinfiammatorio e antitumorale (riduce la formazione di nitrosammine, sostanze cancerogene). Le spezie rilassanti sono la salvia, il basilico, lo zafferano, la menta, la citronella. La salvia calma la mente, allevia il mal di gola e il raffreddore. Squisite le sue foglie colte fresche e fritte in pastella, ricordatevi che nel caso di utilizzo di salvia secca un cucchiaino equivale a un cucchiaio di salvia fresca. Il basilico, oltre a riempirci le narici di un profumo meraviglioso e così familiare, per noi italiani, è antimicrobico, antiossidante, cardioprotettivo.
Zafferano e non curcuma per preparare un autentico risotto alla milanese
Lo zafferano è una spezia molto particolare. Si coglie il fiore, ma si utilizzano solo gli stimmi. Circa tre per fiore, per ottenere un chilo di zafferano puro ci vogliono circa 250.000 fili e oltre 4.000 metri quadrati di fiori. Si tratta di una spezia costosissima e infatti, se ci fate caso, in molti supermercati viene tenuto in scatolette protettive aperte in cassa dopo il pagamento (pare che sia una spezia rubatissima). Allo zafferano è riconosciuta una gamma molto ampia di proprietà: antidepressivo, ansiolitico, contrastante degli squilibri ormonali, antibatterico, anti radicali liberi e preventivo del tumore epatico. Molto ricco di potassio e vitamina C, viene considerato utile anche per abbassare la pressione sanguigna, facilitare la digestione e regolarizzare il battito cardiaco.
Nella cucina italiana, lo zafferano è l'ingrediente re del risotto alla milanese. Gualtiero Marchesi, che lo ha nobilitato con la famosa foglia d'oro, lo faceva così, eliminando il midollo di bue che nella ricetta tradizionale è tassativo e lasciando solo l'aroma della cipolla. Per 4 persone, tostare 300 grammi di riso Carnaroli in poco burro per al massimo due minuti, bagnare con vino bianco, fare evaporare, versare un litro di brodo di carne leggero e 5 grammi di stimmi di zafferano e cuocere per circa 18 minuti. Salare, mantecare con 20 grammi di parmigiano e il burro acido preparato mentre cuoceva il riso e che si fa così: si fa soffriggere in poco burro una cipolla tritata per qualche minuto, si bagna con vino e si fa evaporare. Si filtra e si aggiungere il burro in pomata, mescolando delicatamente con una frusta. Alla fine, il tutto si stende a velo sui piatti e si completa con una foglia d'oro alimentare al centro di ogni porzione.
Alcuni usano sostituire lo zafferano del risotto alla milanese tradizionale con la curcuma - magari fresca, grattugiata - che dà più o meno lo stesso colore ma un sapore diverso. Tuttavia, per quanto gustoso, il risotto alla milanese con la curcuma semplicemente non è il risotto alla milanese. Le piccole leggi dello zafferano da tenere a mente sono le seguenti. Sono preferibili i pistilli di zafferano intero, alla polvere: più è caldo il suo tono giallo-arancio, migliore sarà la crocina contenuta. Un trucchetto per scoprire se si tratta di vero zafferano (lo zafferano è anche una spezia assai sofisticata, diffidate di quello che costa troppo poco) è mettere i pistilli in acqua calda: si devono dissolvere. Tenetelo anche al riparo dalla luce.
Continua a leggereRiduci
In passato erano roba da ricchi, i Romani le pagavano a peso d'oro. Hanno innumerevoli proprietà curative: il garofano è antisettico, la cannella riduce la glicemia, il rosmarino combatte gli agenti cancerogeni, l'alloro fa digerire, il basilico profuma e protegge pure il cuore. Zafferano e non curcuma per preparare un autentico risotto alla milanese. Lo speciale comprende due articoli. Spezie: si tratta dell'ingrediente considerato meno importante in dispensa, perché, diciamoci la verità, la spezia è il puntino sulla i, non la i. La spezia completa un piatto, ma non può costituire da sola una pietanza, a parte l'eccezione del cioccolato realizzato con il cacao (con le fave, non con la polvere che usiamo come spezia) che, comunque, è un fine pasto, non un pasto intero. Eppure, le spezie meritano assolutamente di essere svestite degli abiti da Cenerentole della cucina che le caratterizzano oggi e ricoperte con il mantello regale che è sempre stato loro proprio. Possiedono, infatti, un peso letteralmente fondamentale: nella cucina e nella storia, gastronomica e in generale. Ricordarcelo vuol dire ricordare anche parte della nostra storia. Spezie deriva dal latino species, con il significato di specie, probabilmente intendendo le specie (vegetali) per eccellenza. Percepite come una sorta di verdure concentrate e utilizzate per lo più in polvere, previe seccatura e polverizzazione, le spezie erano utilizzate da Sumeri, Egizi, Fenici, Assiro-babilonesi, Cinesi, Persiani, Greci e Romani come aromi alimentari, innanzitutto. Poi, come ingredienti di rituali sacri, profumi e medicine. Arrivavano in Occidente da India, Indonesia, Malesia e Cina. Il monopolio del trasporto delle spezie da Oriente a Occidente era in mani arabe. Le spezie, con il loro sapore particolare e le proprietà medicamentose che le facevano considerare alla stregua di polveri quasi magiche, erano uno status symbol, preziose come l'oro e il prodotto perfetto: piccole dimensioni, altissimo prezzo e domanda costante. I mercanti di spezie arabi riuscivano a mantenere l'esclusiva della distribuzione del pregiato prodotto orientale in terra occidentale raccontando, in verità, grandi balle sulla pericolosità del loro reperimento, che dissuadevano i consumatori dal procurarsele da sé (pensate che le spezie, come le gemme e la seta, si pagavano in oro e i Romani, per esempio, importavano talmente tanto pepe che si rese necessario costruire appositi depositi denominati horrea pipearia). Erodoto scrive, riguardo al cinnamomo, ossia l'attuale cannella: «Tali uccelli lo porterebbero nei loro nidi fatti di fango su montagne scoscese e inaccessibili all'uomo. E così gli Arabi hanno escogitato una astuzia: tagliano a pezzi, grossi il più possibile, le carcasse di buoi, di asini o di altri animali da tiro morti, e li portano in quei luoghi, posandoli non lontano dai nidi; poi si allontanano. Gli uccelli scendono velocemente in volo sulle carni e le trasportano nei loro nidi, i quali però non essendo in grado di reggere un tale peso, si rompono e precipitano al suolo; gli uomini accorrono e provvedono a raccogliere il cinnamomo; il cinnamomo lì raccolto arriva poi in tutti gli altri paesi». Insomma, scenari da supereroi, di cui poi si scoprì lo status di fake news. La qual cosa fece sì che nel VII secolo Carlo Magno emani l'editto Capitulare de villis vel curtis imperii, contenente un copioso elenco di spezie che dovevano essere coltivate su terre imperiali e monasteri, dalla senape al papavero, dal coriandolo al cumino, dall'aneto alla nigella. All'incirca nell'anno 1000 assume rilievo la figura dello speziale, il farmacista ante litteram che utilizza spezie e non molecole spesso sintetiche come oggi. Il Medioevo sancisce la familiarizzazione di ogni categoria sociale con le spezie. Nei secoli successivi si profila un nuovo tipo di commercio speciale di stampo prettamente coloniale: nel XVII secolo si affermano le Compagnie di Inghilterra, Olanda e Francia, che le distribuiscono in esclusiva da India, Ceylon, Malesia, Molucche, Cina e Giappone. Successivamente, altri prodotti esotici - dallo zucchero al cacao, dal tè al caffè, interesseranno le rotte di importazione: le spezie, pian piano, si avviano al tramonto, si radicano a gruppi in ciascuna cucina connotandone il gusto (per esempio il curry in quella indiana, il basilico in quella italiana). Solo oggi, con l'avanzamento di una cucina globale e con l'interesse sempre più vigoroso per le proprietà anche curative del cibo, le spezie, tutte, anche le più esotiche, stanno tornando ad attirare la nostra attenzione. Le spezie, insomma, possono perdere temporaneamente, ma mai per sempre, il loro fascino. Le decantava il Cantico dei cantici nella Bibbia, che nel quarto poema fa dire allo sposo, rivolto alla sposa: «Giardino chiuso tu sei, / sorella mia, mia sposa, / sorgente chiusa, fontana sigillata. / I tuoi germogli sono un paradiso di melagrane, / con i frutti più squisiti, / alberi di cipro e nardo, / nardo e zafferano, cannella e cinnamòmo, / con ogni specie di alberi d'incenso, / mirra e àloe, / con tutti gli aromi migliori». Con un balzo temporale assai lungo, planiamo nel 1966: Paul Simon e Art Garfunkel intitolano Parsley, sage, rosemary and thyme il loro terzo album e così canta un verso ricorrente della prima traccia, Scarborough fair/canticle, una ballata inglese del XVI secolo la cui citazione ripetuta dell'elenco di spezie prezzemolo, salvia, rosmarino e timo è al centro di varie tesi. Quello delle spezie è un vero e proprio universo, difficile da conoscere fino in fondo. Nell'interessante libro Le spezie della salute in cucina, Natasha MacAller le organizza in base alle proprietà terapeutiche. Le spezie che aiutano le difese immunitarie sono la curcuma, il cumino, il cumino nero, i chiodi di garofano, il pimento, la scorza di agrumi, l'anice stellato, l'aglio, il fieno greco, la melagrana, il rosmarino, la senape e il wasabi. Alla curcuma, la gustosa spezia indiana immancabile nei piatti al curry, sono riconosciute proprietà antiossidanti, antisettiche, antinfiammatorie - in particolar modo nei confronti delle malattie antinfiammatorie croniche dell'intestino come morbo di Crohn e colite - e analgesiche. Ridurrebbe, poi, il colesterolo cattivo e i trigliceridi. Il cumino è invece utilizzato per combattere i batteri responsabili di intossicazioni alimentari, come cataplasma per la gola e gli organi digestivi infiammati, come aiuto antistress e per abbassare la glicemia. I chiodi di garofano sono antinfiammatori, antiossidanti, antisettici e anestetici locali, tanto che l'eugenolo è stato usato a lungo in odontoiatria come anestetico locale e antisettico. La scorza di agrumi, che tipicamente grattugiamo nelle ricette dolci e non soltanto, contiene più vitamina C del succo e della polpa, oltre a sostanze chimiche vegetali che potrebbero avere effetto protettivo nei confronti della formazione del cancro, come d-limonene, esperidina, naringina e auraptene. L'anice stellato - che non deve mai essere dato ai bambini - viene usato nella medicina tradizionale cinese contro infiammazioni, nervosismo, insonnia e dolore, in più possiede proprietà antibatteriche, antimicotiche, antiossidanti e, infine, antinfluenzali grazie all'acido scichimico. Le spezie disintossicanti sono la cannella, il rosmarino, l'origano, l'alloro, l'ibisco. Disintossicano nel senso che sostengono i naturali sistemi di detossificazione dell'organismo. La cannella sarebbe in grado di abbassare la glicemia e la pressione sanguigna e interviene sui recettori dell'insulina, così alterando il modo in cui il fegato metabolizza lo zucchero nel sangue. Contenendo però molta cumarina, assunta in grandi quantità (ma le spezie vanno assunte sempre in piccola quantità) può essere dannosa per il fegato. Del rosmarino mangiamo gli aghi - che poi sono le foglie - e il suo uso più sorprendente è sulla carne: «Quando la carne cotta alla griglia o ad alte temperature viene precedentemente marinata con del rosmarino si determina, oltre all'abbattimento della quantità di batteri, anche la riduzione del rischio di tumori all'intestino e al seno. Il rosmarino essiccato in polvere ha dato prova di diminuire sensibilmente (fino al 77%) la formazione di ammine eterocicliche (composti organici cancerogeni che si sviluppano quando la carne cuoce ad alte temperature) in hamburger di manzo cotti alla griglia a 200 gradi centigradi», spiega John La Puma. L'origano è un buon rimedio per le infezioni delle vie respiratorie e dell'apparato gastrointestinale: i suo oli volatili, timolo e carvacrolo, inibiscono la crescita di molti batteri, compreso l'Helicobacter pylori. L'alloro contiene, nelle sue foglie, enzimi che favoriscono la digestione e l'assimilazione di nutrienti e per questa ragione è consigliabile aggiungerlo ai piatti ad alto contenuto proteico difficili da digerire. Le spezie energetiche sono il pepe nero, il coriandolo, il cacao, la noce moscata, il tamarindo. Il pepe nero contiene piperina, potenziatore di biodisponibilità, che accresce le proprietà di altre spezie come ad esempio la curcuma. Inoltre, aumenta nell'organismo citochine antinfiammatorie, migliorando la salute polmonare, articolare e il dolore ed è un perfetto antimicrobico. La noce moscata è utile in caso di diarrea, nausea, dolori addominali e gas intestinali e le si riconoscono proprietà microbiche. Le spezie riscaldanti sono il peperoncino, lo zenzero, i semi di senape, il rafano, il wasabi. Il peperoncino aiuta nella cefalea a grappolo, nel dolore neuropatico diabetico e nella sindrome dell'intestino irritabile. Possiede anche capacità antiossidanti e sembra che le nazioni nelle quali si consuma molto peperoncino il tasso di malattie cardiovascolari sia più basso rispetto a quelle che ne fanno un uso minore. Lo zenzero è un antibatterico, ma gli sono riconosciuti anche effetti tonico-cerebrali e di sollievo dal dolore. Le spezie rigeneranti sono l'aglio, il cardamomo, la melagrana, il fieno greco, il timo. L'aglio tagliato o schiacciato rilascia allinasi, enzima che attiva l'effetto antinfiammatorio e antitumorale (riduce la formazione di nitrosammine, sostanze cancerogene). Le spezie rilassanti sono la salvia, il basilico, lo zafferano, la menta, la citronella. La salvia calma la mente, allevia il mal di gola e il raffreddore. Squisite le sue foglie colte fresche e fritte in pastella, ricordatevi che nel caso di utilizzo di salvia secca un cucchiaino equivale a un cucchiaio di salvia fresca. Il basilico, oltre a riempirci le narici di un profumo meraviglioso e così familiare, per noi italiani, è antimicrobico, antiossidante, cardioprotettivo. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/una-vita-pepata-saper-usare-le-spezie-fa-stare-meglio-e-aiuta-a-conoscere-la-nostra-storia-2622868945.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="zafferano-e-non-curcuma-per-preparare-un-autentico-risotto-alla-milanese" data-post-id="2622868945" data-published-at="1769542141" data-use-pagination="False"> Zafferano e non curcuma per preparare un autentico risotto alla milanese Lo zafferano è una spezia molto particolare. Si coglie il fiore, ma si utilizzano solo gli stimmi. Circa tre per fiore, per ottenere un chilo di zafferano puro ci vogliono circa 250.000 fili e oltre 4.000 metri quadrati di fiori. Si tratta di una spezia costosissima e infatti, se ci fate caso, in molti supermercati viene tenuto in scatolette protettive aperte in cassa dopo il pagamento (pare che sia una spezia rubatissima). Allo zafferano è riconosciuta una gamma molto ampia di proprietà: antidepressivo, ansiolitico, contrastante degli squilibri ormonali, antibatterico, anti radicali liberi e preventivo del tumore epatico. Molto ricco di potassio e vitamina C, viene considerato utile anche per abbassare la pressione sanguigna, facilitare la digestione e regolarizzare il battito cardiaco. Nella cucina italiana, lo zafferano è l'ingrediente re del risotto alla milanese. Gualtiero Marchesi, che lo ha nobilitato con la famosa foglia d'oro, lo faceva così, eliminando il midollo di bue che nella ricetta tradizionale è tassativo e lasciando solo l'aroma della cipolla. Per 4 persone, tostare 300 grammi di riso Carnaroli in poco burro per al massimo due minuti, bagnare con vino bianco, fare evaporare, versare un litro di brodo di carne leggero e 5 grammi di stimmi di zafferano e cuocere per circa 18 minuti. Salare, mantecare con 20 grammi di parmigiano e il burro acido preparato mentre cuoceva il riso e che si fa così: si fa soffriggere in poco burro una cipolla tritata per qualche minuto, si bagna con vino e si fa evaporare. Si filtra e si aggiungere il burro in pomata, mescolando delicatamente con una frusta. Alla fine, il tutto si stende a velo sui piatti e si completa con una foglia d'oro alimentare al centro di ogni porzione. Alcuni usano sostituire lo zafferano del risotto alla milanese tradizionale con la curcuma - magari fresca, grattugiata - che dà più o meno lo stesso colore ma un sapore diverso. Tuttavia, per quanto gustoso, il risotto alla milanese con la curcuma semplicemente non è il risotto alla milanese. Le piccole leggi dello zafferano da tenere a mente sono le seguenti. Sono preferibili i pistilli di zafferano intero, alla polvere: più è caldo il suo tono giallo-arancio, migliore sarà la crocina contenuta. Un trucchetto per scoprire se si tratta di vero zafferano (lo zafferano è anche una spezia assai sofisticata, diffidate di quello che costa troppo poco) è mettere i pistilli in acqua calda: si devono dissolvere. Tenetelo anche al riparo dalla luce.
Ecco #DimmiLaVerità del 27 gennaio 2026. Stefania Bardelli, leader del Movimento Angelo Vidoletti, ci racconta perché è rimasta delusa da Roberto Vannacci e la sua opinione sulla sicurezza in Italia.