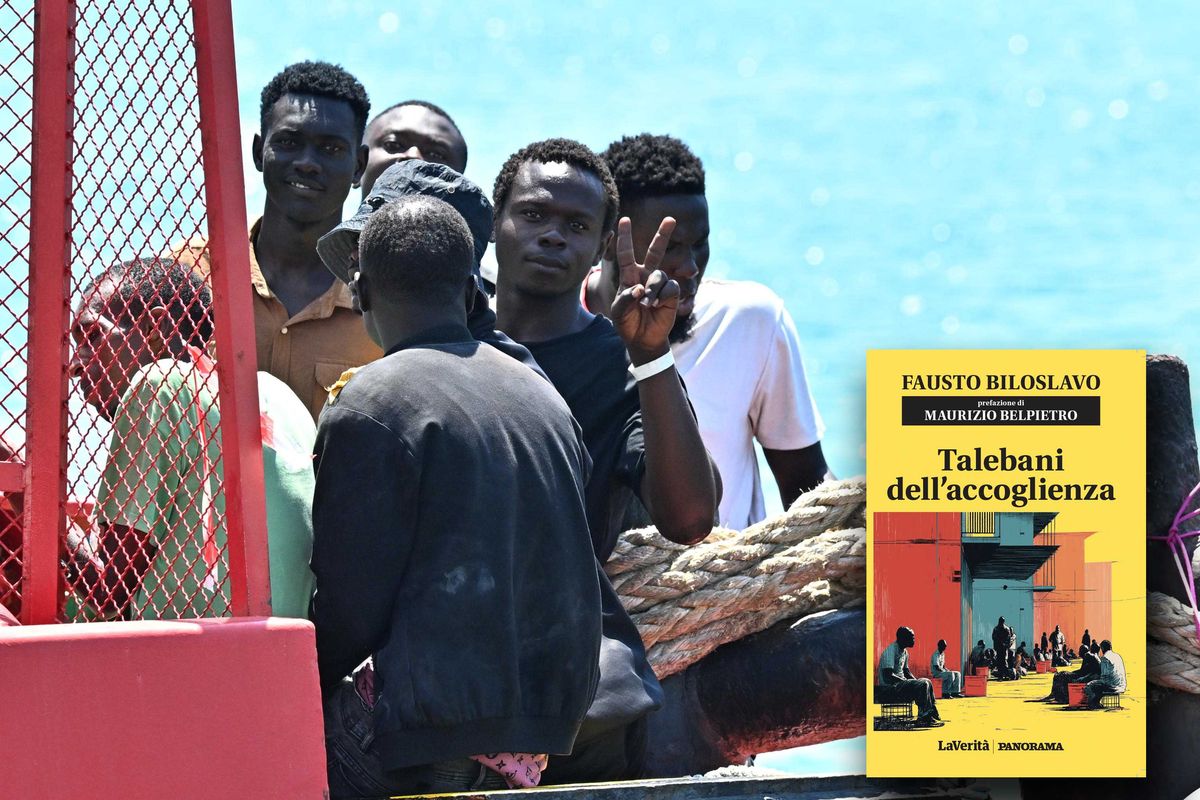2023-09-16
Regno d’Italia «battezzato» con lo stracchino
Vittorio Emanuele lo volle alla cena di gala con i diplomatici europei. Anche il grande nemico Radetzky lo pretendeva sempre quando aveva ospiti. Più nutriente dei legumi e meno costoso di carne e pesce, questo formaggio conquistò anche l’alta società.Il rapporto tra la Bergamasca e la sua tradizione casearia è un mosaico di storie che si sono incrociate nel tempo per giungere a noi più attuali che mai. La via Priula, ad esempio, è stata una sorta di autostrada (a dimensione di carretti a due ruote) realizzata per la transumanza dei bergamini e le loro greggi. Voluta dall’allora podestà veneziano Alvise Priuli, venne realizzata in poco meno di due anni con innovazioni tecnologiche e architettoniche all’avanguardia per quel tempo e collegava la pianura, attraverso la Val Brembana, le altre valli laterali, fino al passo di San Marco e da lì poi alla Valtellina e i mercati del Nord.Fu lungo questi saliscendi che si svilupparono stazioni di sosta, con le relative frasche, divenute poi osterie. In tal modo i bergamini arrivavano più agevolmente ai pascoli montani, dove pagavano alle municipalità locali il dazio della «gratarola», detto così perché l’uso dei pascoli era riservato a questi ungulati (bovini, ovini) che, spesso, grattavano il terreno per procurarsi il necessario. Entrate fiscali importantissime viste le poche risorse a disposizione di quelle comunità.Nella vicina Valle Imagna è stata ricreata la «Strada dello stracchino e della pietra», proprio per ricordare le fasi salienti della sua lavorazione. Con la pietra erano realizzati i calec, muretti a secco alti circa un metro per la sosta delle greggi. Le grotte sparse lungo le pareti della montagna diventavano piccole enclave per la conservazione del formaggio lavorato in alpeggio. Bergamini dalle mille risorse, «tenaci e perspicaci», come li aveva ben descritti Luigi Cattaneo, tanto che, oltre ai formaggi, lavorando con acume il letame ovino insieme alla terra e la paglia, preparavano il salnitro, una delle basi per ottenere poi la polvere da sparo, sempre utile se abbinata agli archibugi preparati nella vicina Val Trompia. La bruna alpina era la razza più adatta, una selezione naturale formatasi nel tempo con «l’unghia giusta per monticare» (ecco spiegato il dazio della «gratarola»), dal muso più grande, visto che doveva far provvista da sé al pascolo e respirare appieno l’aria di montagna. Animale in costante esercizio motorio e non pigramente parcheggiata nella stalla, poteva offrire, al termine della sua missione lattofora, carni più saporite. Un rapporto molto empatico tra uomo e animale. La mandria era guidata dalla «batidura», la vacca leader, dotata di un campanaccio di maggiori dimensioni, la «cioca», utile richiamo per tutte le sue colleghe.La mungitura avveniva sul fare dell’alba e a metà pomeriggio con una dedizione molto attenta, tanto che il latte «doveva uscire a guisa di nastro» e «mungere a mano riscalda le mani e il cuore», come ha confessato un malgaro di lunga militanza. Un antico rito che è stato tenuto vivo da varie iniziative tra cui il Campionato del mondo di mungitura a mano, svolto a Lenno per qualche edizione. Poche regole ma chiare. Due minuti a mano libera, secchiello in resta. La bruna alpina stava oramai diventando un ricordo del passato quando, alcuni anni fa, ha trovato chi ha deciso di riportarla all’onore che merita, attraverso un’attenta ricerca genealogica, ovvero i brembani Nicolò Quarteroni e Ignazio Carrara, assieme al valtellinese Alfio Sassella. La filiera genetica è garantita da un singolo toro presente in ogni azienda. Il tutto per raggiungere quell’equilibrio ideale che si era mantenuto per secoli così da ottenere prodotti a qualità garantita, stracchino in primis. Un tempo valevano dedizione ed esperienza. I bergamini preparavano un prodotto freschissimo che poi offrivano ai commercianti dedicati, i «marù», che si recavano in alpeggio a cadenze regolari, spesso settimanali. Le forme valutate a occhio e poi soppesate con una mano, battendole con l’altra per capire se c’erano cavità bollose, che ne avrebbero minato la qualità.Manualità ed esperienza erano un ulteriore valore aggiunto nella fase di affinamento. I casari ispezionavano periodicamente le varie forme ma senza l’uso del martelletto, come ad esempio gli affinatori del grana, in pianura, ma con una palpazione attenta dei polpastrelli per rilevare alterazioni della consistenza. Una sorta di clinici caseari, ma senza camice bianco e stetoscopio d’ordinanza. Lo stracchino era il motore dell’economia locale, sotto vari aspetti. Per i commercianti era vantaggioso per la breve stagionatura e il forte consumo legato a una richiesta diffusa, garantendo così un’ottima rotazione del capitale. Ideale nel contesto dell’economia familiare, abbordabile anche per le classi più umili. Il grasso e le proteine dello stracchino fornivano più energia dei semplici legumi e costava meno di quella ottenuta dal consumo di carne o pesce, tra l’altro con minori problemi di conservabilità in un’epoca in cui non esistevano le moderne tecnologie.A metà Ottocento, in Val Brembana, esercitava un medico condotto illuminato, Filippo Lussana. Fu lui a raccomandare la promozione dell’uso dello stracchino tra i suoi colleghi in quanto «adatto a sostenere stili di vita ed appetiti robusti», così da compensare le carenze nutrizionali legate alle scarse risorse disponibili. Non era certo un caso che, quando le valligiane andavano a «far stagione» come mondine nelle risaie della Bassa, portassero con sé robuste scorte di stracchino, così come, per il suo costo abbordabile e i benefici che portava, era sempre presente nelle cucine degli ospedali e delle case di ricovero. Lo stracchino aveva un profilo più riservato in confronto con la sua prestigiosa discendenza, in primis gorgonzola e taleggio, via via sempre più apprezzati e richiesti dalla buona società dell’epoca. Anche se, nel frattempo, di quarti di nobiltà golosa il nostro stracchino ne aveva raccolti, a tavole prestigiose.Il feldmaresciallo Josef Radetzky, governatore austro ungarico del Ducato di Milano, si raccomandava al suo attendente di non farlo mai mancare a tavola con gli ospiti. Filippo Facci, nella biografia dedicata a Gioacchino Rossini, ricorda come questi «ritiratosi dalle scene a trentasette anni, passò il resto della vita a discutere di stracchini e bistecche» facendosi spedire a Parigi, dal suo fidato fornitore, il marchese Antonio Busca, generose partite di stracchino e gorgonzola. Il bergamasco Gaetano Donizzetti, impegnato nelle tournée all’estero, raccomandava al segretario di inviargli «una cassa con pochi strumenti musicali per lasciar spazio a gorgonzola, stracchini e qualche salame e salsiccia».Quando i Savoia si confrontarono con le diplomazie europee per la decisiva legittimazione del nascente Regno d’Italia, alla cena di gala ognuno offrì il meglio del suo territorio. Gruyère dagli svizzeri, Stilton dagli inglesi e, naturalmente, stracchino da Vittorio Emanuele. Svariato anche il ricettario, al di là del consueto carrello dei formaggi. Immancabile nella polenta taragna, messo a mantecare con i cereali di montagna, così come un grande classico lo «strachì parat», sciolto nel burro e poi strapazzato assieme alle uova.Da provare, solo a leggerne la ricetta, lo schisol. Si appallottolava la polenta avanzata e vi si schiacciava dentro una cucchiaiata di stracchino. Il tutto finiva sotto la brace fino a che non si formava una crosticina dorata e croccante. Una sorta di arancino orobico, custodito golosamente per pranzo nella saccoccia di contadini e bosciaioli. A Cremona, la sera della Vigilia di Natale, ecco lo «strachì rustit», fritto nel burro con mostarda. Una sintesi ben descritta da Irene Foresti: «Ai fornelli lo stracchino rivela ancora una volta tutta la complessità che si cela dietro la comune immagine di angelica semplicità, riscattandosi autonomamente dall’identità pressoché anonima che il mercato attuale gli ha purtroppo cucito addosso».
(Totaleu)
Lo ha detto il Presidente di Unipol Carlo Cimbri in occasione del convegno «Il contributo delle assicurazioni alla competitività europea», che si è svolto al Parlamento Ue.
(Arma dei Carabinieri)
L’arresto in flagranza differita di un 57enne di Acerra eseguito a Caivano è frutto del lavoro coordinato dei Carabinieri della Regione Forestale Campania e del Comando Provinciale partenopeo. Un’attività che muove i suoi passi dal decreto recentemente entrato in vigore in materia di illeciti ambientali e dagli schermi collegati ad una moderna «control room», una struttura che accentra segnalazioni, flussi informativi e richieste di intervento nelle province napoletana e casertana con un comune denominatore: la lotta all’inquinamento.
L’integrazione della nuova normativa a questo sistema di coordinamento consente di individuare e monitorare situazioni a rischio, consentendo una mobilitazione immediata delle pattuglie sul territorio.
Le immagini di un sistema di videosorveglianza dedicato hanno mostrato ai militari del NIPAAF (Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale) e della stazione di Caivano un soggetto intento ad incendiare 25 sacchi di scarti tessili. Quintali di rifiuti, la cui combustione ha generato una nube di fumo che ha avvolto anche alcune abitazioni vicine.
Secondo quanto documentato in poche ore, il 57enne avrebbe alimentato le fiamme e poi si sarebbe allontanato a bordo del suo suv. Le pattuglie intervenute, collegate con la «control room», hanno ricostruito il tragitto del veicolo e ne hanno identificato il proprietario. L’uomo è stato rintracciato qualche ora dopo la registrazione delle immagini e arrestato in flagranza differita nella sua abitazione. E’ ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.
L’intera operazione costituisce un esempio concreto dell’efficacia della nuova normativa - che supera i limiti della tradizionale flagranza - e del lavoro sinergico e strutturato dell’Arma dei Carabinieri.
Continua a leggereRiduci