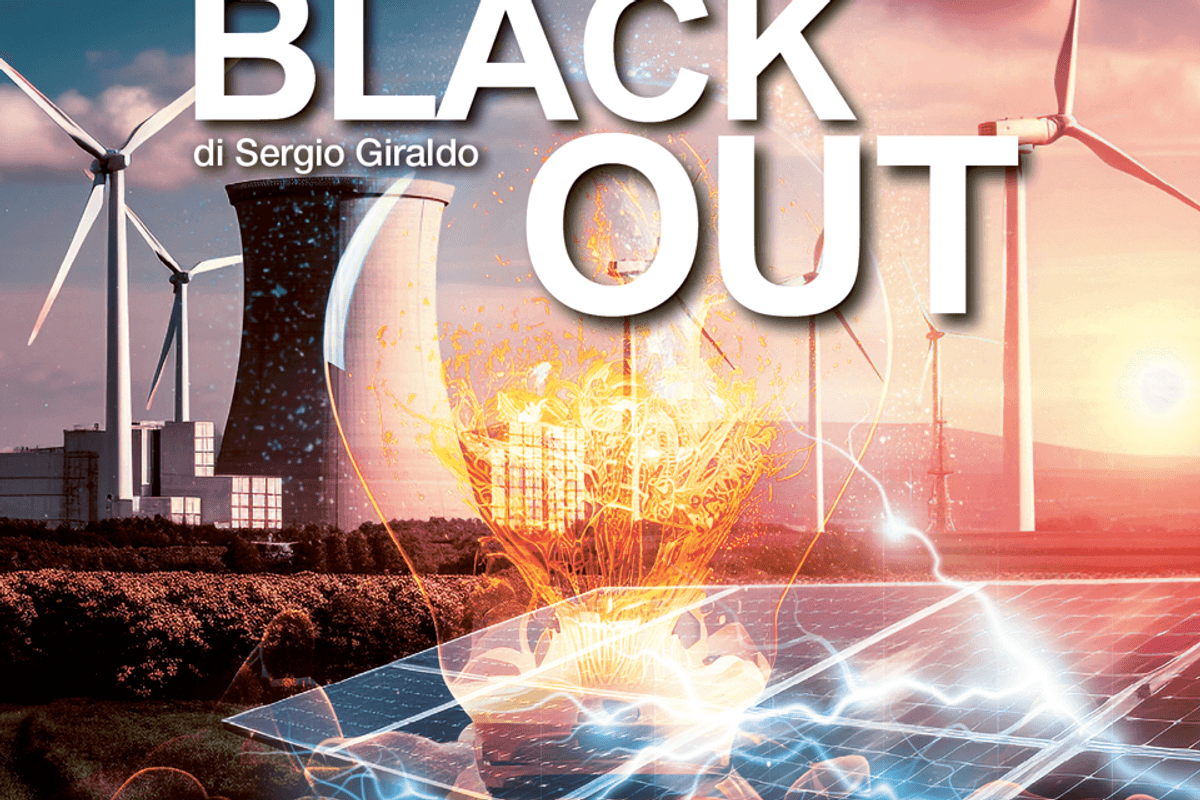Nel dubbio, in favore della vita. È la lezione che si deve trarre dall’ultima sentenza della Corte d’Appello di Trieste sul suicidio assistito. La quale, ribaltando il verdetto di primo grado, ha condannato i figli di un ottantaquattrenne a restituire il risarcimento che avevano ottenuto dall’azienda sanitaria, per il suo rifiuto di staccare i tubicini dell’alimentazione artificiale all’uomo.
Nel 2018, il povero signor de’ Manzano viene colpito da un ictus: smette di parlare, di muoversi, non riconosce più i familiari, soffre di disfagia ed è costretto a nutrirsi con un sondino naso-gastrico. I figli pensano sia meglio porre fine alle sue sofferenze, ma la Stroke unit dell’ospedale di Cattinara nega la procedura e pure il permesso al trasferimento in un’altra struttura, disponibile ad accompagnare il paziente verso la «dolce morte». Così, il 10 gennaio 2019, l’avvocatessa Giovanna Augusta de’ Manzano, figlia del malato, si fa nominare amministratrice di sostegno e, con l’intervento del giudice tutelare, ottiene lo spostamento del padre nella clinica Salus, dove l’alimentazione forzata viene sospesa e il babbo muore. La donna decide di citare in giudizio l’Asugi triestina. E in tribunale, ottiene 25.000 euro di risarcimento. Il 5 gennaio di quest’anno, però, il secondo grado di giudizio rovescia il pronunciamento e obbliga i figli di de’ Manzano a restituire la somma, nonché a saldare le spese legali, per un totale di 55.000 euro.
L’avvocatessa - si legge negli atti - sosteneva che il papà reagisse alle cure «scuotendo il capo, strappandosi la flebo e il sondino naso-gastrico». Gesti interpretati alla stregua di una richiesta di farla finita. I magistrati d’Appello non ne sono sicuri: nella sentenza, anzi, scrivono che nel ricorso per la nomina ad amministratrice di sostegno, presentato dalla de’ Manzano, «non veniva esposta nessuna narrazione della volontà del paziente». In sostanza, non era stata «resa esplicita l’intenzione di sospendere i trattamenti sanitari in corso». Le perplessità dei medici di Cattinara, quindi, erano «tutt’altro che pretestuose», dal momento che «né il primo ricorso né la nomina» a tutrice contenevano elementi che permettessero di accertare i desideri del malato. Un elemento cruciale, tanto che i giudici fanno riferimento al dettato della Corte costituzionale, laddove essa esclude «che il conferimento della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario rechi con sé, anche e necessariamente, il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita».
La Consulta, nonostante le varie aperture, a cominciare dal caso di dj Fabo, ha comunque ribadito - basta leggere la sentenza del luglio 2024 - che in Italia non esiste il diritto di morire. Nel recente verdetto, con cui ha in parte bocciato la legge della Regione Toscana, essa ha confermato che, in ottemperanza alla legge sul biotestamento, la richiesta di suicidio assistito non può essere formulata da un «delegato» del paziente. Allo stesso modo, la Corte ha cassato la disposizione della giunta Giani sugli «stringenti tempi per la verifica dei requisiti di accesso» alla procedura, ricordando che ai medici va garantita «la possibilità di svolgere tutti quegli approfondimenti clinici e diagnostici» ritenuti «appropriati». Il margine di autonomia professionale dei dottori, insomma, non deve soccombere sistematicamente alle istanze dei malati né - soprattutto - alle pressioni dei loro familiari. Da questo punto di vista, il verdetto di Trieste ridimensiona le ambizioni degli attivisti radicali, i quali da mesi si battono affinché si arrivi al suicidio «express».
Ma c’è di più. Tra i motivi che spiegavano le sollecitazioni a sopperire al vuoto normativo, intervenendo a livello parlamentare, o almeno regionale, c’era il timore delle Asl di finire sommerse dalle richieste di indennizzo dei parenti dei pazienti, adirati per eventuali dinieghi o tempistiche di risposta considerate incongrue. La Corte d’Appello giuliana - il cui verdetto sarà impugnato in Cassazione dai legali della de’ Manzano - potrebbe aver stabilito un precedente giurisprudenziale, indebolendo una delle giustificazioni per legiferare.
In Senato, il testo è arenato nelle secche dei dissidi sul coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale: il centrodestra sta cercando in tutti i modi di evitarlo, consapevole che in ballo c’è la natura stessa della professione medica e del giuramento di Ippocrate. «Non somministrerò a nessuno, neppure se richiesto», recitava la formula classica della deontologia, «alcun farmaco mortale e non prenderò mai un’iniziativa del genere; e neppure fornirò mai a una donna un mezzo per procurare l’aborto». Ecco. Certi argini sono già crollati.