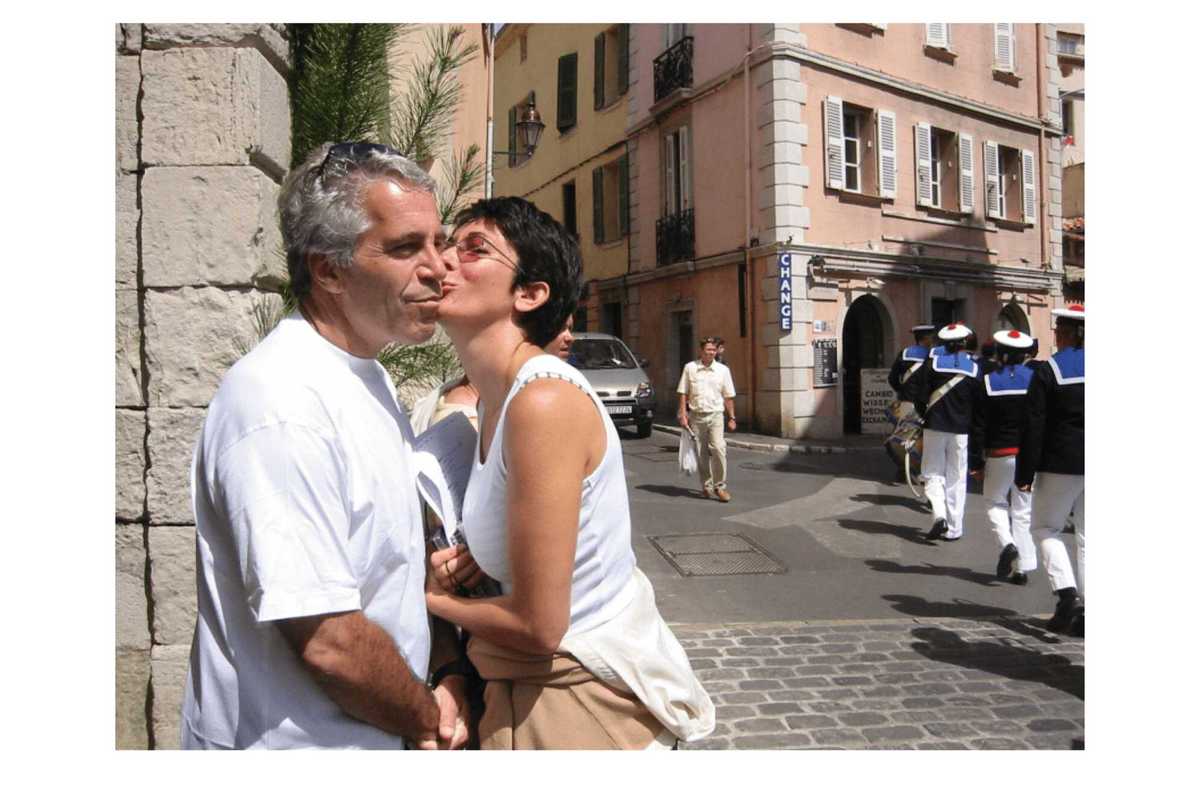Il ritornello del conflitto inevitabile nasconde mere ragioni industriali

In occasione di una visita a una base militare, il 18 marzo scorso, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha affermato: «Il nostro Paese e il nostro continente devono continuare a difendersi, equipaggiarsi e prepararsi se vogliamo evitare la guerra»; guerra che - ça va sans dire - la Russia, altrimenti, senza dubbio scatenerebbe una volta conclusa a suo favore (con la complicità, dopo la svolta operata da Donald Trump, degli ormai quasi alleati Stati Uniti) la partita in corso con l’Ucraina. Visto che ha parlato di «nostro continente» sarebbe però, forse, il caso che qualcuno rammentasse a «monsieur le Président» non solo che, secondo le comuni nozioni di geografia, il continente europeo comprende anche la Russia ma anche (e soprattutto) che tra i suoi predecessori, oltre a Napoleone Bonaparte, al quale egli vuole ispirarsi, vi è stato anche un certo Charles de Gaulle, per il quale era tutta Europa quella che va «dall’Atlantico agli Urali». E ciò diceva non certo per sfoggio di conoscenze geografiche ma per esprimere un concetto basilare della sua visione politica, secondo cui - ferma restando la contrapposizione tra il sistema politico-economico dell’Occidente liberal-democratico e quello della Russia sovietica, come pure la necessità di mantenere, nella Francia e nei suoi alleati europei, un’adeguata forza militare dissuasiva da eventuali tentazioni aggressive di qualunque provenienza - doveva però rifiutarsi l’idea di una permanente e irrimediabile conflittualità tra l’Europa occidentale, alleata degli Usa, e quella orientale, rappresentata dalla Russia e dai Paesi a essa legati nel Patto di Varsavia. Quella che doveva prevalere, invece, era l’idea - peraltro sostanzialmente condivisa anche dai governanti di tutti gli altri Paesi europei aderenti alla Nato - che con l’Europa orientale, Russia compresa, dovesse instaurarsi una «convivenza pacifica», nella ritrovata consapevolezza dei comuni legami di civiltà.
Completamente diversa appare, invece, la visione non del solo Macron, ma anche di gran parte degli altri governanti dei Paesi dell’Ue, come pure della Commissione europea, a partire dalla sua presidente, Ursula von der Leyen, e della maggioranza dell’Europarlamento. Secondo tale visione, infatti, la Russia sarebbe da riguardarsi, per sua natura - almeno fino a che non intervenisse un radicale mutamento del suo attuale regime politico - come nemica dell’Europa e desiderosa soltanto di sottoporla al suo dominio. Ciò escluderebbe, quindi, la possibilità di una qualsiasi «pacifica convivenza» con essa ma esigerebbe, piuttosto, un sempre maggiore rafforzamento militare, in funzione dissuasiva, della componente europea della Nato, soprattutto in considerazione - si sostiene - della sopravvenuta inaffidabilità, sotto l’attuale presidenza Trump, della garanzia di protezione finora offerta dagli Usa.
Non occorre, tuttavia, una particolare competenza in materia geopolitica o militare per rendersi conto, sulla base della logica più elementare e di nozioni di pubblico dominio, della totale infondatezza di tale ragionamento. Ammesso, infatti, e non concesso che la Russia nutra effettivamente i propositi di aggressione che le vengono attribuiti (e dei quali non ci sono né prove né indizi di sorta) i casi sono due: o si esclude l’affidabilità della garanzia americana, e allora è del tutto illusorio ritenere che un pur massiccio riarmo convenzionale dei singoli Paesi dell’Ue o anche solo di quest’ultima (cosa che appare, peraltro, totalmente priva di fattibilità) possa assumere un’effettiva efficacia deterrente nei confronti di una Russia che dispone di un arsenale nucleare dieci volte più potente di quello, congiunto, della Francia e della Gran Bretagna e potrebbe servirsene senza perciò esporsi - date le premesse - a una massiccia rappresaglia quale potrebbe provenire solo dagli Usa, essendo questi ultimi gli unici a essere dotati di un arsenale nucleare equiparabile al suo; oppure si ritiene tuttora affidabile la garanzia americana, e allora non può più prospettarsi come necessario un riarmo europeo che sopperisca alla sua assenza. E che su quella garanzia si possa, in effetti, continuare a far conto, nonostante le estemporanee uscite verbali di Trump circa la sua subordinazione a un maggior contributo economico da parte dei Paesi europei, appare tutt’altro che irragionevole, almeno fino a quando, in assenza di un formale ritiro degli Usa dalla Nato (cosa, peraltro, mai seriamente prospettata) resti perciò operante l’incondizionato obbligo di intervento, da parte loro, ai sensi dell’art. 5 del trattato, in caso di attacco armato della Russia a uno degli alleati europei; obbligo al quale difficilmente potrebbero avere la faccia di sottrarsi, salva, forse, la sola eventualità che l’attacco fosse stato sconsideratamente provocato dallo stesso Paese che l’ha poi subito.
Nell’uno e nell’altro caso, quindi, l’Ue e i singoli Paesi che ne fanno parte, lungi dal mostrare «sgomento» - come incredibilmente affermato qualche giorno fa dal Parlamento europeo - a fronte delle attuali prospettive di riavvicinamento tra Russia e Usa, dovrebbero invece associarvisi, nell’evidente interesse di quella stessa pace che mostrano, invece, di voler perseguire facendo leva, assurdamente, sull’efficacia deterrente di una forza che non hanno e che mai potranno avere nella misura che sarebbe necessaria. Il che altra spiegazione non può avere se non quella che i governanti europei che predicano la necessità del riarmo lo facciano per finalità che, con la pace e, quindi, con la sicurezza e il benessere dei loro popoli, non hanno, in realtà, nulla a che vedere ma molto hanno, invece, a che vedere con un’altra esigenza da loro avvertita: quella, cioè, di mascherare in qualche modo, forzando al massimo l’industria degli armamenti, sotto pretesto di un fantomatico pericolo di futuri attacchi da parte della Russia, il disastro che essi stessi hanno prodotto, con le sciagurate politiche di transizione «green», in altri settori industriali, con particolare riguardo a quello automobilistico. Se così è, rimane, quindi, solo da sperare nel vecchio detto secondo cui è possibile ingannare alcuni per sempre e tutti per un certo tempo, ma non è possibile ingannare tutti per sempre. E che, in effetti, la regola funzioni s’intravede, per fortuna, qualche segno.