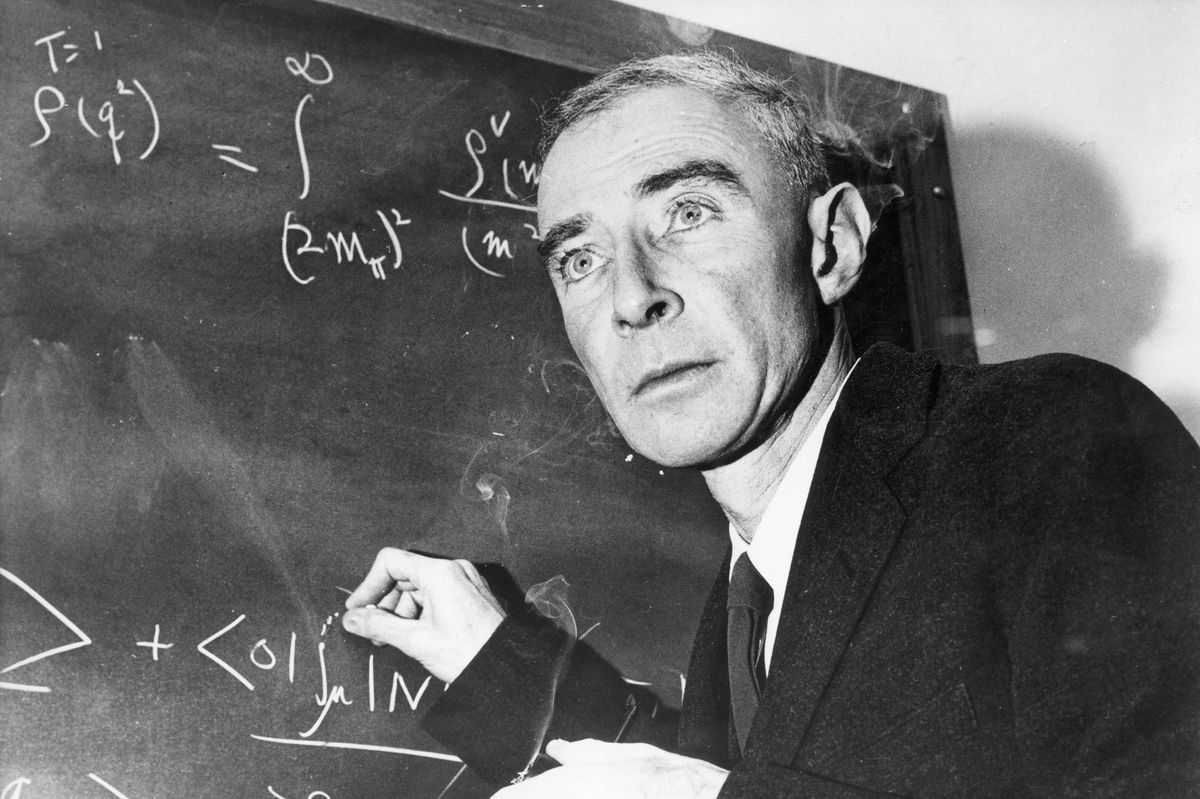Passato il rito del brindisi, il Capodanno continua a parlare attraverso il cibo. Nei simboli che si portano in tavola e nella capacità, tutta italiana, di non sprecare nulla: frutti augurali, piatti carichi di significati antichi e una cucina del recupero che affonda le radici nell’antropologia domestica e nella tradizione contadina, dove ogni avanzo diventa risorsa.
Passata la festa si recupera tanto

iStock
Portiamoci avanti con il lavoro. Un elemento che è stato trascurato nella lettura assai superficiale e molto enfatica che si è data del riconoscimento alla cucina italiana (?)quale patrimonio immateriale dell’umanità da parte dell’Unesco è quello antropologico e tra le “abitudini” alimentari degli italiani un tempo la parsimonia, il riuso, il non spreco erano prerogative essenziali di una brava massaia o di un bravo domestico. Del resto leggendo l’Artusi, ma prima ancora il Nebbia, emergono qua e là citazioni di ricette di riuso. Non si vede perché ai giorni nostri con un po’ d’arguzia non si possa ripercorrere l’appetitosa strada che conduce alla meta del non si butta via niente. Ecco qui alcune ricettine facili facili che danno però soddisfazione.
PASTICCIO DI TORTELLINI
Ingredienti – 800 gr di tortellini avanzati, due dischi di pasta brisè confezionati, 250 gr di burro, 4 cucchiai di farina, 4 cucchiai di Parmigiano Reggiano o altro formaggio da grattugia, 200 ml di latte, un bicchiere di vino bianco o rosso dipende cosa avete 300 gr di macinato di manzo magro di ottima qualità, due salsicce, 100 ml di olio extravergine di oliva, 450 gr di passata di pomodoro, un cucchiaio abbondante di concentrato di pomodoro, una carota, una cipolla di generose dimensioni, una costa di sedano, un uovo, sale, pepe e noce moscata qb.
Procedimento – Preparate un ragù veloce: in una pentolina mettete a stufare in 100 gr di burro e 100 ml di olio extravergine di oliva le verdure battute finemente al coltello, aggiustate di sale, di pepe e grattugiate ampiamente noce moscata, ora fate saltare le carni nel grasso e nel trito di verdure e rosolatele per qualche minuto a fiamma vivace, sfumate col vino e quando l’alcol è evaporato abbassate la fiamma aggiungete il concentrato di pomodoro disciolto appena in acqua, fate tirare e poi aggiungete di nuovo la passata di pomodoro Abbassate la fiamma incoperchiate e lasciate sobbollire. Ora preparate la besciamella. Fate fondere in un pentolino il burro residuo aggiungete la farina e girando energicamente con la frusta fate il roux, ora versate a filo il latte sempre girando con la frusta, aggiustate di pepe, sale noce moscata e in ultimo il formaggio. Sempre girando con la frusta fate addensare. In una ciotola condite i tortellini con il ragù (badate che sia abbastanza asciutto) e la besciamella. Disponete in una tortiera il primo disco di pasta brisè, versateci il composto di tortellini, ricoprite con il secondo disco di pasta sigillando i bordi ma facendo con una forchetta qualche buchetto qua e là. Pennellate la superficie con l’uovo sbattuto. Andate in forno per 20 minuti a 190 gradi. Sarà un piatto unico gustosissimo .
PAPPA AL POMODORO
Ingredienti – 800 gr di pane raffermo, 400 gr di passata di pomodoro, due cucchiai di concentrato di pomodoro, 4 cucchiai di Parmigiano Reggiano, Grana Padano o altro formaggio da grattugia, due cipolle rosse, una carota, una costa di sedano, chiodi di garofano, se ce l’avete una crosta di Parmigiano Reggiano, due spicchi d’aglio, 4 foglie di salvia, un peperoncino, 80 ml di olio extravergine di oliva, alcune foglie di basilico, sale e pepe qb.
Procedimento – Fate con una cipolla steccata con i chiodi di garofano, la cipolla, la carota, il sedano e l’eventuale crosta di formaggio ben raschiata un brodo vegetale. Sminuzzate il pane e in un tegame fate imbiondire in extravergine di oliva, aglio, salvia e peperoncino. Quando l’aglio ha preso colore eliminatelo insieme alla salvia e al peperoncino, tostate nell’olio il pane sminuzzato, poi allungate col brodo il concentrato di pomodoro, fate assorbire dal pane e aggiungete la passata. Allungate ancora col brodo e girate di quando in quando: la pappa deve risultare cremosa, ma non brodosa. Quando vedete che il composta ha assunto una consistenza omogenea aggiustate di sale e pepe e servite con un giro dii olio extravergine a crudo, le foglie di basilico e se piace il formagio grattugiato.
OLIVE FRITTE DI PESCE
Ingredienti – 40 olive denocciolate meglio se Tenera Ascolana in salamoia, 400 gr di gallinella, o nasello, o rana pescatrice chevi è avanzato dai cenoni, 3 uova, 150 gr di farina, 300 gr di pangrattato, un litro di olio per friggere, un mazzetto di prezzemolo, sale e pepe qb.
Procedimento – Battete al coltello il pesce fino ad ottenere una tartare finissima. Tritate finemente il prezzemolo e unitelo al pesce. Ora con un coltellino aprite per il lungo da un lato solo a portafoglio le olive e riempitele una a una con un po’ di pesce. Premete in modo che il pesce aderisca bene alla drupa. Sbattette le uova ben bene. Infarinate le olive, passatele nell’uovo, poi nel pangrattato ancora nell’uovo e ancora nel pangrattato. Nell’ultimo passaggio premete bene le olive e roteandole nei palmi delle mani date loro una forma quasi sferica in modo che siano ben compatte. Fate scaldare bene l’olio e quando sarà a temperatura, friggete le olive poche alle volta. Adagiatele in un contenitore con carta da cucina o assorbente in modo che perdano tutto l’olio di frittura poi salate e servite.
POLPETTE DI LENTICCHIE
Ingredienti – 300 gr di lenticchie lessate, 120 gr di formaggi duri misti macinati, 100 gr di pangrattato, un ciuffo abbondante di prezzemolo, uno o due spicchi d’aglio, 6 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale e pepe qb.
Procedimento – Frullate grossolanamente le lenticchie avendo cura che siano quanto più asciutte possibile. In una ciotola aggiungete alle lenticchie frullate il formaggio, gli spicchi d’aglio spremuti, il prezzemolo abbondante e tritato finemente, metà del pane grattato aggiustando di sale e pepe. Con le mani formate tante palline non troppo grosse e ripassatele una ad una nel pangrattato. Scaldate l’olio extravergine in una padella e cuocete le “polticchie” fin quando non fanno una bella crosticina dorata avendo cura di rigirarle con grande attenzione in modo che non si spacchino. Servitele. Potete anche cuocerle al forno sistemandole su di una placca con carta-forno a 180 gradi per circa un quarto d’oro oppure friggerle. Friggetele però poche per volta e in olio ben caldo per evitare che si sfaldino.
POLPETTONE FARCITO
Ingredienti – 250 gr di cotechino o zampone, 350 gr di macinato magro di manzo, un uovo, 500 gr di spinaci, 150 gr di formaggio a vostra scelta (dal Montasio alla Scamorza), 200 gr di pane raffermo, 5 o 6 cucchiai di Parmigiano Reggiano o Grana Padano grattugiato, 6 cucchiai di pangrattato, un mazzetto di prezzemolo, olio extravergine, sale e pepe qb.
Procedimento – Mettete a lessare in pochissima acqua non salta gli spinaci. Scolateli, strizzateli bene e volendo usate l’acqua di cottura per ammollare il pane. Passate al mixer il cotechino o lo zampone con il prezzemolo sì da ottenere una sorta di granella. Mette in ammollo il pane. In una ciotola rinite il macinato di manzo, il macinato di cotechino, il pane ben strizzato, il formaggio grattugiato e lavorate con le mani impastando. Separate la chiara dal rosso dell’uovo e utilizzate il rosso per completare l’impasto. Solo se l’impasto risultasse troppo sgranato aggiungete anche la chiara. In una teglia da forno ricoperta di carta-forno stendete l’impasto delle carni e adagiatevi sopra gli spinaci e poi il formaggio fatto a tocchetti. Aggiustate di sale e di pepe e formate il polpettone aiutandovi con la carta-forno per formare il cilindro. Ora ricoprite il polpettone di pangrattato e adagiatelo nella teglia sempre ricoperta di carta-forno, condite con olio extravergine di oliva e andate in forno a 200 gradi per circa mezz’ora.
FRANCESINA O LESSO (BOLLITO) RIFATTO
Ingredienti – 400 gr di lesso o bollito misto, 400 gr di cipolle, due o tre foglie di alloro, 200 gr di polpa di pomodoro e 2 cucchiai di concentrato di pomodoro, 100 ml di olio extravergine di oliva, uno spicchio d’aglio, sale e pepe qb.
Procedimento – In un tegame fate imbiondire l’aglio con le foglie di alloro nell’olio extravergine di oliva. Quando l’aglio ha preso colore eliminatelo. Tagliate non troppo sottilmente le cipolle e fatele ammorbidire nel tegame. Sminuzzate grossolanamente la carne e fatela rosolare nell’olio con le cipolle, aggiungete il concentrato di pomodoro allungato nell’acqua, fate assorbire e ora aggiungete la polpa di pomodoro (o se volete i pelati appena frullati). Se serve allungate con un paio di mestoli di acqua bollente. Cuocete per una decina di minuti, eliminate le foglie di alloro e servite aggiustando di sale e pepe.
POLPETTE DI PESCE E PATATE
Ingredienti – 400 gr di patate, 400 gr di pesce misto compresi molluschi se ne avete, 3 uova, 100 gr di pangrattato e 100 gr di farina 0, un litro di olio di semi di girasole alto-oleico (o altro olio per friggere), un mazzo di prezzemolo, uno spicchio d’aglio, sale e pepe qb.
Procedimento – Lessate le patate con la buccia, poi appena cotte schiacciatele col passapatate facendole cadere in una terrina. Frullate grossolanamente il pesce avendo cura di eliminare le lische, unite alle patate un uovo, il prezzemolo tritato finemente, l’aglio schiacciato con l’apposito attrezzo in modo da prendere solo la polpa oppure tritatelo finissimamente e il pesce frullato. Aggiustate se serve di sale e di pepe. Amalgamante bene poi con le mani formate tante palline. Sbattete le uova rimaste. Passate le palline prima nella farina poi nell’uovo, nel pangrattato, ancora nell’uovo e di nuovo nel pangrattato. Scaldate l’olio e friggete le polpette un po’ alla volta.
FRITTATA DI PASTA
Ingredienti – 400 gr di pasta avanzata (va bene anche mista) 3 uova XXL, mezzo bicchiere di latte, 250 gr di passata di pomodoro, una cipolla piccola, un cucchiaio di erba cipollina secca, 5 cucchiai di formaggio grattugiato, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale e pepe qb.
Procedimento – Sbattete le uova col formaggio il latte, l’erba cipollina aggiustando di sale e di pepe. Scaldate in metà dell’extravergine la cipolla finemente tritata e fatele prendere colore, ora aggiungete la passata di pomodoro e fate andare per una decina di minuti. Condite con questo sugo di pomodoro la pasta avanzata, aggiungete le uova sbattute. Scaldate una padella antiaderente e capiente con un filo di extravergine e quando la padella è calda versate il composto di pasta e uova. Fate rapprendere, rigirate, fate fare la crosticina come si fa con una normale frittata e servite. Se la pasta avanzata è molto condita potete omettere di aggiungere il sugo di pomodoro.
POPETTE DI LESSO
Ingredienti – 400 gr di patate, 400 gr di bollito di carne misto, 4 uova, 150 gr di pangrattato e 150 gr di farina 0, 150 gr di formaggio grattugiato, un litro di olio di semi di girasole alto-oleico (o altro olio per friggere), un mazzo di prezzemolo, uno spicchio d’aglio, sale, noce moscata e pepe qb.
Procedimento – Lessate le patate con la buccia, poi appena cotte schiacciatele col passapatate facendole cadere in una terrina. Frullate grossolanamente il bollito. Unite alle patate due uova, il prezzemolo tritato finemente, l’aglio schiacciato con l’apposito attrezzo in modo da prendere solo la polpa oppure tritatelo finissimamente e il bollito frullato o battuto al coltello, il formaggio grattugiato e una buona dose di noce moscata. Aggiustate se serve di sale e di pepe. Amalgamante bene poi con le mani formate tante palline. Sbattete le uova rimaste. Passate le palline prima nella farina poi nell’uovo, nel pangrattato, ancora nell’uovo e di nuovo nel pangrattato. Scaldate l’olio e friggete le polpette un po’ alla volta.
PLUMCAKE DI PANDORO
Ingredienti – Un mezzo pandoro (dunque circa 500 gr) due uova, 300 gr di mascarpone, sei tazzine di caffè, mezzo bicchiere di rum o di liquore al cioccolato, 180 gr di zucchero compreso quello per zuccherare il caffè, 300 ml di panna da montare già zuccherata polvere di cacao amaro, zucchero a velo, 30 gr di lamelle di mandorle, qualche grappolino di ribes.
Procedimento – Montate a con la planetaria o con le fruste elettriche a neve le chiare delle uova. Ora montate con 2/3 dello zucchero a bianco i tuorli delle uova. Fate i caffè, zuccherateli e lasciateli raffreddare. Incorporate ai rossi d’uovo montati con lo zucchero il mascarpone e le scaglie di mandorla, amalgamante bene poi aggiungete girando dal basso verso l’alto le chiare d’uovo. Fate a fette di circa mezzo centimetro di spessore il pandoro, allungate il caffè con il rum o il liquore al cioccolato e in questa bagna passate velocemente le fette di pandoro. Foderate con il pandoro uno stampo da plumcake (se del caso imburratelo prima) e farcitelo con il mascarpone e le uova. Chiudete con ancora pandoro e andate in frigorifero per un paio d’ore, in congelatore per una mezz’ora. Nel frattempo montate la panna. Togliete dal frigo il plumcake, sformatelo e guarnitelo con la panna, il ribes, lo zucchero a velo e il cacao amaro.
Scaramanzie gastronomiche e simboli per il Capodanno

iStock
Anche a tavola ci sono dei rituali scaramantici, del resto la simbologia del cibo è estesa a tutte le latitudini. Basterebbe pensare a come i giapponesi intendono la cucina o come alcuni precetti religiosi siano dettati non da un afflato sacro, ma da una più prosaica necessità di tutela della salute. L’unico caso forse è quello della cucina kasher o kosher che si richiama direttamente al testo della Bibbia là dove è scritto: “Quanto si muove e ha vita vi servirà di cibo: vi do tutto questo, come già le verdi erbe. Soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè il suo sangue. (Genesi 9: 3-4) e ancora Dio disse: Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero in cui è il frutto, che produce seme: saranno il vostro cibo.” (Genesi 1:29). Poi ci sono le sovrapposizioni culturali e antropologiche. Molto del nostro calendario delle feste di fine anno dipende da quello romano che a sua volta assunse dal mondo greco ed etrusco: i Saturnali in celebrazione del tempo che scorre, il Sol Invictus in venerazione del ritorno del ciclo della vita. Siccome l’Italia è stata terra di passaggio per moltitudini ed è pontile proteso nel Mediterraneo indagare tutti i riti della fine d’anno è impresa enciclopedica. Limitiamoci ad alcuni simboli che si portano in tavola.
MELAGRANA – È a molte latitudini il frutto della fertilità per eccellenza. Per gli ebrei i suoi 613 frutti sono tanti quanti i precetti della Torah, per i greci era addirittura il frutto regale (per via della corona che ha all’apice) per le popolazioni asiatiche era paragonata alla fertilità femminile e il rosso del suo succo è per definizione il colore della vita: il sangue. Dunque portarla in tavola a Capodanno è quasi un obbligo.
MANDORLA - È il frutto simbolico per eccellenza: si tratta della vescica piscis. Che è l’incontro di due semicerchi. Non se ne abbiano a male i cristiani che pure venerano questo simbolo, ma è la similitudine con lo yn e lo yang cinese e orientale in genere è forte. La mandorla incorona le immagini del Cristo e della Madonna ed è l’unione di cielo e terra, di spirito e materia, di copro e anima. Così la mandorla è insieme auspicio di fertilità e affermazione di eternità.
FRUTTA SECCA – Sia pure con una simbologia attenuata rispetto alla mandorla la frutta secca – era adorata dai romani che la scambiavano come dono durante i Saturnali e da lì deriva la nostra abitudine a i regali di Natale – rappresenta anch’essa la speranza di fertilità (il frutto morbido celato all’interno) e la capacità di resistenza (il guscio duro) allo scorrere del tempo. A Napoli e in tutto il Sud alla fine dei pasti delle feste arriva il cesto della frutta secca detto ‘o spassatiempo che serve a prolungare il convivio nelle chiacchiere post-prandiali.
DATTERI – Ne andavano pazzi i romani per i cristiani, ma anche per i musulmani, è un omaggio a Maria e simbolo di sostentamento. C’è una sura del Corano (la 19 Mayriam) che narra come Maria sentite le doglie del parto si fermò sotto una pianta e Dio le disse di scuoterla, ne ricevette una “pioggia” di datteri per sostentarla e rinfrescarla.
BACCALÀ – È il pesce dei cattolici per eccellenza, si è conquistato questo titolo al Concilio di Trento dove lo stoccafisso venne indicato come ingrediente necessario per i giorni di magro (che allora erano tanti) visto che dell’aringa si era “impossessato” Martin Lutero. Furono i portoghesi a sostituire il pesce stocco con il loro merluzzo salato, ma baccalà e stoccafisso hanno avuto diffusione parallela e talvolta confusa in tutto l’areale cattolico. Il consumo di pesce durante le feste religiose non rimanda solo al concetto di vigilia ma a un simbolo fortissimo che connotò i paleocristiani i quali indicavano Cristo con la simbologia del pesce (due archi di cerchio che si intersecano, esattamente come la mandorla) visto che Ichtys in greco diventa l’acronimo di Gesù Cristo, Figlio di Dio, Salvatore.
ANGUILLA – È “vittima” della sua forma: anguilla e capitone essendo simili al serpente simboleggiano il male che viene appunto sconfitto all’inizio del nuovo anno, ma col serpente condividono anche un’altra simbologia: quella del ciclo vitale. Esculapio lo eleva a emblema della cura, la Bibbia lo precipita al ruolo di mentitore, per i Sumeri era sensualità. Insomma siccome significa tutto questo finire in pentola è un destino segnato.
RISO – FARRO – Il significato da oriente a occidente è lo stesso: il cereale come affermazione di fertilità e promessa di benessere. Anche il grano ha questo corredo simbolico per cui usare farina, abbondare col pane, immaginare zuppe di cereali da portare a tavola ha un forte valore augurale.
LENTICCHIE E ZAMPONE – La valenza scaramantica di questa pietanza è duplice. Per i romani le lenticchie erano segno di promessa di abbondanza. La ragione è alimentare, cibo disponibile ampiamente e a basso costo e anche se così si può dire geometrica: essendo rotonde assomigliano alle monete. Dunque tante lenticchie tanta promessa di ricchezza. Lo zampone (oggi sovente sostituito da cotechino) ha una doppia simbologia. Per i mediterranei il maiale era (ed è) l’animale disponibile, da tesaurizzare (è il motivo per cui il salvadanaio è a forma di porcellino) da sfruttare come giacimento proteico, per la cultura della selva è invece il simbolo della fertilità ed in particolare la zampa del suino (probabilmente del cinghiale che era l’alimento di base delle popolazioni germano-celtiche) era il portafortuna per eccellenza.
ARANCE E MANDARINI – Sono gli agrumi i frutti del Sole, non a caso le case regnanti avevano tutte l’orangerie (in Italia i Medici avevano una singolare predilezione per questi frutti) e si era soliti regalarli ai bambini in segno di promessa di futuro. Anche oggi mantengono – non foss’altro perché col corredo di vitamina C sono ausilio contro i mali di stagione – questa connotazione magico-simbolica di evocare la vita attraverso il sole.
UVA – I significati simbolici del frutto della vite si perdono nella notte dei tempi. I chicchi rappresentano la propensione all’ebrezza, ma anche il dono degli dei agli uomini come ostentamento, sono insieme abbondanza e rigenerazione, ma anche sacrificio nel momento in cui l’uva viene spremuta per dare il vino. A questo proposito c’è un’iconografia molto particolare che è quella del Cristo Vendemmiatore (ne resta un esemplare notevole al museo Piersanti di recente riaperto a Matelica nelle Marche) che spreme nel torchio mistico i peccatori. Da qui la necessità di assicurarsi la futura prosperità mangiando l’uva. Il rito viene dalla Spagna (per la verità in Italia lo si consumava già prima in forma diversa) che ha unito un chicco a ogni mese così allo scandire della mezzanotte si dovrebbero mangiare 12 chicchi d’uva come polizza sulla prosperità dell’anno che viene.
PEPERONCINO – Il colore rosso e la forma a corno non potevano non dare un posto di privilegio tra i cibi scaramantici al “diavolicchio”. Il colore rosso – è per i cristiani il sangue di Cristo versato per la nuova ed eterna alleanza dunque simbolo di futuro – è il colore della vitalità. Il corno, fin dal neolitico, è simbolo di forza (ha a che fare con la caccia e dunque con la prova di forza ma anche con la riserva alimentare) dunque il peperoncino è il cibo scaramantico per eccellenza (fate un giro a Napoli e vedrete quanti cornetti rossi vi vengono proposti). Ah, e comunque: buon anno!