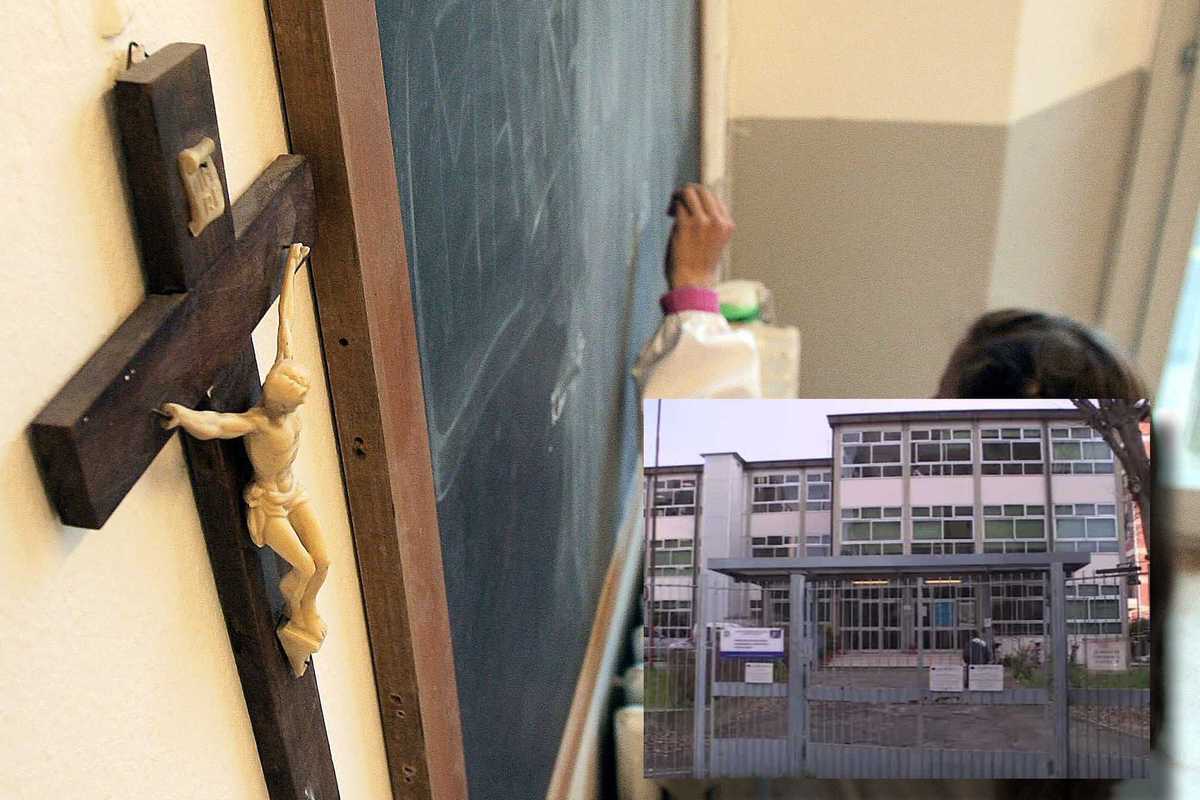Proverbio gardesano: il pesce vuol nuotare tre volte, nell’acqua, nell’olio e nel vino. Più che un motto è la bandiera tricolore del territorio benacense e della sua cucina di pesce. Il Garda è un lago a tutta Dop, denominazione d’origine protetta. Tutto il pesce si cattura in questi 368 chilometri quadrati di superficie acquea; l’olio e le viti si coltivano sui terreni che vi si affacciano. Teofilo Folengo, alias Merlin Cocai, poeta maccheronico mantovano, monaco indulgente ai peccati del ventre (e a quelli del bassoventre), lo aveva capito bene 500 anni fa. Nel poema Maccheronee dedica un epigramma al lago di Garda e ai suoi pesci che prediligeva fritti: «C’è un lago in Italia le cui acque balzan su come quelle del mare in tempesta. Si mangia sempre buon pesce da quelle parti: sardéne, anguille, carpione, tinca, trote. Ma senza il palladio liquore che valgono i pesci? Che valgono se non friggono nell’olio in una nera padella? Ecco perché tutt’intorno le rive sono cariche d’olivi e perché la vicina Brescia fornisce i suoi vasi di ferro. Nascono dunque qui, insieme, olio, pesce, pescatore e perfino la stessa padella che serve a friggere il pesce». È una perfetta descrizione di quello che i giornalisti di gastronomia chiamano territorio: l’ambiente, i prodotti tipici, gli uomini, l’artigianato, la storia.
Da secoli il pesce del Benàco, antico nome del Garda, è celebre per il sapore delle carni, per le loro qualità nutritive e per come si prestano in cucina. Oltre alla frittura, trote, sarde, coregoni, persici, tinche si offrono per essere cucinati al forno, ai ferri, al vapore; a preparazioni in carpione, in zuppe, in salse; con la pasta e col riso. I bigoli con le sarde del lago, che qui chiamano sardène, il risotto col lavarello (o coregone), il luccio in saòr, che Bartolomeo Stefani nel Seicento preparava per i Gonzaga alla corte di Mantova, la trota lacustre, sono tra le specialità del Garda da gustare almeno una volta nella vita.
I bigoli con le sarde piacevano molto a Maria Callas, che tra una Turandot, un’Aida e una Traviata in Arena, se li faceva servire al ristorante Gardesana di Torri del Benàco dove arrivava dalla villa di Sirmione in compagnia del marito veronese Gianbattista Meneghini (Aristotele Onassis era di là da venire). Racconta Giuseppe Lorenzini titolare dell’albergo ristorante che oltre al divino soprano greco ha ospitato re (Juan Carlos di Spagna), presidenti (il tedesco Horst Koehler), famosissimi attori e campioni dello sport: «La Callas introdusse una variazione ai nostri bigoli con le sarde: volle che aggiungessimo l’uva sultanina di Corinto. Non era una tipicità del Garda, ma, naturalmente, l’accontentammo. E la ricetta dei Bigoli alla Callas è rimasta nel menu storico del Gardesana».
Secoli prima di Folengo e un paio di millenni prima della Callas i pesci del Garda, soprattutto il mitico carpione, trovarono un grande estimatore in Valerio Catullo. Il poeta aveva tre amori: il lago, la poesia e le donne. Tornava sempre volentieri nella villa paterna di Sirmione dove lo aspettava la fedele Quinzia che, nella «perla delle isole e delle penisole», suppliva nel letto del poeta Lesbia, la patrizia romana piuttosto spregiudicata in amore. Per il poeta del Benàco Lesbia rimaneva, nonostante i tradimenti, «splendida dentro e fuori: da sola toglie le grazie a tutte le altre donne». Anche a Dante Alighieri, poeta di poco appetito, stando ai racconti che il Garda conserva gelosamente (e golosamente), piaceva il pesce del Benaco che conobbe alla mensa di Cangrande Della Scala a Verona. In particolare gli garbavano le famose anguille di Peschiera, cittadina che immortalò nel 20° canto dell’Inferno: «Siede Peschiera, bello e forte arnese / da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi,/ ove la riva ’ntorno più discese».
Per secoli il pesce del Garda ha sfamato le popolazioni rivierasche e impreziosito le mense delle classi alte, borghesia, nobiltà e clero, alle quali era riservato il meglio: i carpioni, in passato numerosi, le trote lacustri, i lucci, perfino le lamprede estinte negli anni Settanta. Cosa restava alle famiglie meno abbienti? Le alborelle (in dialetto veronese aole), le popolari sardène, gli umili varoni. Oggigiorno il prezzo del pesce di lago è alla portata di tutti. Ma purtroppo da fine Ottocento ad oggi il lago, la sua fauna, la biodiversità in generale sono stati sottoposti a colpi durissimi. Specie ittiche sono scomparse per l’inquinamento, la pesca incontrollata, modifiche del territorio perpetrate da amministrazioni ottuse, turismo di massa. Si sta cercando di correre ai ripari proteggendo la biodiversità, con l’ittiocoltura, e rimettendo al centro della cucina gardesana il pesce. Lo ha fatto una settimana fa il primo Festival del pesce d’acqua dolce, ideato da Giulio Biasion, giornalista bolognese, presidente del Club dei Sapori, e appoggiato dalle amministrazioni di Torbole-Nago, Arco, dalla Regione e dalla comunità del Garda. Il festival ha riunito cuochi, nutrizionisti, biologi, itticoltori, ambientalisti in convegni, laboratori didattici (per gli studenti), show cooking con cuochi di fama.
Ivano Confortini, biologo della Regione Veneto toccando diversi temi, dai pescatori professionisti (sono rimasti in cento in tutto il lago) ai pesci autoctoni e a quelli introdotti ha detto: «Ci voleva un pesce svizzero, il lavarello proveniente dal lago di Costanza e introdotto nel 1918, per arricchire la fauna del Garda e sostenere l’economia». Ivo Miorelli, 52 anni, cuoco da quando ne aveva 19, patron de La terrazza di Torbole, profondo conoscitore delle trazioni gastronomiche, spiega: «Un tempo era il prelibato carpione a creare la ricchezza del territorio. I pescatori lo portavano ai dogi veneziani, ai duchi milanesi, ad Amburgo... Per il trasporto veniva acconciato con alloro, cipolle, spezie, fette di limone, aceto. Da questo metodo prende il nome la preparazione in carpione. Ora è il lavarello che si è ambientato magnificamente, a creare economia. Lapo Elkann, arrivato con una Ferrari fantastica lo ha voluto in carpaccio».
Miorelli, torbolano da generazioni, ha ospitato parecchi clienti di riguardo: Lech Walesa, presidente della Polonia, al quale ha preparato la tinca alla torbolana. Risotto con la tinca per il regista Bernardo Bertolucci; luccio lesso per Luciana Littizzetto. Ivo prepara ancora il sisam, sorta di conserva di pesce che si faceva fin da tempi antichi con le alborelle. «Le faccio arrivare dal lago d’Iseo perché nel Garda mancano da 18 anni. È pesce azzurro povero, come la sarda. Un tempo si essicavano in spiaggia su graticci. A noi bambini facevano schiacciare le teste per ricavarne una gustosa colatura. Per la gente del lago il sisam era come il salame per i contadini di pianura. Si mangiava pan e sisam».
Fiorenzo Perremuto, 49 anni, papà siciliano e mamma trentina, è cuoco e docente all’Istituto alberghiero di Levico. «Ho imparato a valorizzare le erbe col pesce dalla nonna e dalla mamma, entrambe botaniche. «Per lo show-cooking del festival ho preparato una tartare di trota lacustre marinata con agrumi, aneto, pepi tostati. L’ho servita con una mousse di rapa rossa e maionese di uova di trota e, per dare un’idea del Garda ho aggiunto una polvere fatta con olive del lago. Ho aggiunto salicornia, fiorellini di borraggine e di sambuco appena raccolti».
Livio Parisi, ex professore, autore di molti libri sul Garda e sulla fauna ittica, ha lasciato la scuola per fare il ristoratore a Castelletto di Brenzone, ristorante Al pescatore. «Dobbiamo lavorare in sinergia e portare il pesce del nostro lago al riconoscimento del marchio Dop. Riportare sul podio il pesce gardesano significa limitare l’accesso al nostro territorio di prodotti ittici provenienti da Ucraina, Russia e Asia e valorizzare figure, come quella del pescatore, ormai in via d’estinzione».