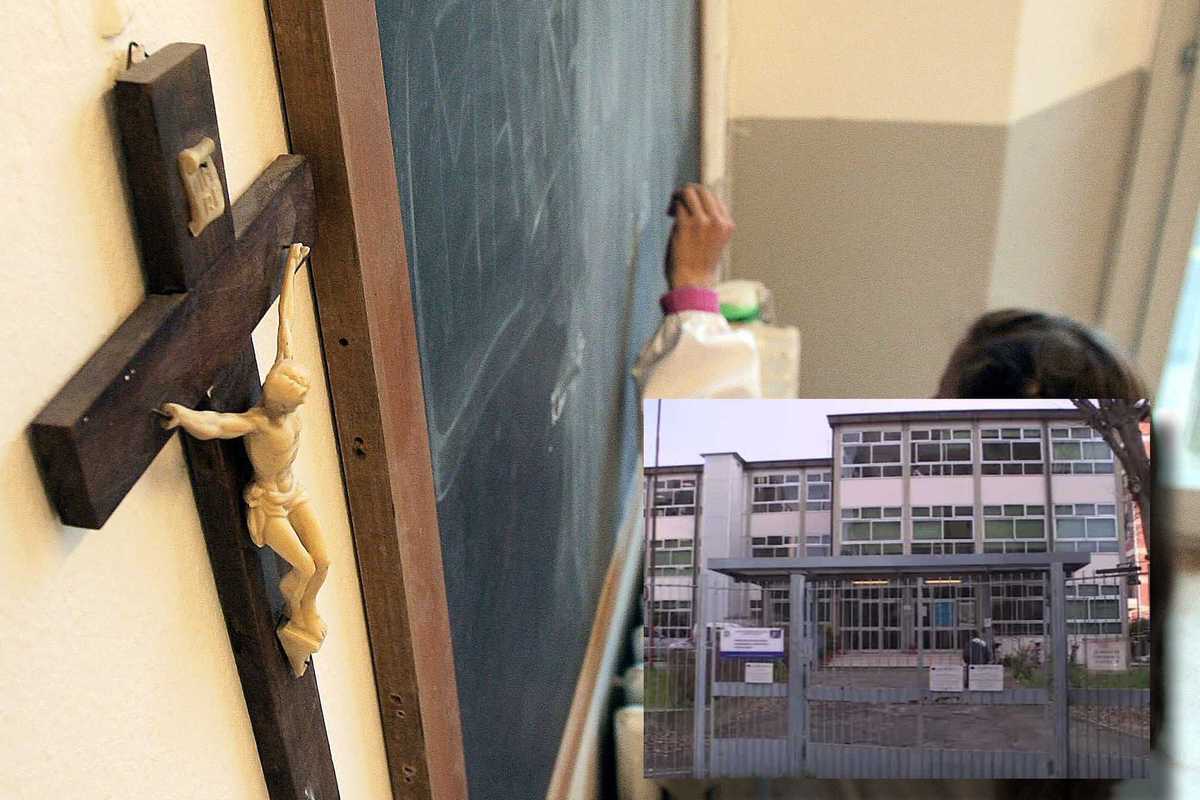True
2022-03-03
Quando Bach suona il rock
True
(Ansa-IStock)
Fu solo dopo la metà degli anni Sessanta che la musica classica incontrò il pop-rock mondiale, per proseguire e svilupparsi per tutto il periodo successivo. Fino ad allora, a partire dagli albori del decennio precedente, la scena mondiale della musica leggera era stata dominata dal rock’n’roll, un’evoluzione del blues dalle radici puramente afro-americane. La fine della seconda guerra mondiale e il dominio culturale ed artistico degli Stati Uniti sul mondo occidentale avevano contribuito alla diffusione del rock, declinato nella lingua locale in molti paesi d’Europa. In Italia il Clan di Adriano Celentano e autori come Bobby Solo e Little Tony si erano appropriati dell’immagine del re del rock mondiale Elvis Presley e di star come Jerry Lee Lewis ed avevano scalato le classifiche nazionali come fece in Francia Johnny Hallyday. Per tutta la prima parte degli anni Sessanta i nuovi autori rimasero sostanzialmente ancorati al rock’n’roll classico, in primis i Beatles degli esordi e i primi Rolling Stones. L’incontro tra le melodie e i canoni dei grandi autori del passato avviene sostanzialmente con gli esordi dello stile «progressive», che dominerà le scene a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta. I protagonisti dello stile saranno musicisti tecnicamente preparati, molti dei quali provenienti da studi di conservatorio. Riguardo alle contaminazioni, alle citazioni o alle elaborazioni originali dei pezzi classici ne abbiamo parlato con un grande pianista a livello internazionale, Takahiro Yoshikawa. Gli abbiamo chiesto chi fosse l’autore del passato che più ha influenzato l’evoluzione «progressiva» e in generale quella del pop-rock internazionale. «Nessun dubbio, Johann Sebastian Bach» - ci ha risposto- spiegandoci anche il perché: «Bach - afferma Yoshikawa - è sempre stato un punto di riferimento per gli autori che lo hanno seguito. Una specie di enciclopedia vivente della musica occidentale, culla delle tradizioni musicali popolari e sacre allo stesso tempo, interprete dei canoni inglesi, francesi, tedeschi e italiani che ricorrono nelle sue composizioni». L’origine popolare di molte composizioni di Bach fece sì che le generazioni future di compositori prendessero le sue opere come punto di partenza per elaborazioni originali, molto più di autori successivi altrettanto illustri come ad esempio Mozart». Fu dunque il maestro di Eisenach ad ispirare in molteplici forme l’evoluzione del pop-rock. «La musica di Bach - spiega il pianista giapponese- è concettuale. Lui nella composizione non era legato al colore o timbro di ciascuno strumento. Nella sua «Offerta musicale», composizione scritta nel 1747 partendo da un’improvvisazione dedicata a Federico II di Prussia, la partitura non riporta i nomi degli strumenti, lasciando la massima libertà di interpretazione ed elaborazione». In alcuni casi il riferimento a Bach fu una vera e propria «cover» e questo fu il caso dei Procol Harum, con «A Whither shade of pale» del 1967. Il pezzo non era altro che una fedele copia dell’«Aria sulla quarta corda» riarrangiata alla fine del XIX secolo da August Whilelmj dall’originale Terza suite orchestrale in re maggiore del 1730. Il grandissimo successo del pezzo dei Procol Harum (in Italia riproposto con il titolo Senza luce e interpretato negli anni dai Dik Dik, Fausto Leali, Caterina Caselli e Al Bano) fece da ponte alla divulgazione della classica nelle classifiche pop-rock mondiali. L’anno precedente ad aprire le danze alla nuova contaminazione musicale era stato il quartetto più celebre del mondo, i Beatles. Lo avevano fatto quasi in sordina, grazie all’apporto fondamentale di un compositore di primissimo piano che era anche il produttore musicale dei Fab Four, George Martin. «Rubber Soul», il sesto lp dei Beatles, era uscito alla fine del 1965 ed aveva scalato le classifiche mondiali sin dai primi giorni del 1966. L’undicesima traccia del disco era il brano «In my life», una ballata malinconica sui ricordi del passato interrotta alla penultima strofa da un intermezzo nettamente staccato dalla struttura della canzone e suonato dallo stesso Martin al clavicembalo. Quello che ai profani potrebbe suonare come un minuetto è in realtà l’arrangiamento su un particolare giro musicale del Seicento. E’ Takahiro Yoshikawa a leggere per noi quel passaggio, riconoscendolo immediatamente come una interpretazione del «canone di Pachelbel», una composizione in stile barocco che si ritiene composta dal musicista di Norimberga Johann Pachelbel (1653-1706). Quello che sarà uno dei canoni classici più usati dal pop (gli stessi Beatles lo riproporranno in una delle loro ultime composizioni, «Let it Be») era di fatto una composizione per tre violini e basso continuo, dove quest’ultimo costituisce la base armonica allo sviluppo della melodia in una sequenza di accordi molto ricorrenti nella musica leggera contemporanea (Re/La/Si minore/Fa#minore/Sol/La e ritorno sulla tonica Re). Un giro che è entrato nell’orecchio e nel cuore degli Italiani, perché sul canone di Pachelbel si può cantare tranquillamente «Albachiara» di Vasco Rossi e tanti altri successi pop.
I Beatles e George Martin saranno il fulcro dell’abbraccio tra la musica sinfonica classica e il rock anche negli anni successivi, contribuendo in modo determinante alla diffusione globale di questa nuova contaminazione. Nel 1967 usciva infatti uno dei dischi più ascoltati al mondo, «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band», un concept album pieno di rimandi e arrangiamenti orchestrali. Il primo indizio viene da una «ghost track» all’inizio del disco dove in sottofondo si può sentire la London Philarmonic Orchestra nella fase di accordatura degli archi. Dello stesso anno è un’altro successo mondiale dei Beatles, «Penny Lane», che avrebbe dovuto essere inclusa in «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» ma che fu poi pubblicata come singolo. Il brano di per sé appariva all’orecchio di George Martin come una canzonetta, ben fatta ma senza un tocco unico che la distinguesse dalle altre, come avvenuto per molte hit del quartetto. La soluzione venne ancora dal grande Bach con uno strumento, secondo Takahiro Yoshikawa, molto ricercato e che pochi suonano: il trombino (in inglese piccolo trumpet), uno strumento a fiato del tutto simile a una tromba, ma di dimensioni ridotte ed intonata un’ottava sopra, in si bemolle. Era un ottone impiegato nelle opere di Bach e più in generale nella musica barocca. Questo piccolo strumento fu la chiave di volta che George Martin utilizzò per rendere unico l’arrangiamento di una canzonetta, pensando al Secondo concerto brandeburghese che il maestro aveva appena ascoltato alla Bbc insieme a Paul McCartney. L’indomani Martin chiamò il trombettista David Mason, del Royal College of Music di Londra e organizzò una session con i Beatles in cui Mason inventò, ispirandosi all’opera di Bach, quell’assolo che renderà unica la canzone, ancora una volta firmata dal genio tedesco. La luna di miele tra il compositore barocco e il quartetto di Liverpool proseguirà anche negli album successivi. Nel doppio lp del 1968, «the White album», un pezzo per chitarra acustica composto da Paul McCartney ne è la prova. In questo brano di nuovo l’eco di Bach fa da guida a «Blackbird», con l’utilizzo del basso continuo in una reinterpretazione della famosissima «Bourrée in mi minore», che i Jethro Tull riprenderanno integralmente l’anno successivo con Ian Anderson al flauto traverso. L’ultimo disco dei Beatles in termini di data di registrazione (e l’ultimo in studio) fu uno dei più grandi capolavori della storia del pop-rock: «Abbey Road». Qui, nel brano malinconico «Because» attacca il clavicembalo di George Martin con un accompagnamento in terzine che è la rielaborazione di uno dei brani più conosciuti di Ludwig van Beethoven, la «Sonata al chiaro di luna».
I Beatles si sciolsero nel 1970, quando il «progressive» era agli albori e molti altri autori avrebbero guardato alla musica classica, anche tra i grandi la cui carriera era iniziata nel decennio precedente, come il cantautore newyorchese Paul Simon. Nel 1973 uscì l’album «There goes Ryhmin’ Simon» dove era contenuto il brano «American Tune». Al primo ascolto il pezzo, che nel testo parla di deriva del sogno americano, potrebbe sembrare una ballata nella tradizione della East coast. In realtà il tema portante è ancora una volta opera del grande Bach. Anzi no. Takahiro Yoshikawa ci riporta ancora più indietro nel tempo, perché spiega che il grande compositore tedesco prese a sua volta ispirazione da un musicista suo conterraneo di un secolo precedente, Hans Leo Hassler, che compose la «Passione corale» attorno al 1600. La passione di Gesù, musicata dal testo latino scritto nel medioevo e tradotta in tedesco dal poeta luterano Paul Gerhardt, fu ripresa e riarrangiata integralmente da Bach nella «Passione di Matteo» (1727). Paul Simon dichiarò di avere esplicitamente attinto all’opera corale, ben riconoscibile all’inizio e alla fine della strofa.
L’anno successivo all’uscita di «American Tune» un’altro album che farà storia verrà lanciato sul mercato mondiale. Era il 18 novembre 1974 quando i Genesis presentarono il loro primo concept album, «The lamb lies down on Broadway», la cui intro di pianoforte ricordava molto alcuni passaggi del «Concerto per pianoforte n.2» (1900) di Sergej Rachmaninoff mentre nel tour mondiale che precedette il lancio del disco il frontman Peter Gabriel fece distribuire al pubblico un opuscolo con le «note di sala» sull’esempio di Héctor Berlioz (Idée Fixe). Il libretto conteneva informazioni per seguire la storia contenuta nel brano della durata di 23 minuti, «Supper’s Ready».
La presenza della musica classica come influenza diretta o come semplice (si fa per dire) citazione all’interno di brani originali proseguirà in diversi successi degli anni successivi all’era del rock «prog». Uno degli esempi più noti è certamente il repertorio dei Queen, intriso di passaggi musicali ispirati soprattutto all’opera classica. Al di là di evidenti echi noti a tutti come quelli che costituiscono la struttura musicale ed il cantato di uno dei più grandi capolavori della band, «Bohemian Rapsody», la lirica è protagonista in una citazione palese con la performance canora di Freddie Mercury. Le prime battute di «It’s a hard life» altro non sono che una reinterpretazione della melodia di «Vesti la giubba», aria famigerata de «I pagliacci» di Ruggero Leoncavallo. Anche Sting, in un successo scritto durante l’era della perestrojka di Gorbaciov, si produsse in una citazione «sotto traccia» in «Russians» (1985). Sotto il cantato è infatti presente una linea melodica fedelmente ripresa dal tema «Romanza» tratta dall’opera «Il luogotenente Kize», scritta per l’omonimo film sovietico da Sergej Prokofiev nel 1934. Anni più tardi sarà un’altra popstar britannica a riprendere Prokofiev in una delle sue hit più famose degli ultimi anni. In «Partying like a russian», Robbie Williams propone l’inserimento di uno stralcio della «Danza dei cavalieri» tratta dall’opera del 1935 «I Montecchi e i Capuleti». Frédéric Chopin sarà invece il protagonista della citazione di una delle più importanti band degli anni Novanta, i Radiohead, che nel loro album più famoso, «Ok computer» del 1997 si ispirano esplicitamente al «Preludio in Mi minore», dall’opera 28 - n.4 con un arrangiamento folk-grunge fatto dall’accompagnamento di chitarra acustica e la linea melodica cantata. Così come Chopin, anche Beethoven fa la sua comparsa in un brano di uno dei gruppi-rivelazione degli ultimi anni, i 21 Pilots. Il duo nato in Ohio nel 2009 «rappa» sulla «Sonata al chiaro di luna» che lega il parlato e il beat di batteria e percussioni in «Neon gravestones», mentre il «canone di Pachelbel» di cui abbiamo parlato più sopra ritorna in «Memories» dei Maroon Five. Il tempo a disposizione di Takahiro, reduce da una lunga tournée nel suo Giappone, sta per finire e quando ormai è agli sgoccioli ci tocca tornare di nuovo con la mente alle origini del rock, perché ci ricordiamo che Elvis Presley uscì con un grandissimo successo che era ripreso da un brano classico. Nel 1961 usciva «Can’t help falling in love» e quella hit che consumò i juke box e fece innamorare le coppie che la ballavano guancia a guancia era nata in verità nel 1785 dalla mente di Jean-Paul-Egide Martini. «Plaisir d’amour» fu una composizione che piacque particolarmente alla regina Maria Antonietta di Francia. Alla fine ci ricordiamo anche che un «lento», di quelli che chiudevano le serate nelle discoteche degli anni Settanta, ci fu regalato da Rachmaninoff. «All by myself» di Eric Carmen attingeva a piene mani e riprendeva il “Concerto per pianoforte n.2 in do minore». L’ultimo nostro pensiero è per Lady Gaga, che omaggia i classici senza interferire. Takahiro mi ricorda che nel video ufficiale di «Marry the night», per circa un quarto d’ora le crude scene del ricovero in psichiatria della protagonista (Lady Gaga stessa) sono accompagnate dalle note drammatiche ed incalzanti della sonata per pianoforte «Patetica» di Beethoven.
Takahiro Yoshikawa, pianista
Milanese d’adozione, Takahiro Yoshikawa divide la sua attività di concertista tra l’Italia e il natio Giappone. A Tokyo si è diplomato e dottorato in pianoforte presso l’Università delle Arti di Tokyo, a Milano ha proseguito i suoi studi con insegnanti come Anita Porrini e Silvia Bianchera Bettinelli, frequentando l’Accademia Teatro alla Scala. È impegnato in una intensa attività concertistica e discografica in Italia e in Giappone come solista e in formazioni cameristiche. Numerose le sue esibizioni al Teatro alla Scala e in concerti con i Solisti della Scala. Suona in duo da più di 15 anni con il primo clarinettista solista del Teatro alla Scala Fabrizio Meloni con cui tiene anche varie Masterclass. Ha ricevuto numerosi premi internazionali. Per seguirlo il suo sito web ufficiale è www.takahiroyoshikawa.com
Continua a leggereRiduci
L'incontro tra la classica e il pop-rock ha creato capolavori. Fu soprattutto Bach a lasciare il segno: dai Beatles a Paul Simon ai Radiohead. Un pianista classico di grande talento, Takahiro Yoshikawa, ci aiuta a leggere le contaminazioni. Da Chopin a Beethoven a Prokofiev attraverso i grandi successi della musica leggera.Fu solo dopo la metà degli anni Sessanta che la musica classica incontrò il pop-rock mondiale, per proseguire e svilupparsi per tutto il periodo successivo. Fino ad allora, a partire dagli albori del decennio precedente, la scena mondiale della musica leggera era stata dominata dal rock’n’roll, un’evoluzione del blues dalle radici puramente afro-americane. La fine della seconda guerra mondiale e il dominio culturale ed artistico degli Stati Uniti sul mondo occidentale avevano contribuito alla diffusione del rock, declinato nella lingua locale in molti paesi d’Europa. In Italia il Clan di Adriano Celentano e autori come Bobby Solo e Little Tony si erano appropriati dell’immagine del re del rock mondiale Elvis Presley e di star come Jerry Lee Lewis ed avevano scalato le classifiche nazionali come fece in Francia Johnny Hallyday. Per tutta la prima parte degli anni Sessanta i nuovi autori rimasero sostanzialmente ancorati al rock’n’roll classico, in primis i Beatles degli esordi e i primi Rolling Stones. L’incontro tra le melodie e i canoni dei grandi autori del passato avviene sostanzialmente con gli esordi dello stile «progressive», che dominerà le scene a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta. I protagonisti dello stile saranno musicisti tecnicamente preparati, molti dei quali provenienti da studi di conservatorio. Riguardo alle contaminazioni, alle citazioni o alle elaborazioni originali dei pezzi classici ne abbiamo parlato con un grande pianista a livello internazionale, Takahiro Yoshikawa. Gli abbiamo chiesto chi fosse l’autore del passato che più ha influenzato l’evoluzione «progressiva» e in generale quella del pop-rock internazionale. «Nessun dubbio, Johann Sebastian Bach» - ci ha risposto- spiegandoci anche il perché: «Bach - afferma Yoshikawa - è sempre stato un punto di riferimento per gli autori che lo hanno seguito. Una specie di enciclopedia vivente della musica occidentale, culla delle tradizioni musicali popolari e sacre allo stesso tempo, interprete dei canoni inglesi, francesi, tedeschi e italiani che ricorrono nelle sue composizioni». L’origine popolare di molte composizioni di Bach fece sì che le generazioni future di compositori prendessero le sue opere come punto di partenza per elaborazioni originali, molto più di autori successivi altrettanto illustri come ad esempio Mozart». Fu dunque il maestro di Eisenach ad ispirare in molteplici forme l’evoluzione del pop-rock. «La musica di Bach - spiega il pianista giapponese- è concettuale. Lui nella composizione non era legato al colore o timbro di ciascuno strumento. Nella sua «Offerta musicale», composizione scritta nel 1747 partendo da un’improvvisazione dedicata a Federico II di Prussia, la partitura non riporta i nomi degli strumenti, lasciando la massima libertà di interpretazione ed elaborazione». In alcuni casi il riferimento a Bach fu una vera e propria «cover» e questo fu il caso dei Procol Harum, con «A Whither shade of pale» del 1967. Il pezzo non era altro che una fedele copia dell’«Aria sulla quarta corda» riarrangiata alla fine del XIX secolo da August Whilelmj dall’originale Terza suite orchestrale in re maggiore del 1730. Il grandissimo successo del pezzo dei Procol Harum (in Italia riproposto con il titolo Senza luce e interpretato negli anni dai Dik Dik, Fausto Leali, Caterina Caselli e Al Bano) fece da ponte alla divulgazione della classica nelle classifiche pop-rock mondiali. L’anno precedente ad aprire le danze alla nuova contaminazione musicale era stato il quartetto più celebre del mondo, i Beatles. Lo avevano fatto quasi in sordina, grazie all’apporto fondamentale di un compositore di primissimo piano che era anche il produttore musicale dei Fab Four, George Martin. «Rubber Soul», il sesto lp dei Beatles, era uscito alla fine del 1965 ed aveva scalato le classifiche mondiali sin dai primi giorni del 1966. L’undicesima traccia del disco era il brano «In my life», una ballata malinconica sui ricordi del passato interrotta alla penultima strofa da un intermezzo nettamente staccato dalla struttura della canzone e suonato dallo stesso Martin al clavicembalo. Quello che ai profani potrebbe suonare come un minuetto è in realtà l’arrangiamento su un particolare giro musicale del Seicento. E’ Takahiro Yoshikawa a leggere per noi quel passaggio, riconoscendolo immediatamente come una interpretazione del «canone di Pachelbel», una composizione in stile barocco che si ritiene composta dal musicista di Norimberga Johann Pachelbel (1653-1706). Quello che sarà uno dei canoni classici più usati dal pop (gli stessi Beatles lo riproporranno in una delle loro ultime composizioni, «Let it Be») era di fatto una composizione per tre violini e basso continuo, dove quest’ultimo costituisce la base armonica allo sviluppo della melodia in una sequenza di accordi molto ricorrenti nella musica leggera contemporanea (Re/La/Si minore/Fa#minore/Sol/La e ritorno sulla tonica Re). Un giro che è entrato nell’orecchio e nel cuore degli Italiani, perché sul canone di Pachelbel si può cantare tranquillamente «Albachiara» di Vasco Rossi e tanti altri successi pop.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/quando-bach-suona-il-rock-2656829307.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="musica-classica-rock" data-post-id="2656829307" data-published-at="1646321152" data-use-pagination="False"> Musica Classica & Rock I Beatles e George Martin saranno il fulcro dell’abbraccio tra la musica sinfonica classica e il rock anche negli anni successivi, contribuendo in modo determinante alla diffusione globale di questa nuova contaminazione. Nel 1967 usciva infatti uno dei dischi più ascoltati al mondo, «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band», un concept album pieno di rimandi e arrangiamenti orchestrali. Il primo indizio viene da una «ghost track» all’inizio del disco dove in sottofondo si può sentire la London Philarmonic Orchestra nella fase di accordatura degli archi. Dello stesso anno è un’altro successo mondiale dei Beatles, «Penny Lane», che avrebbe dovuto essere inclusa in «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» ma che fu poi pubblicata come singolo. Il brano di per sé appariva all’orecchio di George Martin come una canzonetta, ben fatta ma senza un tocco unico che la distinguesse dalle altre, come avvenuto per molte hit del quartetto. La soluzione venne ancora dal grande Bach con uno strumento, secondo Takahiro Yoshikawa, molto ricercato e che pochi suonano: il trombino (in inglese piccolo trumpet), uno strumento a fiato del tutto simile a una tromba, ma di dimensioni ridotte ed intonata un’ottava sopra, in si bemolle. Era un ottone impiegato nelle opere di Bach e più in generale nella musica barocca. Questo piccolo strumento fu la chiave di volta che George Martin utilizzò per rendere unico l’arrangiamento di una canzonetta, pensando al Secondo concerto brandeburghese che il maestro aveva appena ascoltato alla Bbc insieme a Paul McCartney. L’indomani Martin chiamò il trombettista David Mason, del Royal College of Music di Londra e organizzò una session con i Beatles in cui Mason inventò, ispirandosi all’opera di Bach, quell’assolo che renderà unica la canzone, ancora una volta firmata dal genio tedesco. La luna di miele tra il compositore barocco e il quartetto di Liverpool proseguirà anche negli album successivi. Nel doppio lp del 1968, «the White album», un pezzo per chitarra acustica composto da Paul McCartney ne è la prova. In questo brano di nuovo l’eco di Bach fa da guida a «Blackbird», con l’utilizzo del basso continuo in una reinterpretazione della famosissima «Bourrée in mi minore», che i Jethro Tull riprenderanno integralmente l’anno successivo con Ian Anderson al flauto traverso. L’ultimo disco dei Beatles in termini di data di registrazione (e l’ultimo in studio) fu uno dei più grandi capolavori della storia del pop-rock: «Abbey Road». Qui, nel brano malinconico «Because» attacca il clavicembalo di George Martin con un accompagnamento in terzine che è la rielaborazione di uno dei brani più conosciuti di Ludwig van Beethoven, la «Sonata al chiaro di luna».I Beatles si sciolsero nel 1970, quando il «progressive» era agli albori e molti altri autori avrebbero guardato alla musica classica, anche tra i grandi la cui carriera era iniziata nel decennio precedente, come il cantautore newyorchese Paul Simon. Nel 1973 uscì l’album «There goes Ryhmin’ Simon» dove era contenuto il brano «American Tune». Al primo ascolto il pezzo, che nel testo parla di deriva del sogno americano, potrebbe sembrare una ballata nella tradizione della East coast. In realtà il tema portante è ancora una volta opera del grande Bach. Anzi no. Takahiro Yoshikawa ci riporta ancora più indietro nel tempo, perché spiega che il grande compositore tedesco prese a sua volta ispirazione da un musicista suo conterraneo di un secolo precedente, Hans Leo Hassler, che compose la «Passione corale» attorno al 1600. La passione di Gesù, musicata dal testo latino scritto nel medioevo e tradotta in tedesco dal poeta luterano Paul Gerhardt, fu ripresa e riarrangiata integralmente da Bach nella «Passione di Matteo» (1727). Paul Simon dichiarò di avere esplicitamente attinto all’opera corale, ben riconoscibile all’inizio e alla fine della strofa. L’anno successivo all’uscita di «American Tune» un’altro album che farà storia verrà lanciato sul mercato mondiale. Era il 18 novembre 1974 quando i Genesis presentarono il loro primo concept album, «The lamb lies down on Broadway», la cui intro di pianoforte ricordava molto alcuni passaggi del «Concerto per pianoforte n.2» (1900) di Sergej Rachmaninoff mentre nel tour mondiale che precedette il lancio del disco il frontman Peter Gabriel fece distribuire al pubblico un opuscolo con le «note di sala» sull’esempio di Héctor Berlioz (Idée Fixe). Il libretto conteneva informazioni per seguire la storia contenuta nel brano della durata di 23 minuti, «Supper’s Ready». La presenza della musica classica come influenza diretta o come semplice (si fa per dire) citazione all’interno di brani originali proseguirà in diversi successi degli anni successivi all’era del rock «prog». Uno degli esempi più noti è certamente il repertorio dei Queen, intriso di passaggi musicali ispirati soprattutto all’opera classica. Al di là di evidenti echi noti a tutti come quelli che costituiscono la struttura musicale ed il cantato di uno dei più grandi capolavori della band, «Bohemian Rapsody», la lirica è protagonista in una citazione palese con la performance canora di Freddie Mercury. Le prime battute di «It’s a hard life» altro non sono che una reinterpretazione della melodia di «Vesti la giubba», aria famigerata de «I pagliacci» di Ruggero Leoncavallo. Anche Sting, in un successo scritto durante l’era della perestrojka di Gorbaciov, si produsse in una citazione «sotto traccia» in «Russians» (1985). Sotto il cantato è infatti presente una linea melodica fedelmente ripresa dal tema «Romanza» tratta dall’opera «Il luogotenente Kize», scritta per l’omonimo film sovietico da Sergej Prokofiev nel 1934. Anni più tardi sarà un’altra popstar britannica a riprendere Prokofiev in una delle sue hit più famose degli ultimi anni. In «Partying like a russian», Robbie Williams propone l’inserimento di uno stralcio della «Danza dei cavalieri» tratta dall’opera del 1935 «I Montecchi e i Capuleti». Frédéric Chopin sarà invece il protagonista della citazione di una delle più importanti band degli anni Novanta, i Radiohead, che nel loro album più famoso, «Ok computer» del 1997 si ispirano esplicitamente al «Preludio in Mi minore», dall’opera 28 - n.4 con un arrangiamento folk-grunge fatto dall’accompagnamento di chitarra acustica e la linea melodica cantata. Così come Chopin, anche Beethoven fa la sua comparsa in un brano di uno dei gruppi-rivelazione degli ultimi anni, i 21 Pilots. Il duo nato in Ohio nel 2009 «rappa» sulla «Sonata al chiaro di luna» che lega il parlato e il beat di batteria e percussioni in «Neon gravestones», mentre il «canone di Pachelbel» di cui abbiamo parlato più sopra ritorna in «Memories» dei Maroon Five. Il tempo a disposizione di Takahiro, reduce da una lunga tournée nel suo Giappone, sta per finire e quando ormai è agli sgoccioli ci tocca tornare di nuovo con la mente alle origini del rock, perché ci ricordiamo che Elvis Presley uscì con un grandissimo successo che era ripreso da un brano classico. Nel 1961 usciva «Can’t help falling in love» e quella hit che consumò i juke box e fece innamorare le coppie che la ballavano guancia a guancia era nata in verità nel 1785 dalla mente di Jean-Paul-Egide Martini. «Plaisir d’amour» fu una composizione che piacque particolarmente alla regina Maria Antonietta di Francia. Alla fine ci ricordiamo anche che un «lento», di quelli che chiudevano le serate nelle discoteche degli anni Settanta, ci fu regalato da Rachmaninoff. «All by myself» di Eric Carmen attingeva a piene mani e riprendeva il “Concerto per pianoforte n.2 in do minore». L’ultimo nostro pensiero è per Lady Gaga, che omaggia i classici senza interferire. Takahiro mi ricorda che nel video ufficiale di «Marry the night», per circa un quarto d’ora le crude scene del ricovero in psichiatria della protagonista (Lady Gaga stessa) sono accompagnate dalle note drammatiche ed incalzanti della sonata per pianoforte «Patetica» di Beethoven. Takahiro Yoshikawa, pianistaMilanese d’adozione, Takahiro Yoshikawa divide la sua attività di concertista tra l’Italia e il natio Giappone. A Tokyo si è diplomato e dottorato in pianoforte presso l’Università delle Arti di Tokyo, a Milano ha proseguito i suoi studi con insegnanti come Anita Porrini e Silvia Bianchera Bettinelli, frequentando l’Accademia Teatro alla Scala. È impegnato in una intensa attività concertistica e discografica in Italia e in Giappone come solista e in formazioni cameristiche. Numerose le sue esibizioni al Teatro alla Scala e in concerti con i Solisti della Scala. Suona in duo da più di 15 anni con il primo clarinettista solista del Teatro alla Scala Fabrizio Meloni con cui tiene anche varie Masterclass. Ha ricevuto numerosi premi internazionali. Per seguirlo il suo sito web ufficiale è www.takahiroyoshikawa.com
Ditonellapiaga e Tony Pitony si esibiscono sul palco del teatro Ariston (Ansa)
La serata delle cover, con i duetti tra concorrenti e ospiti, è la più attesa del Festival. A incuriosire sono gli abbinamenti e la scelta dei brani. L’Ariston risponde con entusiasmo: tra omaggi, energia e qualche azzardo, ecco le pagelle della serata.
Elettra Lamborghini con Las Ketchup 6,5 Aserejé, tormentone primi Duemila, è perfetta per tenere vivo il clima di festa creato dal medley di Laura Pausini. L’Ariston ha voglia di divertirsi. Fasciate in uno sgargiante abito lungo trasmettono spensieratezza. Frizzanti.
Alessandro Siani 6,5 Arriva da Napoli, come cinque dei cantanti in gara e chissà se c’entra la caccia all’audience. Il ping-pong con Carlo Conti sui motivi, istituzionali e giocosi, perché Sanremo è Sanremo è una bella idea, ma è appena abbozzata. Timido.
Bianca Balti 8 Un anno dopo, con i capelli, elegante e sorridente. «Sono qua per godermela, non solo per me, ma per tutte le persone che hanno sofferto come me». E «sono innamoratissima». Entusiasta.
Malika Ayane con Claudio Santamaria 4,5 Quando si sceglie Mi sei scoppiato dentro il cuore di Mina bisogna pensarci 10 volte. Inevitabile balzi all’orecchio ciò che manca. E lo scoppio floppa. Temerari.
Bambole di pezza con Cristina D’Avena 6 per l’impegno Sembrano copiare i Maneskin senza riuscirci e questo la dice tutta. Infatti, il meglio lo danno quando citano Whole lotta love dei Led Zeppelin. Ma perché non hanno proposto quella? Confuse.
Tommaso Paradiso con Stadio 7,5 Una sferzata di rock visionario e apocalittico atterra all’Ariston con L’ultima luna di Lucio Dalla. Gaetano Curreri non ha la voce giusta, Tommaso sì. Di culto.
Michele Bravi con Fiorella Mannoia 5 Per la scelta di Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni vale quanto detto per il brano di Mina: si sente il vuoto. Non c’è il carisma, non c’è la drammaticità, non c’è la voce piena dell’interprete originale. Pazienza.
Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & The Band 8,5 Il figlio d’arte cresce e si muove meglio ogni sera. Figurarsi se spunta papà Gianni che Vita la cantava con Lucio Dalla. Chissenefregadeimoralisti.
Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas 8 la voce di Colombre si avvicina a quella di Jimmy Fontana di Il mondo e il confronto con una delle più belle canzoni della musica italiana non è penalizzante. Plausibili.
Fulminacci con Francesca Fagnani 6,5 Qui è più teatro che musica, ma citare Mina e Alberto Lupo di Parole parole dà i brividi. Si può accettare solo in un copione scanzonato e autoironico. Coraggiosi.
LDA e Aka 7even con Tullio De Piscopo 7,5 A 80 anni l’energia e il feeling di De Piscopo sono intatti. E fa tutta la differenza cantare la cover con il suo inventore. L’Ariston continua a fare festa. Andamento veloce.
J-Ax con Ligera County Fam 8 All star de Milan: Cochi Ponzoni (senza Renato Pozzetto) Paolo Rossi, Paolo Jannacci, Ale & Franz accompagnano il rapper. Felicemente sgangherati.
Ditonellapiaga con Tony Pitony 8,5 Parrucca rosa e maschera di plastica. Cabaret anni Quaranta, jazz americano, Broadway, Quartetto Cetra. Con The Lady is a tramp un’altra scarica di energia. E si balla.
Caterina Caselli 9 Emozionata. Ancora con la sua voce metallica e contundente. Non smette di ringraziare le persone dalle quali ha imparato. Interprete, scopritrice di talenti, produttrice discografica, artista completa. Magnetica.
Continua a leggereRiduci
I veicoli dei talebani controllano la sicurezza a un posto di blocco vicino al confine tra Pakistan e Afghanistan a Nangarhar (Ansa)
L’aviazione pachistana la settimana scorsa aveva condotto una serie di attacchi aerei in Afghanistan, colpendo alcuni campi di addestramento per terroristi. Il bilancio era stato di 18 morti e 7 feriti secondo il governo talebano, che aveva convocato l'ambasciatore del Pakistan a Kabul. Era così iniziata quella che in gergo si definisce come una guerra a bassa intensità con continue «scaramucce» sul confine che avvevano comunque provocato morti e feriti. Il governo del primo ministro Shehbaz Sharif ha deciso per un attacco in grande stile con missili terra-aria su uffici, caserme e centri di addestramento del regime talebano che non ha una contraerea in grado di difendere il territorio. Gli studenti coranici avevano «ereditato» dagli americani, al loro abbandono dell’Afghanistan, una serie di aerei ed elicotteri, molti dei quali danneggiati e ormai inservibili. Sul confine si sono moltiplicate le battaglie fra le truppe di terra, ma le cifre di morti e feriti divergono sensibilmente. Islamabad ha dichiarato di aver colpito 22 obiettivi militari e che sono stati uccisi 274 funzionari e militanti talebani. Stando a quanto dichiarato dal portavoce delle forze armate pachistane sarebbero stati solamente 12 i militari caduti negli scontri. Il ministro della Difesa dei talebani ha detto che l’aeronautica militare del ministero della Difesa nazionale ha condotto attacchi aerei coordinati contro un accampamento militare vicino a Faizabad, a Islamabad, una base militare a Nowshera, posizioni militari a Jamrud, mentre Zabihullah Mujahid, portavoce del governo talebano, ha subito indetto una conferenza stampa per annunciare che 55 soldati pachistani erano stati uccisi e 19 postazioni conquistate, mentre 8 combattenti talebani erano caduti. Numeri ovviamente incontrollabili, ma appare difficile credere che la cadente aviazione dell’Afghanistan possa aver ottenuto questi risultati. Zabihullah Mujahid, ha aggiunto di voler subito ricorrere al dialogo per risolvere il conflitto con il vicino Pakistan, sottolineando la necessità di una soluzione pacifica e continuando a sperare che il problema venga risolto senza altra violenza. Il portavoce talebano ha respinto le accuse di Islamabad di essere coinvolti negli attacchi terroristici, rispondendo che sono invece loro che sostengono lo Stato islamico che combatte, sotto il nome di Isis K, per abbattere l’emirato dei talebani. Se proseguisse, lo scontro militare sembrerebbe avere un esito certo, perché le forze armate pachistane dispongono di oltre mezzo milione di uomini e di una forza aerea efficiente, oltre ad un arsenale atomico. L’Afghanistan dichiara di avere 150.000 combattenti, ma non si tratta di un vero e proprio esercito, bensì di milizie abituate soltanto alla guerriglia irregolare. Il fronte però è più ampio di quello che potrebbe sembrare perché il ministro della Difesa di Islamabad ha accusato l’India di avere influenza politica sui talebani. Nuova Delhi ha respinto le accuse, denunciando un piano pachistano per destabilizzare il subcontinente indiano. La Cina e la Russia, unica nazione che ha ufficialmente riconosciuto l’emirato dell’Afghanistan, sono al lavoro per una soluzione diplomatica di un conflitto che potrebbe destabilizzare l’intera Asia centrale.
Continua a leggereRiduci
Matteo Del Fante (Ansa)
L’amministratore delegato sorride tra numeri e strategie, mentre la stima per il 2026 promette ulteriori crescite: «Abbiamo rafforzato la nostra politica dei dividendi», dice, e non è un dettaglio da poco: la cedola proposta sale del 16%, arrivando a 1,25 euro per azione, a testimonianza di un’azienda che non vuole solo correre, ma premiare chi le ha dato fiducia. A dare contenuto a questo risultati soprattutto la finanza e la logistica, con il primato nella consegna dei pacchi.
Il futuro, però, non sono solo conti e percentuali: è anche digitale, innovativo e strategico. Del Fante non si limita a parlare di numeri, ma racconta un percorso di trasformazione che intreccia Poste con Tim, «una partnership che non è mirata a un guadagno immediato ma alla creazione di valore durevole e sostenibile per entrambi i gruppi». Il filo conduttore? Sinergie, integrazione e visione a lungo termine. E per dare concretezza alle parole, la riorganizzazione di gruppo in corso prevede un hub finanziario integrato, dove PostePay e BancoPosta dialogheranno fianco a fianco attraverso la fusione delle rispettive attività. Business come energia e telecomunicazioni saranno distribuiti dalla rete degli sportelli Poste. E non si tratta di semplice fantasia digitale: la nuova super-app di Poste, fiore all’occhiello del 2025, è diventata un fenomeno nazionale, con oltre quattro milioni di utenti giornalieri, la più utilizzata tra gli algoritmi proposti da un’azienda italiana. L’Intelligenza artificiale non è un concetto fumoso: Del Fante la indica come «un acceleratore di crescita chiave» del piano strategico pluriennale che verrà presentato entro il 2026, pronto a inaugurare una nuova stagione dopo nove anni di evoluzioni continue.
I numeri del bilancio restano sotto i riflettori: i ricavi di gruppo hanno raggiunto 13,1 miliardi, in crescita del 4% rispetto al 2024. Il margine operativo tocca i 3,2 miliardi, con un balzo del 10%, e l’utile netto segna 2,2 miliardi, anche questo con un +10%, in anticipo sui target del piano 2024-28. Dalle parole di Del Fante emerge che Poste non solo cresce, ma lo fa stabilmente, costruendo le basi per guardare oltre, fino al 2026: i ricavi sono previsti a 13,5 miliardi, il margine operativo superiore a 3,3 miliardi e l’utile netto (esclusa la partecipazione in Tim) a 2,3 miliardi. Anche i dividendi resteranno generosi, con una percentuale di assegnazione ai soci superiore al 70% degli utili. Da aggiungere un piccolo extra legato all’arrivo del dividendo Tim stimato in cento milioni di euro a partire dal 2027.
Proprio dal gruppo telefonico arriva una novità nella governance. Adrian Calaza, ex direttore finanziario di Tim, è il nuovo presidente di Tim Brasil dove già ricopriva il ruolo di consigliere. Prende il posto di Nicandro Durante. In consiglio entra anche Camillo Greco, direttore finanziario di Poste Italiane. Nell’illustrazione dei conti da parte di Matteo Del Fante manca, naturalmente, il capitolo «grandi manovre»: tra le priorità c’è l’acquisizione del 20% del Polo strategico nazionale da Cdp, un investimento contenuto ma strategico per supportare Tim nella migrazione della pubblica amministrazione italiana verso il cloud. Insomma, tra numeri da record e strategie a lungo termine, Poste italiane si conferma un gigante in movimento: non solo un’azienda di servizi postali e finanziari, ma un ecosistema digitale in piena espansione, pronto a cavalcare la tecnologia, l’Intelligenza artificiale e le sinergie industriali. Matteo Del Fante lo annuncia a tutta la comunità finanziaria che l’ascolta durante la conference call: il 2025 è stato eccezionale, ma l’avventura è appena all’inizio.
Il riflesso dell’uso dell’Ia si vedrà anche sul fronte dei dipendenti: le assunzioni annuali nei centri aziendali nel 2026 si stimano in calo del 15% rispetto alla media degli ultimi quattro anni. Con Tim, di cui è primo socio, Poste ha aperto vari tavoli. I risparmi attesi si aggirano sui cento milioni.
A inizio del prossimo anno, Poste attende, inoltre, completare la riorganizzazione con la creazione di un hub finanziario e la fusione di BancoPosta con PostePay. «A seguito di questa fusione deterremo il business energia e tlc a livello di capogruppo», ha detto l’ad, spiegando il progetto di creazione dell’hub finanziario. L’Intelligenza artificiale sarà cruciale nello sviluppo previsto. Nel servizio clienti ha permesso la riduzione dei costi del 30%. Sono attesi altri 30 milioni entro i prossimi quattro anni. Inoltre, sono stimati fino a circa 100 milioni di euro di risparmio annuo sui costi It.
Continua a leggereRiduci