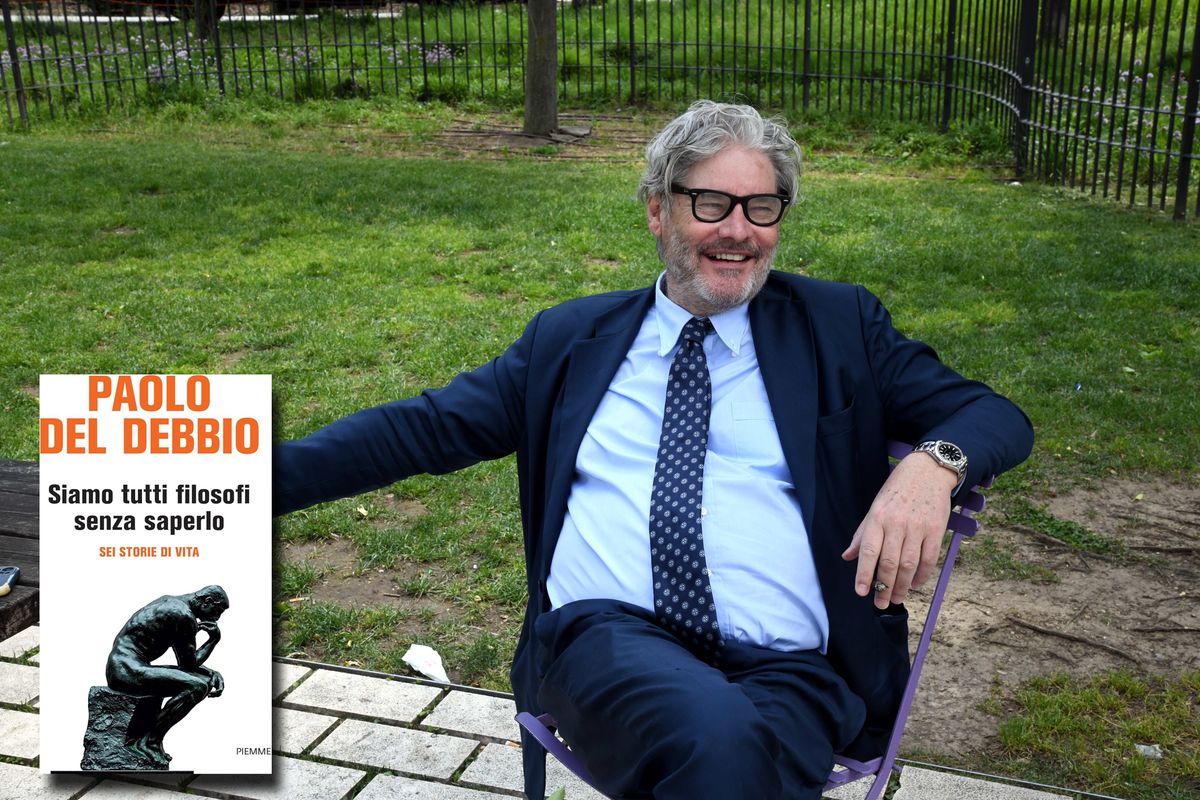
«Prenderla con filosofia». Difficilmente ho incontrato un’espressione più sbagliata ed infelice di questa. Nell’uso comune viene detta di qualcuno che è afflitto da un problema, un dubbio, un qualcosa che non lo lascia né indifferente né tranquillo. In questi casi «Prenderla con filosofia», sempre nell’accezione comune, vuol dire «prenderla con leggerezza», «non farne un problema», «farselo scivolare addosso». Insomma, un invito alla leggerezza, alla spensieratezza, alla frivolezza; in definitiva alla superficialità. Un invito a non rifletterci troppo su, a non cercare spiegazioni difficili, complesse. «Se puoi, fregatene, se ce la fai, infischiatene. Se non è proprio importante vedi di fottertene».
Ecco, se qualcuno pensasse che questo sia l’atteggiamento giusto nei confronti della vita sappia che ha in mano il libro sbagliato. E che la filosofia non fa per lui.
Primariamente, perché la filosofia è l’esatto contrario di tutto ciò: la filosofia non vive sulla superficie della vita ma vive nella profondità della mente e dell’anima. La filosofia approfondisce, domanda di continuo, senza sosta, indaga sulle cause di quello che succede, sui motivi di ciò che circonda l’uomo e nel quale l’uomo è immerso, non si accontenta mai, tende ad andare sempre oltre anche se ha raggiunto dei traguardi, che, comunque, rimandano sempre e inesorabilmente ad altri traguardi ad altre mete. Se trova qualcosa che può essere descritto come una verità, come un principio, volge il suo sguardo altrove, dove non ha ancora indagato, in quei territori della vita e della mente, che non sono ancora passati al suo vaglio, entro la sua incessante ricerca.
Secondariamente, non solo perché qui si sostiene il contrario dell’affermazione che abbiamo preso in considerazione, ma perché, ben oltre, pensiamo che ognuno, e non solo il filosofo «di professione», (e certo non tutti) nella sua vita, fa delle riflessioni su quanto gli succede e si forma delle idee, un pensiero proprio che, come vedremo, è spesso molto vicino al pensiero filosofico di alcuni autori dei quali nemmeno conosce l’esistenza.
Si trovano tracce di filosofia nel pensiero di quasi tutti gli uomini. Proviamo a dimostrarlo in questo libro a proposito di sei temi della filosofia: il bene, il tempo, la persona, la coscienza di sé e l’autocoscienza, la morte, Dio. All’inizio di ogni capitolo porremo sinteticamente i termini del perché quel tema costituisca un problema per la filosofia; poi seguirà un racconto nel quale uno o più soggetti si troveranno a confrontarsi con quel problema; in fine, mostreremo come quei pensieri emersi in quelle storie di vita (6 come i capitoli) siano emerse consonanze, affinità, analogie e corrispondenze col pensiero di uno o più filosofi dei quali i soggetti delle storie non erano a conoscenza.
[…] Quando si fa filosofia, quando si discute di filosofia, non si può appellarsi a qualche autorità esterna, naturale o soprannaturale, si può discutere, argomentare solo ricorrendo alla ragione, al suo sviluppo nel ragionamento. Di fronte ad un ragionamento di un soggetto si può discuterne, metterne in discussione la razionalità, la verità che l’altro che si oppone al nostro è irrazionale, illogico, falso. In questo senso ciò che conta non è imparare la filosofia, ma imparare a filosofare: verificare se il ragionamento altrui - e anche il proprio, ovviamente - sono conseguenti, cioè seguono un filo logico e non fanno dei salti; la ragione filosofica non procede per salti, ma per passi successivi, uno dopo l’altro, in modo che ciò che viene affermato prima sia coerente logicamente con quello che affermo dopo, e viceversa.
Se, ad esempio, affermo che nella vita non ci devono essere regole, poi non posso affermare che tutti non devono avere regole perché mi contraddico: se nella vita non ci devono essere regole non posso desiderare di imporlo a tutti perché questo sarebbe una regola. Solo un esempio di un «salto» filosofico. In filosofia non si salta, questo è ragionare, si cammina, questa è la regola primaria del ragionamento e anche dell’opporre un ragionamento ad un altro.
[…] La filosofia è anzitutto domanda; chiede: «Perché?». Nel chiedere perché si è già entrati nella riflessione filosofica. Ogni volta che l’uomo chiede perché sulle questioni più generali della vita e del tutto entra nella porta al di là della quale c’è la filosofia. Si può ovviamente rinunciare a farsi domande e vivere una vita che sfugge a tutte le forze di coinvolgimento emotivo, razionale e di ogni altro tipo, ma questo cos’è se non rinunciare alla vita stessa?
Mancanza di azione, incomunicabilità, stasi totale, estrema, assoluta. Esattamente come nella pièce teatrale Aspettando Godot di Samuel Beckett (1906-1989), scrittore e drammaturgo inglese, dove due uomini, Vladimiro ed Estragone aspettano l’arrivo di un terzo uomo di nome Godot che, però, non arriverà mai. Non si sa chi siano questi due uomini che parlano attraverso dialoghi totalmente paradossali, dove si trovano, chi sia questo Godot e perché lo stiano aspettando. Tutto perché non sembra interessare ai due personaggi e non hanno nessuna risposta. Insensatezza della vita umana e frustrazione data dal continuo e altrettanto fallimentare tentativo di muoversi dei due personaggi. Mancanza di un perché che si trasforma in una mancanza di vita, da vivi. Vivi senza vita. Vivi senza perché. È il teatro dell’assurdo che rappresenta l’assurdo di una vita senza perché, perché il perché non c’è.
Gianni Rodari, uno scrittore per l’infanzia, ha sostenuto che «il gioco dei perché è il più vecchio del mondo. Prima ancora di imparare a parlare l’uomo doveva avere nella testa un gran punto interrogativo». In un suo libro Il libro dei perché ha scritto La Storia di un perché, che ci aiuta a capire la natura dei perché.
Una volta c’era un Perché, e stava in un vocabolario della lingua italiana a pagina 819. Si seccò di stare sempre nello stesso posto e, approfittando della distrazione del bibliotecario, se la diede a gambe, anzi «a gamba», saltellando sulla zampetta della «p». Cominciò subito a dar fastidio alla portiera.
- Perché l’ascensore non funziona? Perché l’amministratore del condominio non lo fa riparare? Perché non c’è la lampadina al pianerottolo del secondo piano?
La portiera aveva altro da fare che rispondere a un Perché tanto curioso. Lo rincorse con la scopa fin sulla strada e gli ingiunse severamente di non tornare più.
- Perché mi cacci? - domandò il Perché molto indignato: - Perché ho detto la verità?
Se ne andò per il mondo, con quel brutto vizio di fare domande, curioso e insistente come un agente delle tasse.
- Perché la gente butta la carta per terra invece di metterla negli appositi cestini?
- Perché gli automobilisti hanno tanto poco rispetto dei poveri pedoni?
- Perché i pedoni sono tanto imprudenti?
Non era un Perché: era una mitragliatrice di domande e non risparmiava nessuno [...]. La Questura venne a sapere che c’era un Perché così e così, alto tanto e non di più, fuggito dalla pagina 819 del dizionario. Fece stampare la sua fotografia e la distribuì a tutti gli agenti, con questo ordine: «Se lo vedete, arrestatelo e mettetelo al fresco» (e fa affiggere manifesti). «Perché - si domandava il povero Perché, succhiandosi il dito sotto uno di quei manifesti, - perché vogliono mandarmi al fresco? Forse non bisogna fare domande? La legge punisce i punti interrogativi?». Cerca e cerca, nessuno riuscì mai a trovarlo. Ad arrestarlo, poi, non ci riuscirebbero tutte le guardie del mondo, che sono milioni e parlano molte lingue. Si è nascosto tanto bene il nostro Perché: un po' qui e un po' la, in tutte le cose. In tutte le cose che vedi c’è un Perché». Il Perché è insopprimibile, se lo scacci ritorna ancora più imperioso che prima. Se venisse da fuori dell’uomo, forse sarebbe anche scacciabile, ma questo Perché non viene fuori dall’uomo ma da dentro di lui ed allora l’impressione di scacciarlo diventa più complessa, anzi, impossibile. Dice bene il nostro Rodari: «Si è nascosto bene il nostro Perché: un po' qui un po' la, in tutte le cose. In tutte le cose che vedi c’è un Perché». […]






