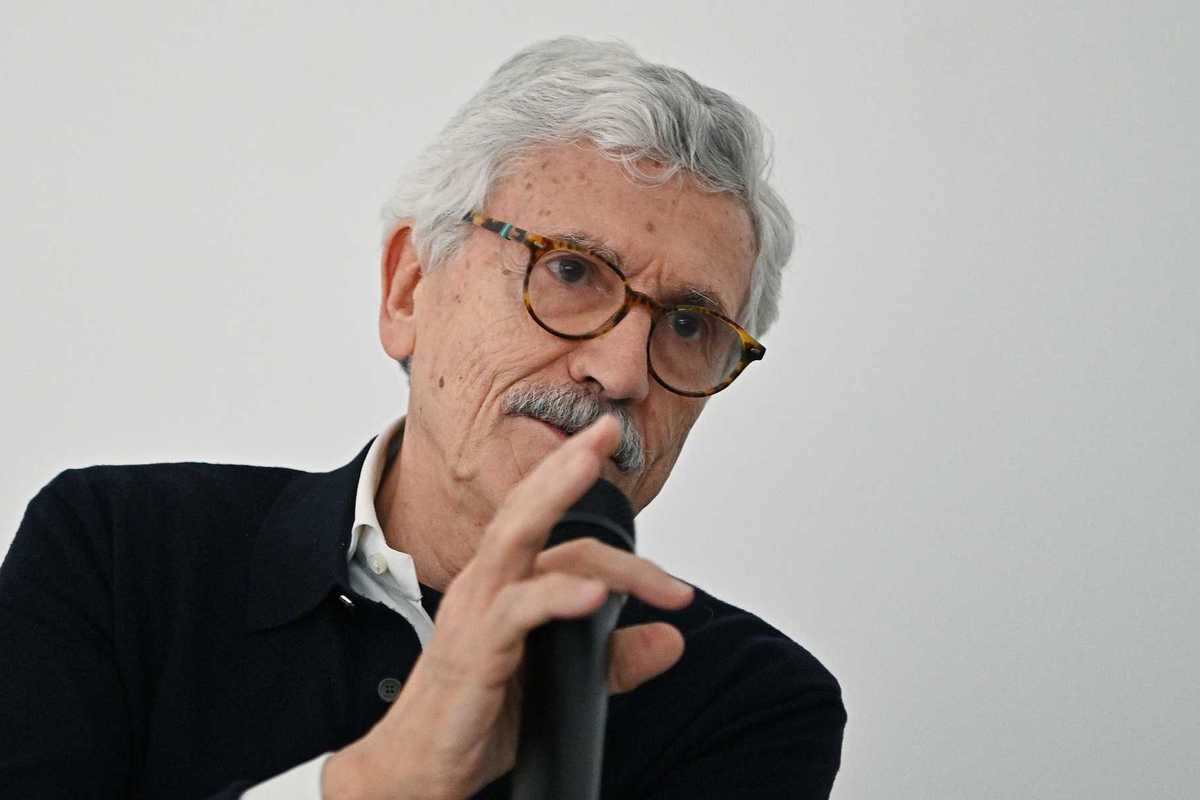Pezzi di ghiaccio. Come dissetarsi e sorridere nei giorni della grande calura

Eccoci nel periodo dell’anno nel quale il nostro elemento preferito è... il ghiaccio. Mettiamo l’acqua nella vaschetta per cubetti di ghiaccio che poi poniamo in congelatore e quando il ghiaccio è pronto mettiamo i cubetti nelle bibite, anche se si affermano sempre più i cubetti di plastica dalle forme più disparate ripieni di liquido refrigerante. Sfruttiamo il ghiaccio per conservare in fresco la bottiglia di champagne o vino nel cestello e lo usiamo, questo in qualunque stagione, nella borsa del ghiaccio, per calmare infiammazioni e dolori di origine traumatica o abbassare la febbre. Ma c’è anche un uso precisamente alimentare del ghiaccio che lo trasforma nell’ingrediente insostituibile di una delle preparazioni che, in queste settimane, ci aiuta a sentire meno caldo: la granita.
Il sostantivo femminile granita è il participio passato del verbo «granire», che si è sostantivizzato in riferimento all’aspetto tipico dei grani di ghiaccio nella preparazione appunto chiamata granita. La Treccani online spiega che la granita è un «tipo di sorbetto, fatto con soluzioni zuccherine aromatizzate con limone, caffè, succhi di frutta, e agitate durante il congelamento in modo da ottenere una massa pastosa formata di tanti minutissimi cristalli ghiacciati». Nel Bacco in Toscana Francesco Redi, nel 1685, esalta il ghiaccio: «Son le nevi il quinto elemento, / Che compongono il vero bevere: / Venga pur da Vallombrosa / Neve a iosa: / Venga pur da ogni bicocca / Neve in chiocca; / E voi, Satiri, lasciate / Tante frottole e tanti riboboli, / E del ghiaccio mi portate / Dalla grotta del monte di Boboli. / Con alti picchi / De’ mazzapicchi / Dirompetelo, / Sgretolatelo, / Infragnetelo, / Stritolatelo, / Finchè tutto si possa risolvere / In minuta freddissima polvere, / Che mi renda il ber più fresco / Per rinfresco del palato, / Or ch’io son morto assetato».
In questo noto ditirambo il letterato aretino, biologo, naturalista, membro dell’Accademia della Crusca e medico di corte al servizio di Cosimo III de’ Medici tesse un elogio del vino a tutto tondo, lodando anche il ghiaccio. Sempre Francesco Redi ne L’Arianna inferma, altro componimento (non terminato) del 1687, redige un altro elogio del ghiaccio dolce e frullato che chiama «la rugiada congelata di sorbetto» e fa dire alla fanciulla che lo mangia: «oh come scricchiola tra i denti e sgretola; / quindi dall’ugola giù per l’esofago / freschetta sdrucciola fin nello stomaco. / E l’arse viscere / con giusta tempera / tutte contempera / quella che qual nevischia congelata / su gli orli delle tazze alzasi in monti / e costante in se stessa e benguardata / del Sol più caldo sa schermir gli affronti».
Non è un caso la perifrasi «nevischia congelata» per intendere questo ghiaccio trito e dolce. In seguito, si differenzierà con maggiore precisione tra granita e sorbetto (e poi gelato), ma a prescindere dalla denominazione la prassi di addolcire la neve ghiacciata o il ghiaccio per poi mangiarli è antichissima.
Granita, cremolata, grattachecca, ghiacciolo e sorbetto non sono la stessa cosa (e meno che mai sono uguali al gelato) e la differenza tra le varie preparazioni è data innanzitutto dall’uso di frutta in polpa oppure in succo (ma si può usare anche caffè), poi dal quantitativo di zucchero, poi dalla consistenza del ghiaccio e poi dalla presenza di altri ingredienti, come il bianco d’uovo nel sorbetto spongato o il latte e l’uovo nel gelato. Per preparare una granita, infatti, si miscelano acqua, zucchero e succhi di frutta. Si mettono a congelare raschiando man mano ma in maniera discontinua il ghiaccio che si cristallizza. La caratteristica texture della granita prevede i grani, appunto, di ghiaccio. E si ottiene con un congelamento abbastanza lento, la discontinuità del raschiamento e l’incorporamento di meno aria possibile. Il contenuto in saccarosio di una granita è tra 20 e 35%.
Non c’è solo la granita, abbiamo detto. C’è la cremolata. Chiamata anche gramolata, è molto simile alla granita. La differenza sostanziale sta però nella frutta, che qui si usa in forma di polpa e nella percentuale minima dell’80%, che determina una percentuale di zucchero aggiunto minore di quella della granita. La cremolata, poi, si ottiene, sottoponendo l’impasto a un continuo mescolamento specifico per incorporare più aria possibile e ottenere una granulometria dei cristalli di ghaccio inferiore a quella della granita. C’è poi la grattachecca, tipica della zona di Roma, anche detta ghiacciata o granatina. Si fa con gli stessi ingredienti della granita, quindi zucchero e frutta a creare uno sciroppo (ma si usa anche caffè) e ghiaccio. Però, il ghiaccio non è il punto di arrivo, è quello di partenza. Il blocco di ghiaccio, detto «checca», viene raschiato con un raschietto apposito, chiamato anche pialla. Il trito di ghiaccio ottenuto in questo modo viene poi posto nel bicchiere e infine aromatizzato con sciroppi, frutta o entrambi, in accostamenti abbastanza originali.
Il ghiacciolo si può considerare una granita da passeggio, all’inglese diremmo granita on the go, che si fa ghiacciare intorno a un bastoncino proprio come come si fa col gelato su stecco. Da sempre, l’uomo beve e «mangia» il ghiaccio aromatizzato. Che nella Bibbia Isacco suggerisca ad Abramo di riprendersi dalla calura con latte di pecora e ghiaccio, notizia che si trova un po’ ovunque sul web, pare essere una fake news, non risultando affatto queste parole se si fa una ricerca nel testo sacro in questione. Ma se ci fossero sarebbero veritiere, perché la neve o il ghiaccio aromatizzati si mangiavano già nell’antichità, in Cina o, per riferirci a siti più vicini, in Grecia e nella Roma dell’Impero. Si raccoglieva, trasportava e ammassava la neve dentro le cosiddette neviere perché, con la pressione, il tempo e la temperatura, si trasformasse in ghiaccio. Altra modalità di conservazione del ghiaccio era la ghiacciaia, costruzione nella quale si stipava il ghiaccio formatosi naturalmente, per esempio dalla ghiacciatura invernale di fiumi limitrofi. Entrambe le soluzioni di stipaggio si sviluppavano sottoterra per sfruttare la frescura e l’umidità del terreno sotto il livello del mare, proprio come le cantine. Ma dovevano essere assai più profonde delle cantine.
Dai blocchi di ghiaccio di neviera o di ghiacciaia, inframmezzati da paglia per essere più facilmente maneggiabili e manipolabili, alla bisogna si tagliavano blocchettini che si usavano per uso medico, principalmente. Ma, in estate, anche per rinfrescare il vino, come declamavano i versi di Francesco Redi, per confezionare sorbetti e poi, col tempo, i gelati propriamente detti. Il blocco di ghiaccio è un must della refrigerazione prima dell’elettricità e lo stesso frigorifero nasce con esso: i primi frigoriferi per casa dell’inizio del Ventesimo secolo erano infatti strumenti meccanici, non ancora elettrici, si chiamavano frigoriferi a ghiaccio anche detti ghiacciaie ed erano, in sostanza, dei piccoli armadi nei quali si infilava un bel blocco di ghiaccio preso in ghiacciaia o neviera. Col tempo, si afferma anche il passaggio dalla granita fatta con ghiaccio grattugiato da un blocco e mescolato all’aroma a quella fatta congelando direttamente uno sciroppo di acqua a temperatura ambiente e zucchero, poi aggiunto agli aromi.
La granita fatta così, grattugiando il ghiaccio come ancora si fa nella grattachecca romana, in Sicilia si chiamava rattata, cioè grattata. La granita grattata è un po’ la norma ovunque fino al Sedicesim secolo, quando si scopre che unendo il sale alla neve si ottiene un composto eutettico che, cioè, ha un punto di fusione più basso di quello che possiedono singolarmente le sostanze che lo compongono. La miscela di ghiaccio e sale, H2O allo stato solido e NaCl (il cloruro di sodio è il sale sodico dell’acido cloridrico ed è il costituente principale del comune sale da cucina, per antonomasia detto semplicemente sale) appartiene alla categoria delle «miscele frigorifere»: il ghiaccio fonde a 0°C, il sale a 804°C, ma la loro miscela fonde a -21,3°C.
Cosa c’entra il punto di fusione col congelamento? Come spiega Wikipedia alla voce «miscele frigorifere», la fusione «è un processo endotermico, cioè richiede calore dall’ambiente circostante». La miscela di sale e ghiaccio contiene due fasi solide, il sale e il ghiaccio, e una liquida, cioè la soluzione formata dal sale disciolto nella piccola quantità di acqua presente.
Siccome queste tre fasi non possono contemporaneamente coesistere a temperatura ambiente, per essere in equilibrio il sistema comincia a formare una fase liquida col ghiaccio che fonde sciogliendo il sale. Il calore necessario per fondere il ghiaccio viene preso dalla miscela che, quindi, passa da 0 a -21,3 °C, ghiacciando la granita, il sorbetto, il gelato cui si avvicina. Il valore eutettico, -21,3 °C, è mantenuto finché non viene fuso tutto il ghiaccio o sciolto tutto il sale, qualche ora. Oggi esistono due tipi di gelatiere: quelle con ciotola da congelare autonomamente, di solito inserendola nel freezer, e poi montare sulla gelatiera che mescola e quelle con motore refrigerante che congelano mentre mescolano. Queste gelatiere (che naturalmente si usano anche per fare granite e sorbetti) funzionano raffreddando la mescola che al contempo girano con una pala anch’essa elettrica, perché la mescola si geli senza creare grossi cristalli di ghiaccio. Anche la protogelatiera funzionava così, ma - attenzione - il raffreddamento della ciotola era ottenuto chimicamente, per contatto con la miscela refrigerante! Questa affascinante protogelatiera si chiamava pozzetto ed era composta da un tino di legno contenente un secchiello (prima di terracotta, poi di ceramica, infine di zinco) di diametro inferiore, il cui contenuto poteva essere girato con un mestolo o tramite una manovella apposita. Nell’intercapedine tra secchiello e tino si poneva la famosa miscela refrigerante di ghiaccio e sale e in poche ore la mescola nel secchiello si gelava.
Apprezziamo e sorbiamo granite dalla cima dello Stivale fino all’ultimo centimetro del suo tacco e della sua suola, ma se c’è una regione italiana protagonista delle granite, caratterizzata da un’affinità decisamente elettiva con questo mangia e bevi fresco fresco, forse anche per via del clima molto caldo (la granita si mangia anche a colazione) è sicuramente la Sicilia. Essa ha ben quattro P.a.t. cioè Prodotti agroalimentari tradizionali, che sono granite: il Gelo di melone, la Granita di gelsi neri, la Granita di mandorla e la Scursunera cioè la granita di gelsomino e cannella.