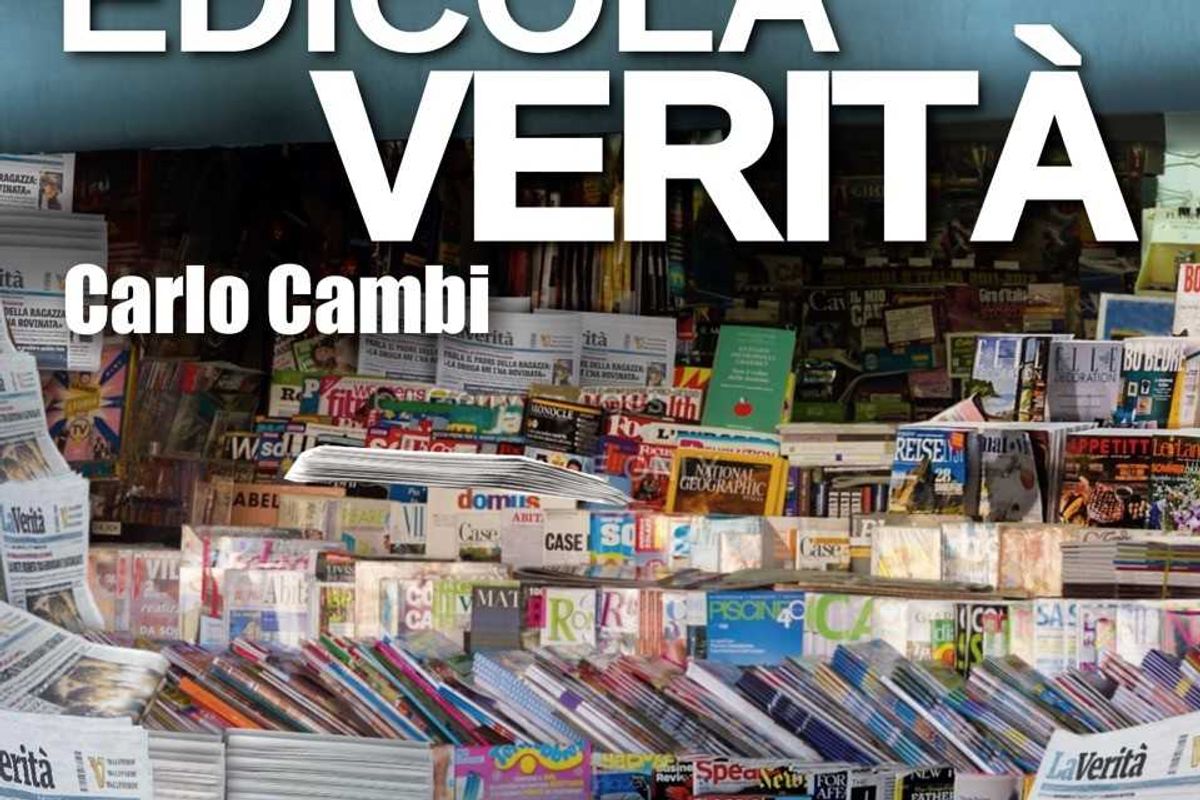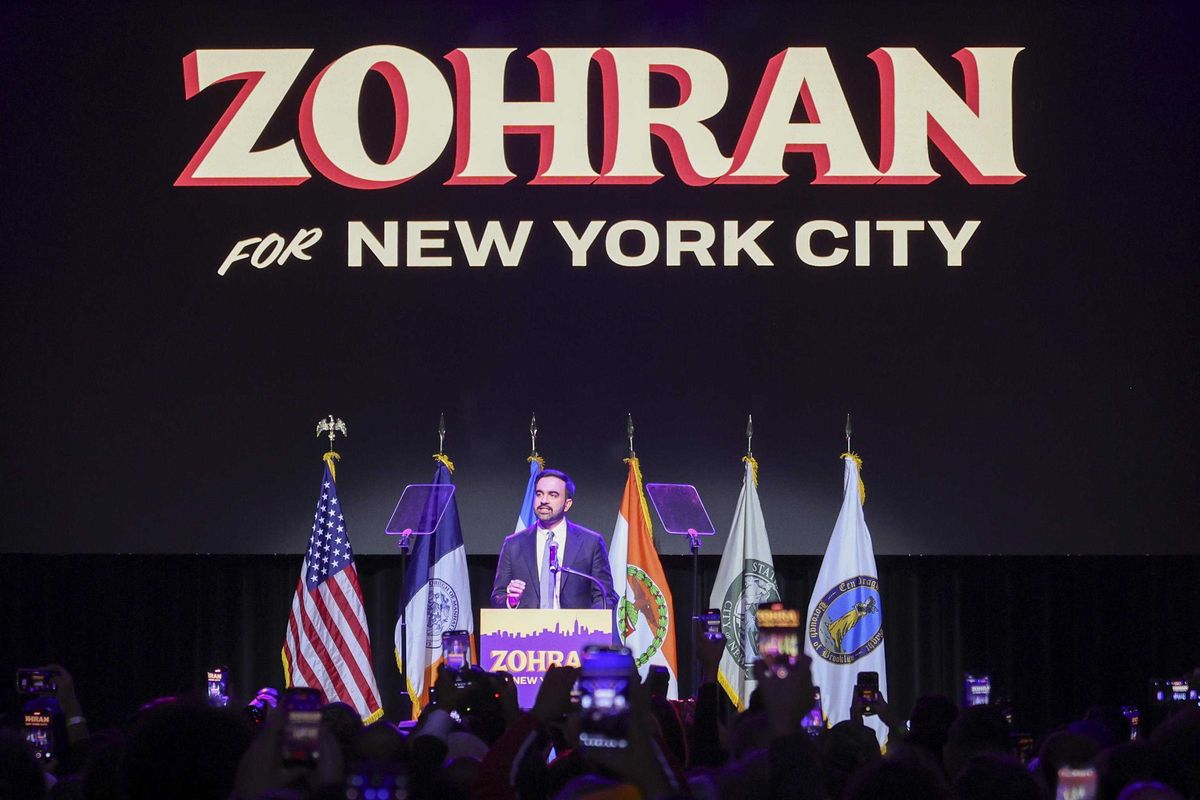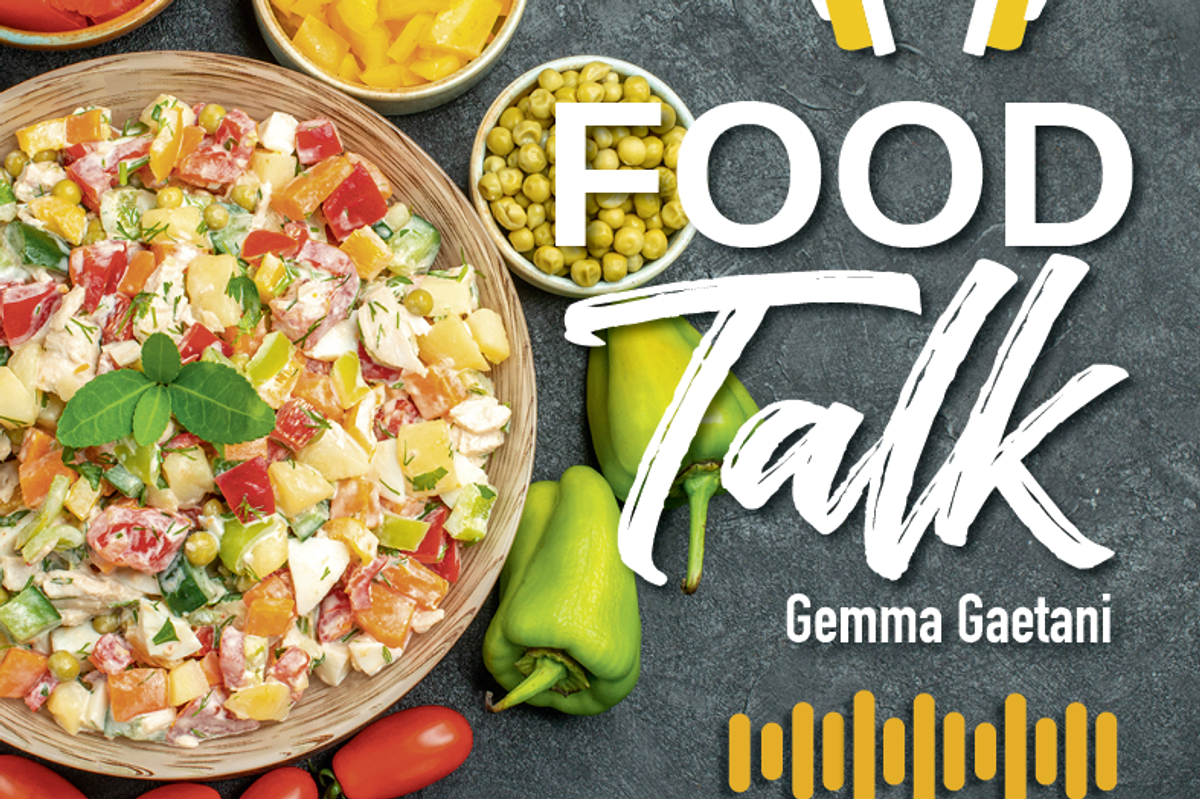2020-06-03
Perfino i giuristi non digeriscono le scelte di marketing della Cartabia
Elisabetta Casellati, Marta Cartabia e Luigi Di Maio (Ansa)
Il professor Massimo Luciani della Sapienza è critico sull'apertura della Corte alla società civile, una svolta «pop» strategica per la corsa al Quirinale: «Così il conflitto sociale penetra nella Consulta, incapace di gestirlo».Quando si è insediata alla Corte costituzionale, Marta Cartabia è stata lodata da un coro di voci «femministicamente corrette», che all'unisono plaudivano al suo discorso sul «tetto di cristallo», rotto dalla prima donna a capo della Consulta. Ora, però, tra gli addetti ai lavori cominciano a serpeggiare i dubbi.Ne è spia un dibatto organizzato via Web dall'Università di Milano e trasmesso alcuni giorni fa da Radio radicale: Invito a Corte, ma... «con juicio». Significativo che, a moderare lo scambio di vedute sul «nuovo corso» imposto dalla Cartabia - oltre che a doversi intestare una difesa d'ufficio delle innovazioni introdotte collega - ci fosse il giudice costituzionale Nicolò Zanon.Sul banco degli imputati, la decisione, risalente allo scorso gennaio, di aprire la Corte all'ascolto degli amici curiae, cioè «le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi» e attinenti alla questione di costituzionalità che sia oggetto di uno specifico giudizio. Quella che, con abile operazione di marketing mediatico, la Consulta aveva definito «apertura alla società civile». Nel corso del seminario online, una critica tranciante è arrivata dal professor Massimo Luciani, ordinario di istituzioni di diritto pubblico alla Sapienza di Roma, già presidente dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, componente del seminario permanente della Corte dei conti e membro del suo comitato scientifico. Insomma, non un pericoloso sovversivo populista e neppure un commentatore da bar. Secondo Luciani, l'apertura agli amici curiae, nella migliore delle ipotesi, rischia di rivelarsi un semplice specchietto per le allodole. Ma nel peggiore scenario, può essere addirittura perniciosa. Per metterla nei termini dell'uomo della strada: una cosa inutile nonché dannosa. Il giurista ha osservato che il ricorso agli amici curiae non è una soluzione per far conoscere la Consulta all'esterno: i soggetti ammissibili sono già al corrente delle sue prerogative e del suo funzionamento. Ugualmente, sulle «formazioni sociali» chiamate a raccolte dai magistrati supremi e sulle istanze di cui esse si fanno promotrici, tutti i protagonisti del giudizio e il pubblico sono già informati. Viceversa, ha messo in guardia Luciani, dal processo potrebbero rimanere fuori «i soggetti veramente deboli della società, che non hanno neanche la forza» di darsi un'organizzazione «capace di arrivare alla Corte costituzionale». Il nuovo regolamento, pertanto, offrirebbe una cassa di risonanza a interessi già ampiamente rappresentati, lasciando invece nell'ombra i pezzi più vulnerabili della nostra società: «I poveretti, l'accesso al processo costituzionale, in questo modo, non ce l'hanno lo stesso». Ma l'aspetto più demolitivo della disamina di Luciani è un altro. Così, ha lamentato il professore, «la Corte porta dentro il palazzo della Consulta il conflitto sociale» e «il conflitto economico-politico», «senza avere gli strumenti per dominarlo». Tanto più che, per come è impostata la norma, potrebbero chiedere di essere ascoltati anche «sindacati e partiti politici». Inevitabilmente, i giudici scopriranno il fianco alle strumentalizzazioni: chi la spunterà in giudizio, rivendicherà «una vittoria politica»; la parte sconfitta presenterà la sentenza come «un attentato alla Costituzione». Non serve essere scienziati del diritto per capire quali conseguenze potrebbe avere una deriva del genere sulla credibilità, sul prestigio e sull'autorevolezza dell'istituzione. È per questo che Luciani, peraltro contrario all'idea della partecipazione democratica, vera o presunta, al processo costituzionale, ha esortato i magistrati a non lasciarsi risucchiare dal «polo politico» della loro attività, bensì a limitarsi al «polo giurisdizionale». Purtroppo, negli ultimi anni, la Consulta ha battuto tutt'altra strada. E ha intrapreso il sentiero tortuoso che conduce al giudice legislatore, che da custode della Costituzione si erge a suo innovatore; alla toga la quale, di fronte alle incertezze politica, ma pure cieca dinanzi alla divisività delle questioni eticamente sensibili e all'ipotesi di non riempire certi «vuoti normativi», si sente investita del compito di creare diritto. Tutte posizioni che la Cartabia, sia pure nel suo tipico stile nebuloso, ha ampiamente argomentato.D'altronde, non passa inosservata la frecciatina lanciata dal suo relatore di laurea e presidente emerito della Consulta, Valerio Onida. Il quale, pur respingendo i rilievi di Luciani sul tema degli amici curiae, ne ha condiviso le perplessità sul coinvolgimento degli esperti nelle decisioni della Corte: «Non si sa quali e quanti» dovrebbero essere chiamati, ha commentato, paventando che si finisca per ascoltare «sempre i soliti uno o due di loro».Delle mire sul Colle della Cartabia s'è parlato a lunga sui giornali. Ma se i competenti davvero cominciassero a scaricarla, per la toga lombarda, appassionata di trekking, il Quirinale potrebbe trasformarsi in un monte Everest.
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 6 novembre con Carlo Cambi
Antonio Forlini, presidente di UnaItalia, spiega il successo delle carni bianche, le più consumate nel nostro Paese