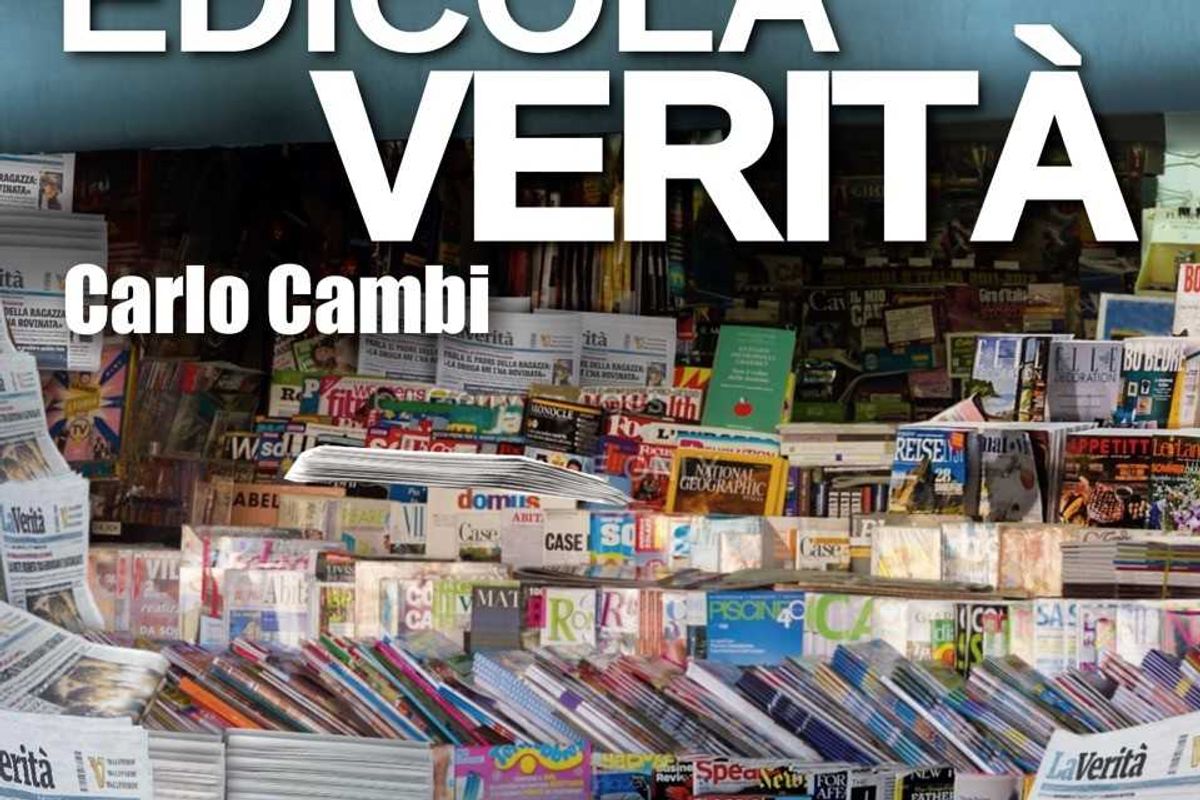La Germania ha messo nero su bianco che, sulla Bce, non intende piegarsi alla Corte Ue. Christine Lagarde si difende: «Rispondiamo alle istituzioni comunitarie». Da noi il problema non è mai nemmeno posto.Alla fine, non è mai (solo) una questione di soldi, ma di potere. O, come diceva Humpy Dumpty in Attraverso lo specchio di Lewis Carroll, «bisogna vedere chi comanda: tutto qua». Bisogna in effetti vedere chi comanda tra Unione europea e Germania, rappresentate in questo caso da Corte europea di giustizia e Corte di Karlsruhe, versione teutonica della nostra Consulta.La portata dello scontro sta in due paroline latine, con le quali le toghe tedesche - nel sintetizzare al loro Senato l'ultimatum consegnato alla Bce tre giorni fa - hanno descritto l'acquisto di titoli di Stato varato da Mario Draghi nel 2015: «ultra vires». Cioè al di fuori dei poteri statutari, «despite the Cjeu's judgment to the contrary», ovvero: «Malgrado la sentenza contraria della Corte di giustizia Ue». Ora, chiunque dicesse che un uomo è innocente «malgrado una sentenza passata in giudicato dica il contrario» porrebbe quantomeno un problema di legittimazione del sistema giudiziario. E infatti in poche ore l'intero assetto europeo è precipitato a un livello di scontro inedito perché esplicito.Il problema non è infatti che la Germania con i suoi organi di garanzia abbia di fatto rigettato (formalmente ha respinto il ricorso avverso, ma ha letteralmente messo all'angolo la Bce) il programma di acquisti: questo è storicamente sempre stato indigesto per Berlino, specie per le conseguenze sul comparto bancario e assicurativo. Il problema principale è che una sentenza ha messo nero su bianco che non c'è Corte europea che tenga, rispetto al pronunciamento. Si dovesse arrivare al dunque, che farà la Bundesbank? Ottempererà al suo mandato e al suo legame con il Paese, o riconoscerà l'autorità della Corte europea? Nel 2011, secondo il Financial Times, una Angela Merkel in lacrime scandì in uno dei vertici chiave sulla crisi greca: «Non è giusto, non posso suicidarmi. Non posso decidere io al posto della Bundesbank»: vedremo.Che la botta sia grossa, lo si vede dalle reazioni seguite al verdetto di martedì. La Bce - guidata dalla francese Christine Lagarde - e l'establishment parigino hanno risposto con stizza, appellandosi alla preminenza del diritto comunitario. Ieri l'ex capa del Fmi, che ha preso il posto di Mario Draghi , ha ribadito con forza che l'Eurotower è «un'istituzione europea con competenze sull'Eurozona. Rendiamo conto al Parlamento europeo e ricadiamo sotto la giurisdizione della Corte di giustizia europea». Il suo vice, Luis de Guindos, ha ribadito lo stesso concetto respingendo anche nel merito le posizioni tedesche.Curiosamente, il premier italiano, la Commissione Ue e Silvio Berlusconi hanno aderito alla medesima interpretazione. Poche ore dopo Karlsruhe, un portavoce di Bruxelles ha scandito: «Riaffermiamo la primazia del diritto comunitario, e il fatto che le determinazioni della Corte di giustizia europea sono vincolanti per tutte le Corti nazionali» (Anche se sancisse che l'Italia deve cambiare forma di governo, per dire?). Il premier italiano, parlando al Fatto di martedì, ha detto: «Giudico un fuor d'opera che una Corte nazionale, pur costituzionale, chieda alla Bce di giustificare la necessità degli acquisti. Non può interferire in queste iniziative». E l'ex premier azzurro non si è scostato molto, nel colloquio con Il Giornale dello stesso giorno: «Abbiamo ben presente il fatto che il diritto europeo prevale su quello dei singoli Stati».Ecco: ma è ancora così? Ovviamente la Corte tedesca non ignora che i Trattati prevedono un impegno a recepire negli ordinamenti nazionali le leggi dell'Unione. Ma da Karlsruhe in poi l'assunto non può più essere dato per scontato. Anzi, produce un attrito formidabile che, se portato alle estreme conseguenze, potrebbe determinare una disarticolazione di tutta l'eurozona.Allargando il tiro, è in ballo tutta la costruzione europea nei suoi rapporti con gli ordinamenti nazionali. La sentenza cancella l'irenismo europeista e rivela che l'Unione è una costruzione politica, non un dato che si trova in natura. La classe dirigente italiana, mediamente, ha sempre accolto come benefico a prescindere tutto ciò che promanava dalla dimensione comunitaria, ignorando le frizioni con il nostro ordinamento. Il principale azionista dell'Unione europea dice che non è disposto a farlo. Che significa? L'Ue è sovrana sulle nazioni o, per usare le parole di un membro del governo polacco, essa «dice ciò che noi, Stati membri, le consentiamo di dire?». La nostra Carta «consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni». È «parità» una situazione in cui un Paese rifiuta di subordinare i suoi giudici a quelli Ue e l'altro si adegua? Prende sempre più peso un'altra, più definitiva, domanda: «Esiste un diritto costituzionale europeo?». Era il titolo della tesi di laurea discussa da Marta Cartabia nel 1978, relatore Valerio Onida. Entrambi sono poi diventati presidenti della Corte costituzionale. I colleghi tedeschi hanno dato una risposta.
Francesco Filini (Ansa)
Parla il deputato che guida il centro studi di Fdi ed è considerato l’ideologo del partito: «Macché, sono solo un militante e il potere mi fa paura. Da Ranucci accuse gravi e infondate. La sinistra aveva militarizzato la Rai».
Francesco Filini, deputato di Fratelli d’Italia, la danno in strepitosa ascesa.
«Faccio politica da oltre trent’anni. Non sono né in ascesa né in discesa. Contribuisco alla causa».
Tra le altre cose, è responsabile del programma di Fratelli d’Italia.
«Giorgia Meloni ha iniziato questa legislatura con un motto: “Non disturbare chi vuole fare”. Il nostro obiettivo era quello di liberare le energie produttive».
Al centro Joseph Shaw
Il filosofo britannico: «Gli islamici vengono usati per silenziare i cristiani nella sfera pubblica, ma non sono loro a chiederlo».
Joseph Shaw è un filosofo cattolico britannico, presidente della Latin Mass Society, realtà nata per tramandare la liturgia della messa tradizionale (pre Vaticano II) in Inghilterra e Galles.
Dottor Shaw, nel Regno Unito alcune persone sono state arrestate per aver pregato fuori dalle cliniche abortive. Crede che stiate diventando un Paese anticristiano?
«Senza dubbio negli ultimi decenni c’è stato un tentativo concertato di escludere le espressioni del cristianesimo dalla sfera pubblica. Un esempio è l’attacco alla vita dei non nati, ma anche il tentativo di soffocare qualsiasi risposta cristiana a tale fenomeno. Questi arresti quasi mai sono legalmente giustificati: in genere le persone vengono rilasciate senza accuse. La polizia va oltre la legge, anche se la stessa legge è già piuttosto draconiana e ingiusta. In realtà, preferiscono evitare che questi temi emergano in un’aula giudiziaria pubblica, e questo è interessante. Ovviamente non si tratta di singoli agenti: la polizia è guidata da varie istituzioni, che forniscono linee guida e altro. Ora siamo nel pieno di un dibattito in Parlamento sull’eutanasia. I sostenitori dicono esplicitamente: “L’opposizione viene tutta dai cristiani, quindi dovrebbe essere ignorata”, come se i cristiani non avessero diritto di parola nel processo democratico. In tutto il Paese c’è la percezione che il cristianesimo sia qualcosa di negativo, da spazzare via. Certo, è solo una parte dell’opinione pubblica, non la maggioranza. Ma è qualcosa che si nota nella classe politica, non universalmente, tra gli attori importanti».
Stephen Miran (Ansa)
L’uomo di Trump alla Fed: «I dazi abbassano il deficit. Se in futuro dovessero incidere sui prezzi, la variazione sarebbe una tantum».
È l’uomo di Donald Trump alla Fed. Lo scorso agosto, il presidente americano lo ha infatti designato come membro del Board of Governors della banca centrale statunitense in sostituzione della dimissionaria Adriana Kugler: una nomina che è stata confermata dal Senato a settembre. Quello di Stephen Miran è d’altronde un nome noto. Fino all’incarico attuale, era stato presidente del Council of Economic Advisors della Casa Bianca e, in tale veste, era stato uno dei principali architetti della politica dei dazi, promossa da Trump.
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 10 novembre con Carlo Cambi