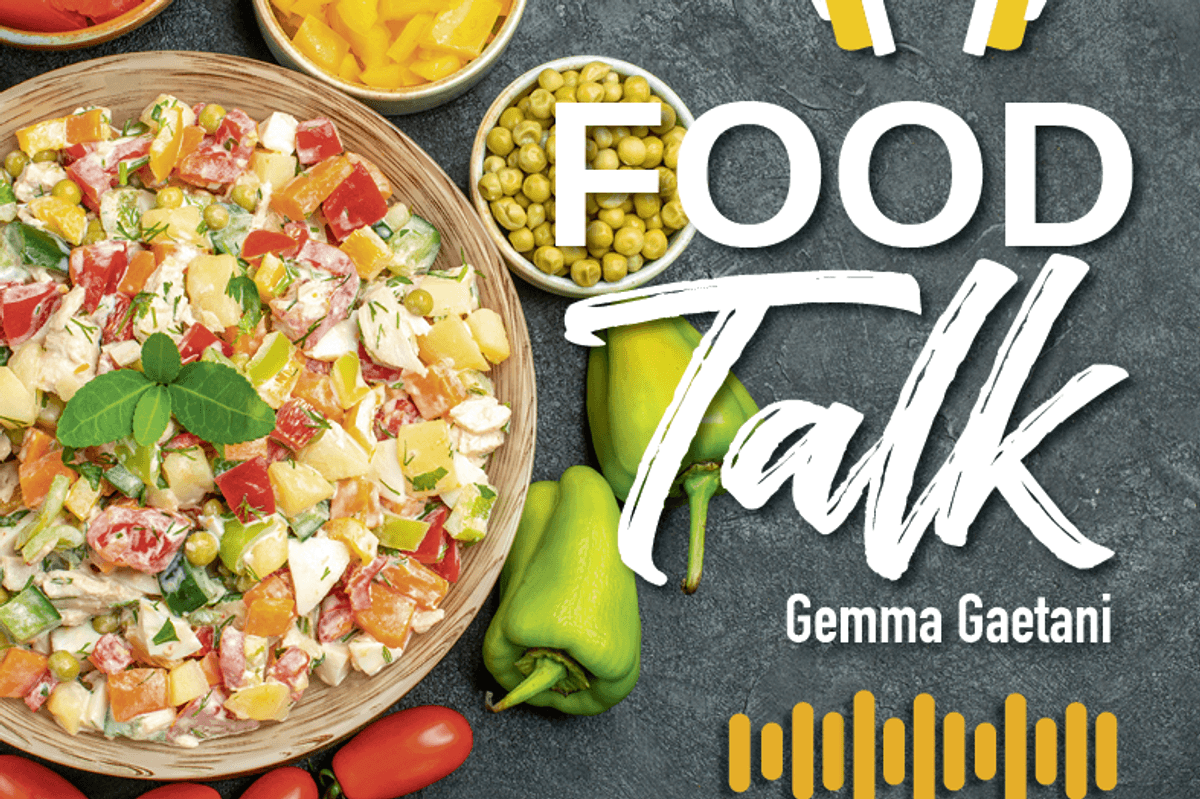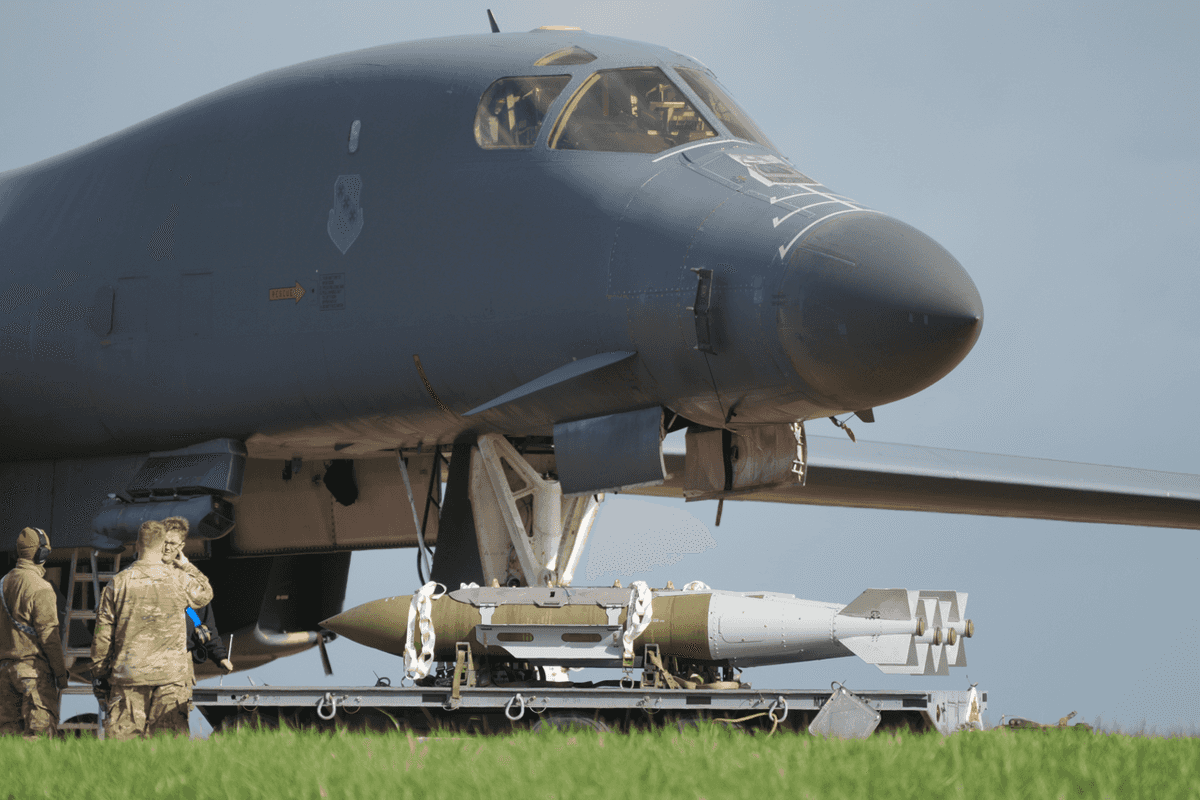<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="True" data-href="https://www.laverita.info/oggi-in-edicola-2656421513.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="particle-1" data-post-id="2656421513" data-published-at="1642451368" data-use-pagination="False">
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 12 marzo con Carlo Cambi
content.jwplatform.com
- Il premier invita Bruxelles a «sospendere urgentemente gli Ets sul termoelettrico». Offre dialogo sincero al centrosinistra, ma dice al Pd di non essere «strabico» sulle bombe: «Quelle di Clinton andavano bene?».
- Dopo aver ammesso che il conflitto è costato 3 miliardi ai contribuenti, Ursula Von der Leyen conferma che la Commissione non farà nulla contro l’inflazione, tenendo una linea ecologista. Procedura d’infrazione per 19 Paesi (Italia compresa) sul piano dell’edilizia verde.
Lo speciale contiene due articoli
Responsabilità, pragmatismo e disponibilità (respinta) a un tavolo di confronto con le opposizioni. Una Giorgia Meloni versione soft, nelle sue comunicazioni al Senato sulla crisi in Medio Oriente e in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo. «Siamo di fronte al venir meno di un ordine mondiale condiviso. Si tratta di un processo in corso da tempo», sottolinea la Meloni, «ma che ha avuto, a mio avviso, un punto di svolta ben preciso. Ovvero, l’invasione di una nazione vicina da parte di un membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La destabilizzazione globale che ne è derivata», aggiunge, «ha avuto le sue ripercussioni in Medio Oriente, dove pure l’attuale conflittualità ha una data d’inizio chiara, e non è quella del 28 febbraio 2026, ma il 7 ottobre 2023. È l’attacco, barbaro e folle, al territorio israeliano da parte di Hamas. Un attacco letale e sofisticato che è stato possibile grazie al sostegno fornito dall’Iran a questo gruppo terroristico. È in questo contesto di crisi strutturale del sistema internazionale», osserva il premier, «gli interventi unilaterali condotti fuori dal perimetro del diritto internazionale, che dobbiamo collocare anche l’intervento americano e israeliano contro il regime iraniano. Un intervento al quale l’Italia non prende parte e non intende prendere parte».
Da Pd, M5s e Avs arriva la richiesta di non usare le basi americane in Italia. «A oggi», risponde la Meloni, «non è pervenuta alcuna richiesta per l’uso delle basi militari americane in Italia per scopi oltre quelli previsti dagli accordi, e in questo caso la decisione spetterebbe al Parlamento. E ribadisco che non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra». «La Meloni», attacca il capogruppo di Avs al Senato, Peppe De Cristofaro, «non può dire nulla perché è subalterna al suo alleato americano. Ha schierato l’Italia a totale sostegno di Donald Trump, offendendo la storia politica e diplomatica del nostro Paese».
Passiamo al tema dei prezzi dei carburanti: «Il governo italiano ha investito 5 miliardi di euro per calmierare i prezzi delle bollette. Il messaggio che voglio dare, agli italiani», avverte il premier, «ma anche a chi dovesse pensare di sfruttare questa situazione per arricchirsi sulla pelle dei cittadini e delle imprese è: faremo tutto quello che possiamo per impedire che si speculi sulla crisi, compreso, se necessario, recuperare i proventi della speculazione con una maggiore tassazione delle aziende che ne fossero responsabili». Ma l’Europa non può far finta di niente: «In molte nazioni europee», ricorda Giorgia Meloni, «una parte rilevante del costo dell’energia è legato, direttamente o indirettamente, al sistema europeo di tassazione del carbonio, il cosiddetto Ets. Un sistema che necessita di una revisione per correggere una serie di meccanismi che oggi, in un significativo numero di Stati membri, Italia inclusa, gonfiano artificialmente il prezzo dell’elettricità, con punte che, per la nostra nazione, toccano i 30 euro per Mwh, un quarto dell’intero costo dell’elettricità. Perché gli Ets sono di fatto una “tassa” voluta dall’Europa che dovrebbe gravare solo sulle modalità più inquinanti di produzione di energia, come quelle di origine fossile, ma finisce per determinare il prezzo di tutte le forme di energia. A livello europeo», sottolinea, «stiamo chiedendo di sospendere urgentemente l’applicazione dell’Ets alla produzione di elettricità da fonti termiche, cioè dal termoelettrico».
La svolta politica della Meloni è quando afferma di essere «disponibile a un tavolo con le opposizioni». Appello raccolto solo da Italia viva e Azione. «Il tavolo c’è già oggi in Parlamento», commenta il leader del M5s Giuseppe Conte, «a cosa serve una sfilata a Palazzo Chigi, per essere presi in giro, come per il salario minimo? Qual è il posizionamento dell’Italia sulla guerra? Ditecelo adesso, non è che veniamo a Chigi e ci facciamo due chiacchiere. Se un ministro va in ferie quando l’attacco Usa è imminente che informazioni dobbiamo prendere?».
I numeri. L’Aula del Senato approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della premier con 102 Sì, 66 No e un astenuto. In sede di replica alla Camera, in serata, la Meloni sottolinea che «l’Agenzia Internazionale per l’energia ha appena annunciato di aver deciso all’unanimità di immettere sul mercato 400 milioni di barili di riserve strategiche». Una scelta presa da una riunione del G7 che si è tenuta in videoconferenza nel pomeriggio. Ai deputati dem che hanno criticato l’intervento Usa in Iran, la Meloni risponde tagliente: «Viva gli americani che liberano l’Europa dal nazifascismo ma no agli americani che liberano dalla dittatura altri popoli in altre parti del mondo. Viva i bombardamenti degli Stati Uniti di Bill Clinton alla Serbia per fermare i massacri di civili in Kosovo, con la partecipazione italiana a quei bombardamenti senza passare dal Parlamento», argomenta la Meloni, «ma no agli interventi militari per fermare i massacri in Iran e in altre parti del mondo. Io francamente non condivido questo strabismo».
Tocca a Conte l’attacco finale: «Le manca il coraggio e la schiena dritta», dice il leader M5s alla Meloni, «perché sopraffatta dall’essere subordinata a Trump».
Ma l’Ue è sorda e pensa solo alle case green
Mentre la guerra in Iran brucia centinaia di miliardi sui mercati europei, manda alle stelle il prezzo del petrolio e infiamma le bollette, dalla Commissione europea non si registra alcuna iniziativa per arginare la speculazione e l’inflazione ma solo fumose manifestazioni di intenti. Anzi, si lamenta la dipendenza energetica dell’Ue, dimenticando che questa è il frutto di politiche ecologiste che hanno messo al bando il nucleare e lo sfruttamento minerario e si ribadisce la traiettoria del Green deal, ovvero la conferma del meccanismo Ets e la sollecitazione a incrementare le rinnovabili e a smarcarsi dalle fonti fossili. In piena emergenza, inoltre, la Commissione Ue non trova niente di meglio che tornare a occuparsi delle case green bacchettando quei Paesi che ancora non hanno presentato un piano di ristrutturazione del patrimonio edilizio.
Intervenendo alla plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo, in vista del Consiglio europeo del 19-20 marzo, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha fatto il punto sugli effetti energetici della guerra in Iran. «Dall’inizio del conflitto i prezzi del gas sono aumentati del 50% e quelli del petrolio del 27%. Dieci giorni di guerra sono già costati ai contribuenti europei 3 miliardi di euro in più per le importazioni di combustibili fossili. Questo è il prezzo della nostra dipendenza», ha evidenziato, sottolineando allo stesso tempo che tornare agli approvvigionamenti russi «sarebbe un errore strategico, ci renderebbe più dipendenti, più vulnerabili e più deboli. Disponiamo di fonti energetiche domestiche, le rinnovabili e il nucleare (la riabilitazione dell’atomo da parte di Ursula von der Leyen è recente, ndr). I loro prezzi sono rimasti invariati negli ultimi dieci giorni». Quindi barra dritta sull’agenda del Green deal, senza cedimenti. «Dobbiamo mantenere la rotta sulla nostra strategia di lungo periodo. Possiamo certamente essere più pragmatici e più intelligenti nella sua attuazione, ma la direzione di marcia è quella giusta», ha aggiunto. Una dichiarazione che arriva dopo che gli Usa hanno dato il via libera all’alleggerimento temporaneo delle sanzioni sul petrolio russo a beneficio dell’India e il segretario al Tesoro, Scott Bessent, ha ventilato la prospettiva di riconsiderare le misure sanzionatorie sul petrolio russo.
Von der Leyen ha parlato anche dell’Ets, il meccanismo di scambio delle quote di CO2, il pilastro Ue per ridurre le emissioni di gas serra, su cui i 27 si sono divisi negli ultimi mesi. La presidente è stata categorica chiudendo la porta a quella sospensione che il premier, Giorgia Meloni, chiederà alla riunione del Consiglio europeo. «Senza l’Ets oggi consumeremmo 100 miliardi di metri cubi di gas in più, rendendoci ancora più vulnerabili e dipendenti. Abbiamo quindi bisogno dell’Ets», ha detto Von der Leyen, dando come unica concessione possibile la possibilità di «modernizzarlo». Un termine che dice tutto e niente. La presidente indica le opzioni allo studio: «Un uso migliore dei power purchase agreement, i Ppa (contratti di acquisto di energia a lungo termine, 5-20 anni stipulati tra un produttore di energia rinnovabile e aziende, ndr), misure di aiuti di Stato, possibili sussidi o tetti al prezzo del gas». Von der Leyen ha ricordato poi che «il costo dell’energia stessa rappresenta oltre il 56% della bolletta, gli oneri di rete il 18%, tasse e prelievi il 15%, e i costi del carbonio, in media intorno all’11%».
Di fronte all’emergenza energetica, Bruxelles non solo non riesce a dare risposte efficaci ma non trova di meglio da fare che bacchettare quei Paesi che non hanno rispettato le scadenze dettate dalla direttiva sulle case green. La Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a 19 Stati membri (tra cui Italia, Belgio, Germania, Francia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Svezia) per non aver presentato entro il 31 dicembre 2025 le loro bozze di Piani nazionali di ristrutturazione degli edifici, previsti dalla direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia. L’obiettivo è trasformare il patrimonio edilizio europeo in un parco decarbonizzato entro il 2050. Gli Stati membri interessati hanno due mesi per rispondere. In assenza di progressi, Bruxelles potrà procedere con un parere motivato. «La notizia non è l’avvio delle procedure d’infrazione, bensì che questi Paesi hanno voltato le spalle a Ursula sulle case green», hanno commentato Paolo Borchia, capodelegazione della Lega, e Isabella Tovaglieri, relatrice ombra del provvedimento. «Ursula tira per la giacca i proprietari di case, chiamati a scucire sull’unghia dai 60 ai 100.000 euro per mettersi a norma. Alla fine, a restare col cerino in mano è stata lei».
Ursula von der Leyen ha ribadito infine la sua posizione generale sulla guerra in Iran senza citare né Usa né Israele. Ha parlato soltanto della responsabilità del regime iraniano e dell’Ayatollah Khamenei, che «ha governato attraverso la repressione, la violenza e la paura e ha sponsorizzato il terrorismo in tutta la regione e persino sul suolo europeo». Per questo «non si dovrebbero versare lacrime per un regime del genere». Viene confermata, dunque, la sua propensione a sostenere il cambio di regime.
Continua a leggereRiduci
Sul vincitore di Sanremo in questi giorni si sono sentite polemiche e valutazioni di ogni tipo. Ma sono davvero sensate? Qui vi diamo la nostra versione...
Forze armate americane (Getty)
Le economie di Europa e Paesi del Golfo non possono reggere un conflitto lungo. Usa e Israele spendono 1 miliardo al giorno. Ma i pasdaran resistono e Donald Trump non si può permettere di non vincere: rischio disastro.
E se il conflitto con l’Iran finisse come quello in Afghanistan? Se cioè la macchina da guerra degli Stati Uniti e quella israeliana non riuscissero ad averla vinta sugli ayatollah? Nel passato è già accaduto che la resistenza di forze apparentemente inferiori tenesse testa a quello che è considerato un esercito invincibile. Basta pensare, oltre che a Kabul, a Corea, Vietnam, Iraq e perfino Somalia, dove l’operazione Restore Hope, nata per stabilizzare il Paese e spazzare via i signori della guerra, si concluse con un ritiro umiliante dopo la morte di 19 marines.
No, non sarebbe la prima volta che gli americani sono costretti a fare i conti con una sconfitta, ammettendo di essere finiti nel pantano. Ma in questo caso, se accadesse, cosa che non mi auguro e non perché penso che gli Usa abbiano sempre ragione, sarebbe una catastrofe globale, politica e militare.
Perché affaccio l’idea di un clamoroso insuccesso di Stati Uniti e Israele? Primo perché è il pensiero inespresso che serpeggia fra gli osservatori. E secondo perché ci sono una serie di fattori che mi rendono inquieto sul risultato di una missione che avrebbe dovuto essere rapida e che invece rischia di trasformarsi in un conflitto più lungo e complesso del previsto. Non ci sono soltanto le dichiarazioni contrastanti di questi giorni, con Donald Trump che parla di fine della guerra, Bibi Netanyahu che lo smentisce e i pasdaran che alzano i toni, annunciando di voler infliggere una lezione al Grande e al piccolo Satana. C’è la sensazione che Stati Uniti e Israele abbiano sottovalutato sia l’arsenale di cui dispone l’Iran, sia il collante religioso e militare su cui si regge il regime degli ayatollah. Teheran non è Caracas e i Guardiani della rivoluzione non sono la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Il potere su cui poggia la Repubblica islamica non si è squagliato al primo colpo come è accaduto in Venezuela, ma anzi - nonostante l’impopolarità della dittatura - rimane saldo.
Del resto, clerici e laici cresciuti in quasi cinquant’anni all’ombra di Khomeini e di Khamenei sanno di non avere alternative: se oggi si arrendessero sarebbero morti, perché quello che non farebbero americani e israeliani lo completerebbe, come avviene in ogni resa dei conti dopo il crollo di una tirannia, il popolo oppresso. Dunque, l’Iran non soltanto non si arrenderà, come sarebbe ovvio dopo un bombardamento a tappeto, ma farà qualsiasi cosa, come appunto scatenare il caos.
Lo abbiamo visto, Teheran ha molti missili e moltissimi droni e grazie a quelli è in grado di infiammare l’intera regione. Infatti, non riuscendo a colpire gli Stati Uniti o a fare enormi danni a Israele, spara sui Paesi vicini, con la scusa che ospitano basi americane. Colpisce gli Emirati arabi, il Qatar, il Bahrein, l’Arabia Saudita, il Kuwait, con l’evidente intento di trascinarli in guerra e di destabilizzare i loro governi. Le bombe piovono sugli avamposti degli Stati Uniti, ma anche sui grattacieli e sulle infrastrutture, per fare più male. Però l’estensione del conflitto non si ferma a questo. Da quasi due settimane l’Iran blocca lo stretto di Hormuz, impedendo a migliaia di petroliere di transitare, paralizzando così il traffico della fonte energetica su cui si regge l’economia globale. Quanto possono durare l’Europa e la sua industria senza petrolio? Le scorte si stanno assottigliando e probabilmente si esauriranno nell’arco di un mese o poco più. E dopo?
La guerra ha in pratica un orizzonte temporale: non può continuare all’infinito, non solo perché agli Stati Uniti e a Israele costa 1 miliardo di dollari al giorno, ma perché i Paesi del Golfo e la stessa Europa non sono in grado di reggere un conflitto di anni. E allo stesso tempo, «terminare il lavoro», per usare le parole di Trump, prima di averlo concluso, ovvero lasciando un Khamenei paradossalmente ancora più cattivo del precedente, rappresenterebbe non solo un fallimento, ma una disfatta senza precedenti. In quanto, anche con un regime acciaccato, gli ayatollah avrebbero vinto contro il Grande e il piccolo Satana. Per il Medio Oriente sarebbe un disastro, ovvero un segnale ai movimenti, terroristici e non, che provano a sovvertire le monarchie del Golfo. Non solo: sarebbe un messaggio anche alla Russia di Putin e alla Cina di Xi Jinping, che a questo punto avrebbero meno remore a fare quello che hanno in mente. Mosca a continuare il lavoro sporco in Ucraina, Pechino a cominciare quello a Taiwan.
Continua a leggereRiduci