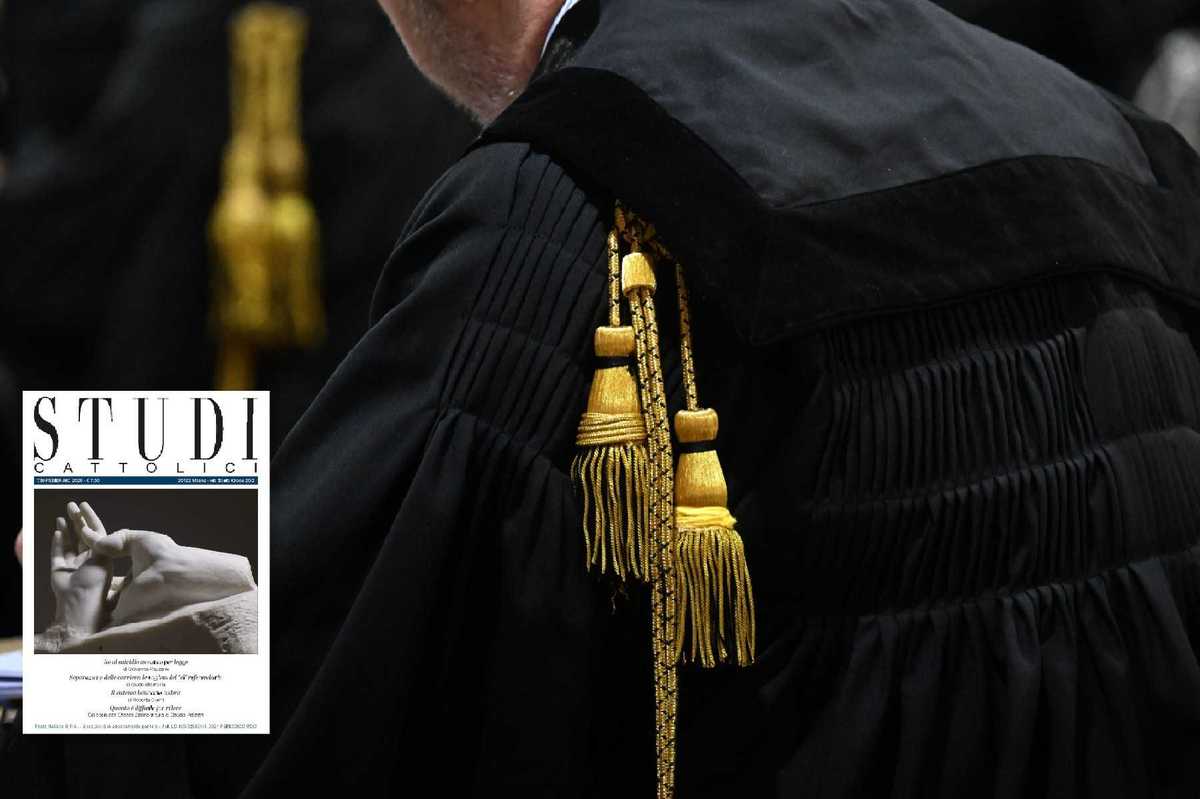[…] Prima dell’avvento della Costituzione repubblicana, il ruolo del pm era inequivocabilmente legato al potere esecutivo. Egli era un funzionario alle dirette dipendenze del governo, tanto da essere definito «procuratore del Re». Sottoposto al potere gerarchico e disciplinare del ministro di Grazia e Giustizia, riceveva da questi ordini e direttive, agendo di fatto come il braccio operativo del potere politico nell’amministrazione della giustizia penale. Questa subordinazione si rivelò un pericolo concreto durante il regime fascista, quando il pm divenne un potenziale strumento di repressione dell’opposizione politica, facilmente orientabile dalle volontà del governo. L’esperienza storica ha quindi lasciato una profonda cicatrice nella coscienza democratica del Paese, generando una forte diffidenza verso qualsiasi forma di controllo politico sulla pubblica accusa.
Dopo la caduta del fascismo, il decreto Togliatti del 1946 iniziò a recidere il legame di dipendenza gerarchica, sostituendo la «direzione» del ministro con una più tenue «vigilanza». Ma il dibattito in Assemblea Costituente vide scontrarsi due visioni diametralmente opposte:
• il progetto di Giovanni Leone: considerava il pm ontologicamente un rappresentante dell’esecutivo presso i giudici. Proponeva che i magistrati requirenti fossero organizzati gerarchicamente sotto il ministro della Giustizia, senza inamovibilità, fungendo da organo di collegamento tra i poteri.
• Il progetto di Pietro Calamandrei: sosteneva che per garantire la legalità e l’uguaglianza dei cittadini, anche il pm dovesse essere un «organo giudiziario vero e proprio», dotato di assoluta indipendenza e inamovibilità, sottratto a ogni subordinazione gerarchica ministeriale. La soluzione finale accolse la tesi di Calamandrei: il pm fu inserito nell’ordine giudiziario, definito come autonomo e indipendente da ogni altro potere (art. 104 Cost.) e governato esclusivamente dal Consiglio Superiore della Magistratura (Csm). […]
Giuliano Vassalli (1915-2009), partigiano, giurista e politico, presidente della Corte costituzionale, è il ministro della Giustizia legato all’introduzione nel 1989 del nuovo Codice penale. Tale riforma rappresenta una cesura radicale con il passato e la causa tecnica diretta dell’odierno dibattito. Importando in Italia un modello processuale di tipo accusatorio, ispirato ai sistemi anglosassoni, la riforma ha trasformato irreversibilmente la fisionomia e il ruolo del pubblico ministero. Il nuovo codice ha introdotto cambiamenti fondamentali:
• abolizione del giudice istruttore: la figura neutrale che garantiva l’equilibrio della fase istruttoria è stata eliminata;
• trasformazione del pm, che ha perso ogni carattere istruttorio per diventare un organo investigativo a tutti gli effetti. Oggi è lui a condurre le indagini preliminari e a dirigere la polizia giudiziaria. Mentre col vecchio codice, il pm (organo istruttore) poteva emettere direttamente provvedimenti limitativi della sfera di libertà individuale del cittadino (ordini di cattura, ordini di sequestro e perquisizione), ora non può più farlo: deve chiedere tali provvedimenti a un organo che ha, sia pur in modo meno ampio del vecchio giudice istruttore, indubbia natura giurisdizionale, il Giudice per le indagini preliminari (Gip). Questa mutazione ha creato, tuttavia, una significativa sovrapposizione funzionale tra l’attività del pm, organo ancora appartenente all’ordine giudiziario autonomo, e quella degli organi di polizia, che dipendono invece dal potere esecutivo. Tra il 1992 e il 1995, la Corte costituzionale intervenne con diverse sentenze che dichiararono incostituzionali alcune norme del nuovo codice, reintroducendo principi di stampo inquisitorio. In particolare, la Corte permetteva che alcune dichiarazioni raccolte unilateralmente dal pm o dalla Polizia giudiziaria senza contraddittorio potessero valere come prova, minando la logica stessa del nuovo processo.
Questi tentativi, seppur circoscritti, di un ritorno a logiche più tipiche di un sistema inquisitorio, determinarono non poche aporie e difficoltà teoriche e pratiche. E a ciò cercò di porre rimedio la politica attraverso il ricorso a commissioni parlamentari ad hoc. […]
La cosiddetta Riforma del «giusto processo» (Legge costituzionale n. 2 del 1999), descritta come una riforma bipartisan, viene così approvata undici anni dopo l’entrata in vigore del Codice Vassalli e 26 anni prima del dibattito attuale sulla separazione delle carriere. Essa ha rappresentato una risposta diretta del Parlamento per «blindare» i princìpi del sistema accusatorio contro le interpretazioni della Corte costituzionale. La riforma ha infatti inserito in Costituzione una nuova, importante, norma, l’art. 111, con la quale furono introdotti i seguenti princìpi:
• il contraddittorio: stabilendo che il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova;
• la terzietà del giudice: rafforzando l’imparzialità e la posizione super partes del giudicante;
• la parità delle armi: garantendo che accusa e difesa abbiano uguali poteri davanti al giudice. In sintesi, l’articolo 111 non fu il prodotto di una singola «commissione sul processo», ma l’esito finale (e riuscito) di un lungo dibattito sulle garanzie processuali avviato all’interno delle grandi commissioni bicamerali (De Mita-Iotti e D’Alema) e conclusosi con una convergenza politica trasversale per salvare l’impianto accusatorio del processo penale.
Il nuovo codice del 1989, quindi, anche a livello di princìpi costituzionali, non configura più il pm come un organo giudiziario al di sopra delle parti, ma come una parte processuale che si contrappone alla difesa. Il processo si svolge davanti a un giudice terzo e imparziale, in una logica di parità delle armi. [...]. La trasformazione del pm in una parte investigativa ha naturalmente alimentato due visioni contrapposte sul suo corretto inquadramento istituzionale, dando vita all’acceso dibattito sulla separazione delle carriere. L’argomentazione tecnica a favore della separazione, alla quale aderisco, sia pure con qualche perplessità, per via delle ragioni di coordinamento istituzionale di cui sto trattando, si fonda su una logica stringente e per le argomentazioni già più sopra evidenziate. Se il pm svolge un’attività investigativa e accusatoria, la sua funzione è intrinsecamente diversa da quella «giurisdizionale», che consiste nel giudicare in modo terzo e imparziale. Separare le due carriere sarebbe, quindi, un passo coerente con il modello accusatorio del nuovo codice, necessario per garantire una reale parità delle armi tra accusa e difesa e per rafforzare la percezione di terzietà del giudice. [...]. E la principale contro-argomentazione è di natura politica, radicandosi proprio nel timore storico di un ritorno al passato quanto alla subordinazione al potere politico. [...]
I sostenitori della separazione rassicurano che questo rischio è remoto, poiché l’autonomia della magistratura (sia requirente sia giudicante) è protetta da un principio costituzionale (art. 104), modificabile solo attraverso un complesso e aggravato procedimento di revisione. Tuttavia, sebbene questo scontro di visioni appaia centrale, esso rischia di distogliere l’attenzione dalla vera patologia del sistema: la crisi di un altro potere dello Stato, ovvero la progressiva perdita di efficacia e centralità del potere legislativo, iniziata a partire dagli anni Settanta.
La debolezza del Parlamento ha radici profonde: la forte conflittualità politica, l’influenza crescente di poteri esterni (sindacati, lobby, gruppi di interesse) e la frammentazione della rappresentanza hanno reso sempre più difficile produrre leggi chiare, generali e astratte. In questo vuoto si è inserita la magistratura, anche con intenti lodevoli, ma dimenticando la natura e i limiti della propria attività, che, a differenza di quella politica, non è libera nei fini e non è soggetta ai normali controlli dell’alternanza politica. Attraverso un’attività interpretativa sempre più svincolata dai rigidi criteri tradizionali e definita «creativa», i giudici hanno di fatto supplito all’inerzia del legislatore.
Sono divenuti così i co-protagonisti di una vera e propria modifica del nostro tessuto sociale, morale, politico ed economico, intervenendo là dove la politica non era in grado o non voleva decidere. E bisogna dire che questa funzione di «supplenza» ha conferito alla magistratura un potere enorme, di fatto alterando l’equilibrio originariamente disegnato dalla Costituzione. L’enorme potere accumulato dalla Magistratura, sia requirente sia giudicante, l’ha portata a confliggere inevitabilmente con il potere politico. Fenomeni storici come «Tangentopoli» sono la dimostrazione più evidente di questa frizione. In questo contesto, la richiesta di «separare» e, potenzialmente, controllare il pm può essere letta non solo come una legittima istanza di riforma, ma anche come una reazione del mondo politico a uno squilibrio di potere che esso stesso ha contribuito a generare con la propria inazione. Il problema, nato nel potere legislativo, si è così trasferito (anche) al potere giudiziario, rendendo la separazione delle carriere un tentativo di curare il sintomo, sicuramente esistente, anziché la malattia.
La trasformazione del pm, attuata con la riforma del 1989, ha fornito il presupposto tecnico e la cornice logica per il dibattito sulla separazione delle carriere. Tuttavia, la causa profonda della tensione risiede nel delicato rapporto con gli altri poteri costituzionali. Ne consegue che una vera e duratura riforma della giustizia non può limitarsi a un intervento, per quanto significativo, sull’ordinamento giudiziario. La soluzione dev’essere di più ampio respiro, a livello costituzionale, e deve riconsiderare l’intero sistema di pesi e contrappesi tra i poteri dello Stato, ridefinendone i rapporti in modo chiaro e sostenibile. Il problema dell’espansione del potere giudiziario non riguarda solo il pm, ma anche i giudici e persino la Corte costituzionale, le cui sentenze - spesso di natura «manipolativa» o «additiva» - si sostituiscono di fatto alla volontà del legislatore. A complicare ulteriormente il quadro si aggiunge il fattore della globalizzazione, che collega la Magistratura italiana a contesti internazionali, rendendo ancor più delicato l’equilibrio tra i poteri nazionali e non più rinviabile una profonda riflessione costituzionale.