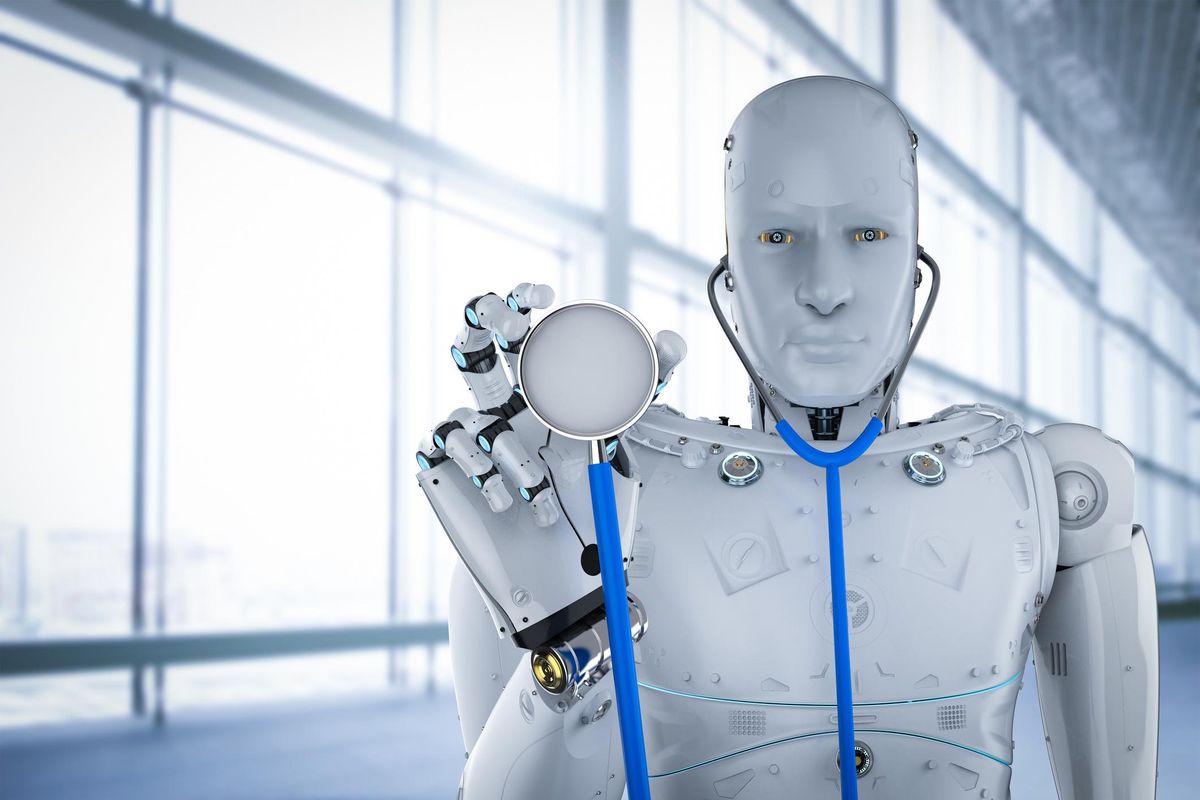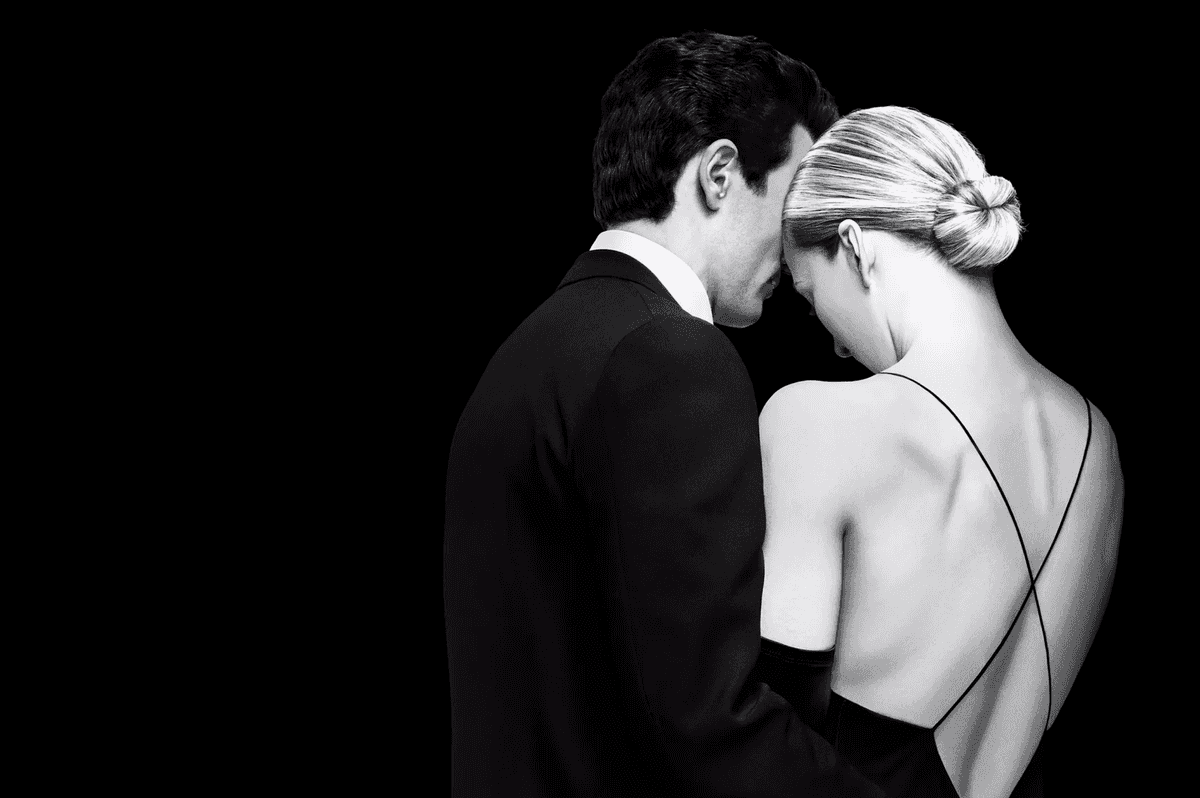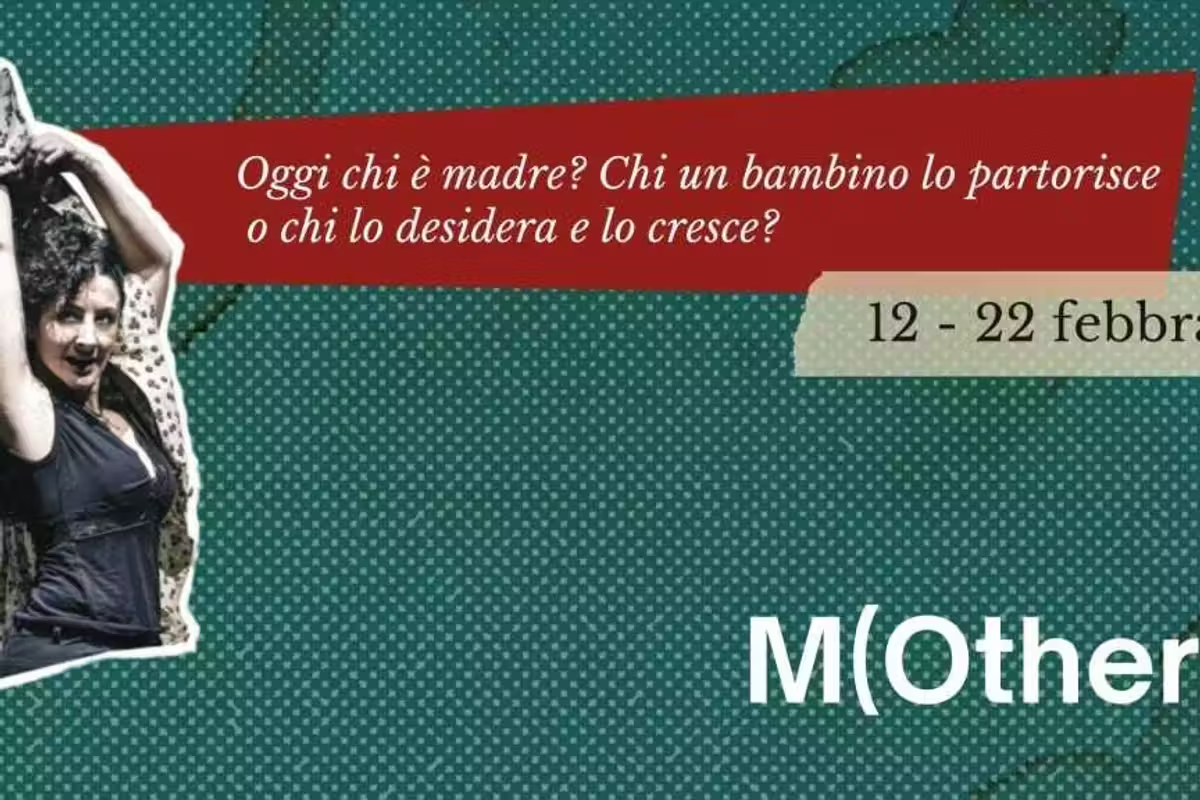True
2022-01-03
Addio medico: ti cura Amazon
(IStock)
In un prossimo futuro non sarà più il medico a occuparsi della nostra salute, non ci dovremo rivolgere a lui per l’antibiotico, la misurazione della pressione e per la pasticca contro il colesterolo o per curare il diabete. Basterà un clic e avremo uno staff di esperti pronto a fornirci tutte le soluzioni e a inondarci di supposte, compresse e preparati avveniristici, avendo in mano, aggiornata in tempo reale, la nostra cartella clinica. Saranno i big tech, Google, Amazon, Apple i padroni della nostra salute. E in parte già lo sono.
Di noi sanno già moltissimo, grazie all’uso compulsivo che facciamo delle piattaforme sociali e di Internet. Ogni volta che ci colleghiamo a Google, che cerchiamo un’informazione online o chattiamo con un gruppo Facebook, «doniamo» ai Signori del Web una montagna di informazioni personali che, diversamente, non concederemmo nemmeno ai parenti più prossimi. Di noi i colossi di Internet sanno abitudini, stato civile, cosa mangiamo, se viaggiamo e come lo facciamo, se siamo socievoli, quali interessi abbiamo e anche quali vizi privatissimi. A questa mole di dati si stanno aggiungendo quelli sulla salute. La pandemia ha aumentato l’attenzione al proprio benessere fisico. Smartwatch, smartband, braccialetti vari che forniscono - a noi, ma anche ai giganti informatici - informazioni sul battito cardiaco, sulla pressione sanguigna, sul numero di passi giornaliero e così via, sono andati a ruba. Fanno parte della quotidianità al pari del cellulare. L’Apple watch, per esempio, raccoglie e organizza tutti i dati di benessere psicofisico per collegarli all’account personale. E Google mesi fa ha risposto acquisendo uno dei maggiori operatori del settore, Fitbit, produttore di bracciali e orologi orientati al fitness.
sempre sotto controllo
Pochi si rendono conto che tutti questi dispositivi sono collettori di informazioni preziose. A noi sembra un servizio gratuito, al solo costo del bracciale che ci facilita la vita e aiuta a stare in forma; in realtà cediamo gratis i dati sulla nostra salute. Da tempo le big tech raccolgono direttamente le informazioni biologiche su milioni di pazienti e li combinano con i dati sulle attività ordinarie di mobilità o di consumo degli stessi soggetti, ricavando profili dettagliatissimi sull’evoluzione delle personalità e dei bisogni di ognuno.
App e dispositivi di monitoraggio della salute si stanno diffondendo rapidamente. Quello che è capitato settimane fa a Eugenio Finardi, salvato in aeroporto dal suo smartphone che ha segnalato il sopraggiungere di una fibrillazione atriale, è un esempio dell’uso virtuoso del dispositivo. Ma c’è un risvolto della medaglia perché manca una regolamentazione, con la conseguenza che viene meno la tutela della privacy. Da tempo i big tech tentano di immagazzinare più informazioni possibili sulla salute mondiale con un’attenta opera di tracciamento dei dati che gli utenti lasciano incautamente sui vari dispositivi tecnologici. Già nel 2013, Google creò Calico, un’azienda con lo scopo di capire il processo biologico d’invecchiamento e sviluppare terapie per permettere alle persone di vivere più a lungo. Nel 2014, sempre Google lanciò le lenti a contatto connesse capaci di controllare il livello di glicemia, ma senza riscontrare il successo sperato. Amazon ha elaborato il progetto «Amazon comprehend medical» per sfruttare i dati medici di milioni di pazienti (come prescrizioni, note mediche, rapporti di patologia o persino radio) con lo scopo di estrarre, da queste fonti disparate, gli elementi chiave necessari per la diagnosi o la scelta di dosi e farmaci.
Sulla stessa linea, Apple sta sviluppando Health kit, piattaforma di condivisione dati tra gli ospedali, mediante applicazioni da questi utilizzati, e che dovrebbe servire a ricostruire l’anamnesi dei pazienti. Ha suscitato scalpore la notizia del coinvolgimento di Google nell’attività di raccolta di dati personali di pazienti in molti ospedali statunitensi. All’insaputa di medici e malati, il colosso di Mountain View avrebbe immagazzinato i dati contenuti in cartelle cliniche di pazienti di 21 Stati Usa, all’interno di un progetto noto con il nome di Nightingale. Google ha sostenuto che tutto era perfettamente conforme alla legge federale sulla portabilità dei dati sanitari, che consente agli ospedali di condividere informazioni sanitarie con partner commerciali al fine di permettere alla struttura stessa di portare avanti le sue funzioni mediche.
l’algoritmo farà ricette
La domanda inquietante è: in un prossimo futuro la nostra salute sarà appesa alle diagnosi effettuate dagli algoritmi? La tendenza di affidarsi più alla tecnologia a buon mercato che alla medicina ufficiale è propria dei nostri tempi e risponde in parte alla protervia dell’autosufficienza e alla sfiducia nella competenza. Negli ultimi anni, ma soprattutto con il Covid, c’è stata una esplosione delle applicazioni sui cellulari che riguardano temi della salute. Insegnano a come superare l’ansia e lo stress, offrono con la stessa facilità consigli su come superare la timidezza in pubblico e come vincere la depressione. L’app Driver utilizza la realtà virtuale per trattare la paura di guidare attraverso la riproposizione al paziente di diversi scenari possibili, dalla guida in città a quella in galleria. Klover si propone di far superare la claustrofobia. L’università di Milan Bicocca ha creato un’applicazione, Italia ti ascolto, per stabilire lo stress pandemico e prenotare l’incontro con medici. La facoltà di psichiatria della Columbia University ha lanciato un’app per fornire cure alla depressione tramite algoritmi. Ma secondo il neuropsichiatra Massimo Ammaniti, l’uso di questi dispositivi è negativo perché comporta che il soggetto si definisca malato senza aver avuto prima una diagnosi. Poi osserva che già i problemi della patologia psichica sono difficilmente trattabili da un medico, figurarsi con un’applicazione che ha la pretesa di dare una risposta in breve tempo e un trattamento efficace in un paio di settimane.
Tra le app più diffuse per combattere la depressione c’è Woebot, è un chatbot che dialoga con l’utente e gli chiede aggiornamenti sullo stato dell’umore e fornisce esercizi per migliorarlo. Ci sono anche applicazioni destinate ai bambini che addirittura tendono a sostituire i genitori nella funzione di rassicurarli. Una di queste aiuta a combattere la paura del buio. È una storia interattiva dal titolo Buona notte Dadà, che ha come protagonisti un bambino e alcuni minion che arrivano in suo soccorso. Anche la salute dei bambini è sempre più in mano ai Signori del Web.
Pierluigi Paganini: «I dati sanitari possono essere usati a fini commerciali»
«Le big tech come Amazon, Google, Apple sono già in possesso di una quantità di informazioni legate alle nostre abitudini e possono profilare ognuno di noi. Questo vale anche per la salute. Stiamo trasferendo moltissime indicazioni sul nostro stile di vita e quindi anche potenzialmente sui nostri punti deboli sanitari. Con braccialetti e dispositivi vari, il monitoraggio dello stato di salute è continuo. Questo apre scenari inquietanti. Chi utilizza le informazioni? Siamo sicuri che non vengano rivendute e utilizzate per finalità commerciali?». Pierluigi Paganini, tra i massimi esperti di cibersicurezza, collabora al Sistema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali del ministero dell’Economia.
Lei ha approfondito il tema della presenza sempre più invadente dei colossi del Web nel settore sanitario. Cosa ha scoperto?
«Ci sono aspetti positivi in questi dispositivi tecnologici, come la possibilità di essere avvertiti in tempo di irregolarità nel battito cardiaco e prevenire l’infarto. Ma anche risvolti preoccupanti che vanno valutati e sui quali intervenire».
A cosa si riferisce?
«I dati personali sulla salute possono essere usati anche a fini discriminatori oltre che commerciali, che non hanno niente a che vedere con il benessere».
Ci fa qualche caso?
«Le informazioni sulla salute potrebbero essere vendute dalle big tech a compagnie di assicurazione. Le società che hanno necessità di stipulare una polizza per i loro dipendenti potrebbero discriminare tra individui ai quali dare una polizza sulla base di dati personali riservati. Chi ha patologie di cuore, ma anche chi conduce una vita molto sedentaria e ha problemi con il colesterolo e cattive abitudini alimentari, può essere, in prospettiva, un soggetto a rischio. In questo caso la polizza potrebbe risultare più costosa. La cosa potrebbe estendersi al mercato del lavoro».
Intende che i dati sulla salute diventerebbero discriminanti nei colloqui di assunzione?
«È un rischio. Sempre più spesso le società guardano alla presenza sui social del candidato per avere più informazioni oltre a quelle fornite dal curriculum. Se ne deduce l’orientamento politico, l’impegno sociale, gli interessi principali. Tutto concorre a profilare una persona. A queste informazioni potrebbero aggiungere quelle relative alla salute acquisite dalle banche dati dei grandi operatori del Web. Chi ha determinate patologie o fragilità è più a rischio di assenze, potrebbe risultare meno produttivo. Ecco che i dati diventano un fattore di discriminazione. La conoscenza dello stato di salute potrebbe essere usato dalle società di recruiting».
Per esempio?
«Se dal monitoraggio del battito cardiaco emerge che un soggetto si emoziona facilmente, potrebbe non essere indicato per attività che lo sottopongono a stress».
Le big tech quindi avrebbero di noi un quadro totale che potrebbero rivendere?
«Noi diamo a Amazon, Apple, Google, continuamente una serie di informazioni sul nostro stile di vita. È facile sapere chi è single, chi vive da solo, chi fa poco movimento fisico, le abitudini alimentari, il livello di socialità. Questi dati incrociati con le indicazioni sul battito cardiaco, il numero di passi giornaliero, il livello di ossigeno nel sangue, la pressione arteriosa, danno molto più di un’anamnesi medica. Bracciali e orologi digitali multifunzionali fanno un monitoraggio 24 ore su 24, ci seguono costantemente, hanno la situazione sotto controllo. È come avere un medico che ci segue tutto il giorno. Le informazioni aggregate concorrono a profilare una persona e a valutare il livello di rischio legato ad alcune sue abitudini. Amazon conosce i nostri acquisti, sa se sono solito comprare oggetti di sport e dall’Apple watch sa se faccio sport, se sono attivo, se cammino o vivo in modo sedentario. Non è fantascienza: è la realtà».
Però a qualcuno il braccialetto che misura il battito cardiaco ha salvato la vita.
«Non dico che il monitoraggio sia un male assoluto. Il tema è l’uso che si fa di tali dati. Se usati da un istituto pubblico possono essere utili a determinare il rischio di esposizione alle malattie di una comunità e quindi a intervenire in tempo con politiche di prevenzione mirate. Si avrebbero risparmi della spesa sanitaria. Però c’è anche un uso distorto dei dati personali sulla salute».
Chi controlla?
«Al momento nessuno, la materia ha tante zone d’ombra e le big tech se ne approfittano. Il problema è chi gestisce le informazioni. Se è un ente che rappresenta la collettività c’è un vantaggio, mentre un ente privato può farne usi commerciali e impropri. Chi è in grado di aggregare i dati personali ha in mano un potere enorme. Una volta profilato un soggetto, si può influenzarne le abitudini e lo stile di vita inducendo determinati acquisti».
C’è chi sta invece facendo un uso virtuoso di questi dati sanitari?
«Alcune cliniche stanno lavorando a progetti di ricerca per dispositivi che consentono di monitorare lo stato di salute in tempo reale. Così si riducono i tempi di ospedalizzazione e diminuisce la frequenza con cui si è obbligati a ricorrere alla clinica. Una sorta di scatola nera sanitaria. Questo è utilizzo virtuoso, si agisce in modo tempestivo su qualsiasi problematica. Un battito cardiaco anomalo è intercettato e la clinica chiede di fare subito un controllo. Il paziente è più seguito e la struttura riesce a ottimizzare il servizio che offre sulla base della disponibilità di medici e strutture».
Pier Luigi Bartoletti (Fimmg): «I dati sanitari possono essere usati a fini commerciali»
«Arriveremo al punto che Glovo, insieme con la pizza, ci porterà anche le medicine. Ormai il rapporto con i dispositivi della salute e con Internet è diventato ossessivo. Non sono contrario al bracciale che indica il battito cardiaco, ma non deve condizionare la vita. Non si può stare fissi sul display, entrare in agitazione e temere l’ictus se i battiti aumentano magari dopo una rampa di scale a piedi». Pier Luigi Bartoletti è vicesegretario della Fimmg, la Federazione italiana dei medici di medicina generale. Ha rilevato un aumento esponenziale dell’uso del Web per i temi della salute e l’acquisto esagerato di prodotti solo perché consigliati dalle chat o da qualche sito che rivendica inattendibili competenze scientifiche.
Racconta Bartoletti: «Ho pazienti che vengono in ambulatorio con la presunzione di indicarmi le cure che dovrei prescrivere solo perché lo hanno letto in Rete. Oppure manifestano disturbi perché, dopo aver seguito le indicazioni di un fantomatico sito sulla prevenzione al Covid, hanno fatto scorpacciata di integratori». Scherza? «Giorni fa si è presentata una paziente giovane con le mani arancioni. Era agitata perché, in base a Internet, temeva di avere qualche problema al fegato. Dopo una breve chiacchierata viene fuori che aveva mangiato troppe carote ritenendole un pieno di vitamine utile contro il Covid. In più aveva abusato di integratori. È bastato tornare all’alimentazione normale e tutto si è stabilizzato. Ma convincerla è stato faticoso, in lei c’era una convinzione granitica a base di citazioni da questo o quell’altro sito di fanatici vegetariani. C’è anche chi pretende di fare le analisi del sangue ogni tre mesi».
Bartoletti sottolinea che la pandemia ha cambiato il rapporto con la medicina: «C’è un’attenzione quasi ossessiva alla salute. Ben venga la sensibilità a un più corretto stile di vita, peccato che spesso si seguono indicazioni sbagliate. Il braccialetto che indica i battiti cardiaci più essere utile per responsabilizzare il soggetto verso comportamenti corretti, ma va usato con la giusta distanza: non può indurre a un atteggiamento compulsivo. Il cambiamento di alcuni valori in modo fisiologico non può creare il panico. L’informazione su Internet ha una sua utilità perché stimola nel paziente un’attenzione maggiore al suo benessere e impone al medico un aggiornamento continuo, di essere al passo con i tempi. Ma il Web non può sostituire il medico».
Per Bartoletti questo rischio è reale: «Sorgono esperti ovunque. I dispositivi tecnologici vanno usati con il dovuto distacco. Va bene se hanno un effetto ansiolitico ma non se hanno un effetto ansiogeno». Gli integratori, per esempio: «Fino a qualche anno fa era un mercato residuale. Ora i consumi sono aumentati e non per questo la salute è migliorata. Anzi spesso si fa un abuso di tali sostanze che come è stato provato, è dannoso. C’è chi, pur essendo vaccinato, continua a fare tamponi ogni settimana o il test sierologico con una frequenza fuori da ogni protocollo». Tutto questo ha un risvolto economico. La spesa è aumentata. E chi non riesce a far fronte ai rincari di alcuni prodotti determinati dall’incremento della domanda, ricorre a scorciatoie: Bartoletti ha notato «un aumento delle richieste di invalidità per avere le medicine gratuite».
Continua a leggereRiduci
Spariscono i dottori, crescono gli interessi della medicina digitale: dopo Big pharma, la nostra salute è minacciata anche da Big tech.L’esperto di cybersicurezza Pierluigi Paganini: «Per soggetti più a rischio polizze assicurative rincarate e maggiori difficoltà nel trovare un posto».Pier Luigi Bartoletti , Fimmg: «arriveremo al punto di ordinare i farmaci come la pizza a domicilio».Lo speciale contiene tre articoli.In un prossimo futuro non sarà più il medico a occuparsi della nostra salute, non ci dovremo rivolgere a lui per l’antibiotico, la misurazione della pressione e per la pasticca contro il colesterolo o per curare il diabete. Basterà un clic e avremo uno staff di esperti pronto a fornirci tutte le soluzioni e a inondarci di supposte, compresse e preparati avveniristici, avendo in mano, aggiornata in tempo reale, la nostra cartella clinica. Saranno i big tech, Google, Amazon, Apple i padroni della nostra salute. E in parte già lo sono. Di noi sanno già moltissimo, grazie all’uso compulsivo che facciamo delle piattaforme sociali e di Internet. Ogni volta che ci colleghiamo a Google, che cerchiamo un’informazione online o chattiamo con un gruppo Facebook, «doniamo» ai Signori del Web una montagna di informazioni personali che, diversamente, non concederemmo nemmeno ai parenti più prossimi. Di noi i colossi di Internet sanno abitudini, stato civile, cosa mangiamo, se viaggiamo e come lo facciamo, se siamo socievoli, quali interessi abbiamo e anche quali vizi privatissimi. A questa mole di dati si stanno aggiungendo quelli sulla salute. La pandemia ha aumentato l’attenzione al proprio benessere fisico. Smartwatch, smartband, braccialetti vari che forniscono - a noi, ma anche ai giganti informatici - informazioni sul battito cardiaco, sulla pressione sanguigna, sul numero di passi giornaliero e così via, sono andati a ruba. Fanno parte della quotidianità al pari del cellulare. L’Apple watch, per esempio, raccoglie e organizza tutti i dati di benessere psicofisico per collegarli all’account personale. E Google mesi fa ha risposto acquisendo uno dei maggiori operatori del settore, Fitbit, produttore di bracciali e orologi orientati al fitness.sempre sotto controlloPochi si rendono conto che tutti questi dispositivi sono collettori di informazioni preziose. A noi sembra un servizio gratuito, al solo costo del bracciale che ci facilita la vita e aiuta a stare in forma; in realtà cediamo gratis i dati sulla nostra salute. Da tempo le big tech raccolgono direttamente le informazioni biologiche su milioni di pazienti e li combinano con i dati sulle attività ordinarie di mobilità o di consumo degli stessi soggetti, ricavando profili dettagliatissimi sull’evoluzione delle personalità e dei bisogni di ognuno. App e dispositivi di monitoraggio della salute si stanno diffondendo rapidamente. Quello che è capitato settimane fa a Eugenio Finardi, salvato in aeroporto dal suo smartphone che ha segnalato il sopraggiungere di una fibrillazione atriale, è un esempio dell’uso virtuoso del dispositivo. Ma c’è un risvolto della medaglia perché manca una regolamentazione, con la conseguenza che viene meno la tutela della privacy. Da tempo i big tech tentano di immagazzinare più informazioni possibili sulla salute mondiale con un’attenta opera di tracciamento dei dati che gli utenti lasciano incautamente sui vari dispositivi tecnologici. Già nel 2013, Google creò Calico, un’azienda con lo scopo di capire il processo biologico d’invecchiamento e sviluppare terapie per permettere alle persone di vivere più a lungo. Nel 2014, sempre Google lanciò le lenti a contatto connesse capaci di controllare il livello di glicemia, ma senza riscontrare il successo sperato. Amazon ha elaborato il progetto «Amazon comprehend medical» per sfruttare i dati medici di milioni di pazienti (come prescrizioni, note mediche, rapporti di patologia o persino radio) con lo scopo di estrarre, da queste fonti disparate, gli elementi chiave necessari per la diagnosi o la scelta di dosi e farmaci. Sulla stessa linea, Apple sta sviluppando Health kit, piattaforma di condivisione dati tra gli ospedali, mediante applicazioni da questi utilizzati, e che dovrebbe servire a ricostruire l’anamnesi dei pazienti. Ha suscitato scalpore la notizia del coinvolgimento di Google nell’attività di raccolta di dati personali di pazienti in molti ospedali statunitensi. All’insaputa di medici e malati, il colosso di Mountain View avrebbe immagazzinato i dati contenuti in cartelle cliniche di pazienti di 21 Stati Usa, all’interno di un progetto noto con il nome di Nightingale. Google ha sostenuto che tutto era perfettamente conforme alla legge federale sulla portabilità dei dati sanitari, che consente agli ospedali di condividere informazioni sanitarie con partner commerciali al fine di permettere alla struttura stessa di portare avanti le sue funzioni mediche. l’algoritmo farà ricetteLa domanda inquietante è: in un prossimo futuro la nostra salute sarà appesa alle diagnosi effettuate dagli algoritmi? La tendenza di affidarsi più alla tecnologia a buon mercato che alla medicina ufficiale è propria dei nostri tempi e risponde in parte alla protervia dell’autosufficienza e alla sfiducia nella competenza. Negli ultimi anni, ma soprattutto con il Covid, c’è stata una esplosione delle applicazioni sui cellulari che riguardano temi della salute. Insegnano a come superare l’ansia e lo stress, offrono con la stessa facilità consigli su come superare la timidezza in pubblico e come vincere la depressione. L’app Driver utilizza la realtà virtuale per trattare la paura di guidare attraverso la riproposizione al paziente di diversi scenari possibili, dalla guida in città a quella in galleria. Klover si propone di far superare la claustrofobia. L’università di Milan Bicocca ha creato un’applicazione, Italia ti ascolto, per stabilire lo stress pandemico e prenotare l’incontro con medici. La facoltà di psichiatria della Columbia University ha lanciato un’app per fornire cure alla depressione tramite algoritmi. Ma secondo il neuropsichiatra Massimo Ammaniti, l’uso di questi dispositivi è negativo perché comporta che il soggetto si definisca malato senza aver avuto prima una diagnosi. Poi osserva che già i problemi della patologia psichica sono difficilmente trattabili da un medico, figurarsi con un’applicazione che ha la pretesa di dare una risposta in breve tempo e un trattamento efficace in un paio di settimane. Tra le app più diffuse per combattere la depressione c’è Woebot, è un chatbot che dialoga con l’utente e gli chiede aggiornamenti sullo stato dell’umore e fornisce esercizi per migliorarlo. Ci sono anche applicazioni destinate ai bambini che addirittura tendono a sostituire i genitori nella funzione di rassicurarli. Una di queste aiuta a combattere la paura del buio. È una storia interattiva dal titolo Buona notte Dadà, che ha come protagonisti un bambino e alcuni minion che arrivano in suo soccorso. Anche la salute dei bambini è sempre più in mano ai Signori del Web.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/medicina-robot-futuro-2656207459.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="pierluigi-paganini-i-dati-sanitari-possono-essere-usati-a-fini-commerciali" data-post-id="2656207459" data-published-at="1641160803" data-use-pagination="False"> Pierluigi Paganini: «I dati sanitari possono essere usati a fini commerciali» «Le big tech come Amazon, Google, Apple sono già in possesso di una quantità di informazioni legate alle nostre abitudini e possono profilare ognuno di noi. Questo vale anche per la salute. Stiamo trasferendo moltissime indicazioni sul nostro stile di vita e quindi anche potenzialmente sui nostri punti deboli sanitari. Con braccialetti e dispositivi vari, il monitoraggio dello stato di salute è continuo. Questo apre scenari inquietanti. Chi utilizza le informazioni? Siamo sicuri che non vengano rivendute e utilizzate per finalità commerciali?». Pierluigi Paganini, tra i massimi esperti di cibersicurezza, collabora al Sistema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali del ministero dell’Economia. Lei ha approfondito il tema della presenza sempre più invadente dei colossi del Web nel settore sanitario. Cosa ha scoperto? «Ci sono aspetti positivi in questi dispositivi tecnologici, come la possibilità di essere avvertiti in tempo di irregolarità nel battito cardiaco e prevenire l’infarto. Ma anche risvolti preoccupanti che vanno valutati e sui quali intervenire». A cosa si riferisce? «I dati personali sulla salute possono essere usati anche a fini discriminatori oltre che commerciali, che non hanno niente a che vedere con il benessere». Ci fa qualche caso? «Le informazioni sulla salute potrebbero essere vendute dalle big tech a compagnie di assicurazione. Le società che hanno necessità di stipulare una polizza per i loro dipendenti potrebbero discriminare tra individui ai quali dare una polizza sulla base di dati personali riservati. Chi ha patologie di cuore, ma anche chi conduce una vita molto sedentaria e ha problemi con il colesterolo e cattive abitudini alimentari, può essere, in prospettiva, un soggetto a rischio. In questo caso la polizza potrebbe risultare più costosa. La cosa potrebbe estendersi al mercato del lavoro». Intende che i dati sulla salute diventerebbero discriminanti nei colloqui di assunzione? «È un rischio. Sempre più spesso le società guardano alla presenza sui social del candidato per avere più informazioni oltre a quelle fornite dal curriculum. Se ne deduce l’orientamento politico, l’impegno sociale, gli interessi principali. Tutto concorre a profilare una persona. A queste informazioni potrebbero aggiungere quelle relative alla salute acquisite dalle banche dati dei grandi operatori del Web. Chi ha determinate patologie o fragilità è più a rischio di assenze, potrebbe risultare meno produttivo. Ecco che i dati diventano un fattore di discriminazione. La conoscenza dello stato di salute potrebbe essere usato dalle società di recruiting». Per esempio? «Se dal monitoraggio del battito cardiaco emerge che un soggetto si emoziona facilmente, potrebbe non essere indicato per attività che lo sottopongono a stress». Le big tech quindi avrebbero di noi un quadro totale che potrebbero rivendere? «Noi diamo a Amazon, Apple, Google, continuamente una serie di informazioni sul nostro stile di vita. È facile sapere chi è single, chi vive da solo, chi fa poco movimento fisico, le abitudini alimentari, il livello di socialità. Questi dati incrociati con le indicazioni sul battito cardiaco, il numero di passi giornaliero, il livello di ossigeno nel sangue, la pressione arteriosa, danno molto più di un’anamnesi medica. Bracciali e orologi digitali multifunzionali fanno un monitoraggio 24 ore su 24, ci seguono costantemente, hanno la situazione sotto controllo. È come avere un medico che ci segue tutto il giorno. Le informazioni aggregate concorrono a profilare una persona e a valutare il livello di rischio legato ad alcune sue abitudini. Amazon conosce i nostri acquisti, sa se sono solito comprare oggetti di sport e dall’Apple watch sa se faccio sport, se sono attivo, se cammino o vivo in modo sedentario. Non è fantascienza: è la realtà». Però a qualcuno il braccialetto che misura il battito cardiaco ha salvato la vita. «Non dico che il monitoraggio sia un male assoluto. Il tema è l’uso che si fa di tali dati. Se usati da un istituto pubblico possono essere utili a determinare il rischio di esposizione alle malattie di una comunità e quindi a intervenire in tempo con politiche di prevenzione mirate. Si avrebbero risparmi della spesa sanitaria. Però c’è anche un uso distorto dei dati personali sulla salute». Chi controlla? «Al momento nessuno, la materia ha tante zone d’ombra e le big tech se ne approfittano. Il problema è chi gestisce le informazioni. Se è un ente che rappresenta la collettività c’è un vantaggio, mentre un ente privato può farne usi commerciali e impropri. Chi è in grado di aggregare i dati personali ha in mano un potere enorme. Una volta profilato un soggetto, si può influenzarne le abitudini e lo stile di vita inducendo determinati acquisti». C’è chi sta invece facendo un uso virtuoso di questi dati sanitari? «Alcune cliniche stanno lavorando a progetti di ricerca per dispositivi che consentono di monitorare lo stato di salute in tempo reale. Così si riducono i tempi di ospedalizzazione e diminuisce la frequenza con cui si è obbligati a ricorrere alla clinica. Una sorta di scatola nera sanitaria. Questo è utilizzo virtuoso, si agisce in modo tempestivo su qualsiasi problematica. Un battito cardiaco anomalo è intercettato e la clinica chiede di fare subito un controllo. Il paziente è più seguito e la struttura riesce a ottimizzare il servizio che offre sulla base della disponibilità di medici e strutture». <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/medicina-robot-futuro-2656207459.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="pier-luigi-bartoletti-fimmg-i-dati-sanitari-possono-essere-usati-a-fini-commerciali" data-post-id="2656207459" data-published-at="1641160803" data-use-pagination="False"> Pier Luigi Bartoletti (Fimmg): «I dati sanitari possono essere usati a fini commerciali» «Arriveremo al punto che Glovo, insieme con la pizza, ci porterà anche le medicine. Ormai il rapporto con i dispositivi della salute e con Internet è diventato ossessivo. Non sono contrario al bracciale che indica il battito cardiaco, ma non deve condizionare la vita. Non si può stare fissi sul display, entrare in agitazione e temere l’ictus se i battiti aumentano magari dopo una rampa di scale a piedi». Pier Luigi Bartoletti è vicesegretario della Fimmg, la Federazione italiana dei medici di medicina generale. Ha rilevato un aumento esponenziale dell’uso del Web per i temi della salute e l’acquisto esagerato di prodotti solo perché consigliati dalle chat o da qualche sito che rivendica inattendibili competenze scientifiche. Racconta Bartoletti: «Ho pazienti che vengono in ambulatorio con la presunzione di indicarmi le cure che dovrei prescrivere solo perché lo hanno letto in Rete. Oppure manifestano disturbi perché, dopo aver seguito le indicazioni di un fantomatico sito sulla prevenzione al Covid, hanno fatto scorpacciata di integratori». Scherza? «Giorni fa si è presentata una paziente giovane con le mani arancioni. Era agitata perché, in base a Internet, temeva di avere qualche problema al fegato. Dopo una breve chiacchierata viene fuori che aveva mangiato troppe carote ritenendole un pieno di vitamine utile contro il Covid. In più aveva abusato di integratori. È bastato tornare all’alimentazione normale e tutto si è stabilizzato. Ma convincerla è stato faticoso, in lei c’era una convinzione granitica a base di citazioni da questo o quell’altro sito di fanatici vegetariani. C’è anche chi pretende di fare le analisi del sangue ogni tre mesi». Bartoletti sottolinea che la pandemia ha cambiato il rapporto con la medicina: «C’è un’attenzione quasi ossessiva alla salute. Ben venga la sensibilità a un più corretto stile di vita, peccato che spesso si seguono indicazioni sbagliate. Il braccialetto che indica i battiti cardiaci più essere utile per responsabilizzare il soggetto verso comportamenti corretti, ma va usato con la giusta distanza: non può indurre a un atteggiamento compulsivo. Il cambiamento di alcuni valori in modo fisiologico non può creare il panico. L’informazione su Internet ha una sua utilità perché stimola nel paziente un’attenzione maggiore al suo benessere e impone al medico un aggiornamento continuo, di essere al passo con i tempi. Ma il Web non può sostituire il medico». Per Bartoletti questo rischio è reale: «Sorgono esperti ovunque. I dispositivi tecnologici vanno usati con il dovuto distacco. Va bene se hanno un effetto ansiolitico ma non se hanno un effetto ansiogeno». Gli integratori, per esempio: «Fino a qualche anno fa era un mercato residuale. Ora i consumi sono aumentati e non per questo la salute è migliorata. Anzi spesso si fa un abuso di tali sostanze che come è stato provato, è dannoso. C’è chi, pur essendo vaccinato, continua a fare tamponi ogni settimana o il test sierologico con una frequenza fuori da ogni protocollo». Tutto questo ha un risvolto economico. La spesa è aumentata. E chi non riesce a far fronte ai rincari di alcuni prodotti determinati dall’incremento della domanda, ricorre a scorciatoie: Bartoletti ha notato «un aumento delle richieste di invalidità per avere le medicine gratuite».
Michela Moioli posa con la sua medaglia di bronzo durante la cerimonia di premiazione della finale femminile di snowboard cross ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, a Livigno (Ansa)
La quiete dopo la tempesta. Dopo la sbornia di giovedì, con gli ori che ancora luccicano al collo di Federica Brignone e Francesca Lollobrigida e l’argento di Arianna Fontana, la decima giornata dei Giochi invernali in corso a Milano-Cortina ha portato all’Italia una sola nuova medaglia, la diciottesima di questa Olimpiade casalinga, e qualche delusione.
L’emozione più grande l’ha regalata Michela Moioli, protagonista di una vera e propria impresa che rispetto a quelle firmate dalla Tigre di La Salle o dalla Freccia bionda - per chi non lo sapesse sono i soprannomi da battaglia di Brignone e Fontana - ha da invidiare soltanto il colore del metallo. Perché anche qui siamo in presenza di qualcosa di epico. La trentenne di Alzano Lombardo ha conquistato un bronzo insperato nello snowboard cross, completando con coraggio una rimonta che resterà nella memoria, non solo della disciplina che si svolge sulla tavola, ma dello sport in generale. Sulla pista di Livigno, Moioli ha dovuto recuperare dallo svantaggio nei confronti delle avversarie ben due volte: prima in semifinale, superando la francese Lea Casta e l’austriaca Pia Zherkhold, poi nella big final, dove ha ripreso e superato la svizzera Noemie Wiedmer negli ultimi metri, fino a scavalcarla sul terzo gradino del podio. Podio completato dall’australiana Josie Baff, medaglia d’oro, e dalla ceca Eva Adamczykova, argento. E dire che l’avventura olimpica della campionessa azzurra non era iniziata sotto i migliori auspici. Una caduta in allenamento, pochi giorni prima della gara, aveva messo a rischio la sua partecipazione. «Quando sono stata portata in elicottero a Sondalo ho pensato che i miei Giochi fossero finiti perché ero bella rintronata dalla caduta. Ieri che c’era la gara dei maschi sono stata tutto il giorno sul divano morta. E mi sono detta «Io domani come cacchio faccio», però ho una capacità di recupero notevole. Ho una squadra fortissima che mi ha aiutato in tutto e anche il Coni e l’Esercito. Comunque, è sempre la forza del cuore quella che fa la differenza ogni volta», ha raccontato Moioli mostrando le ferite ancora fresche sul suo volto a causa del trauma facciale riportato. «Sono così, tocco il fondo e risorgo come una fenice. Stavolta l’ho fatto con la faccia distrutta».
Se la gioia dell’atleta bergamasca ha illuminato la giornata di ieri, il biathlon maschile ha riservato invece una delusione per Tommaso Giacomel. Il trentino, tra i favoriti della 10 chilometri sprint, ha chiuso ventiduesimo a 1’43» dall’oro vinto dal francese Quentin Fillon Maillet. «Ho fallito, credo che questa fosse la gara più adatta a me e ho fallito. Sono molto deluso. Arrivare qui da favorito o comunque tra i favoriti e poi performare così male è una cosa che mi fa molto arrabbiare. Sinceramente non ho idea di cosa ho sbagliato. Non è finita, però la gara di domenica è già compromessa con il risultato di oggi», ha commentato Giacomel, visibilmente provato. I compagni di squadra Lukas Hofer, Nicola Romanin ed Elia Zeni hanno chiuso rispettivamente tredicesimo, sedicesimo e oltre la cinquantesima posizione, mentre le altre due posizioni sul podio restano saldamente nelle mani dei norvegesi Vetle Sjåstad Christiansen e Sturla Holm Laegreid. L’altra amarezza per i nostri colori è arrivata nel tardo pomeriggio dal pattinaggio di velocità maschile, dove i due azzurri Riccardo Lorello e Davide Ghiotto hanno chiuso la gara dei 10.000 metri fuori dal podio. Una delusione soprattutto per Ghiotto, che si avvicinava alla «gara dei re - così viene definita la competizione più combattuta e ambita del panorama del ghiaccio olimpico - da favorito e recordman mondiale su questa distanza, oltre che vincitore di tre titoli iridati consecutivi.
Dal ghiaccio della pista lunga di Rho Fiera, dove si svolgono le gare di pattinaggio di velocità, a quello dell’Arena Santa Giulia. Nemmeno l’hockey maschile può gioire: la nazionale allenata dal ct finlandese Jukka Jalonen ha affrontato alla pari la Slovacchia, ma ciò non è bastato per evitare la seconda sconfitta (3-2) nel torneo olimpico dopo quella patita all’esordio contro la Svezia.
In una giornata «povera» di medaglie, uno dei momenti più suggestivi per il pubblico italiano presente sugli spalti è arrivato nel corso della 10 chilometri sprint di biathlon. Il francese Emilien Jacquelin, grande tifoso di Marco Pantani, ha corso con l’orecchino che gli era stato regalato dalla famiglia del campione romagnolo e, in uno dei passaggi più intensi della gara, ha lanciato la bandana proprio come faceva il Pirata prima delle sue volate in salita.
Continua a leggereRiduci
Ansa
Il processo non è recente. Già nel 1963, sei anni prima del Sessantotto, l’Università di Stanford abolì il corso di Storia della civiltà occidentale. In Italia, il disastro è cominciato nel Sessantotto, che però è eterno, sembra non essere mai finito. L’idea del professore politicamente neutrale appare da decenni una delicata contraddizione in termini: «professore di sinistra» non è più una categoria sociologica, ma una normalità data per scontata. Antonio Gramsci teorizzò la necessità di occupare i gangli del potere - magistratura, scuola, spettacolo, giornalismo - e Palmiro Togliatti lavorò perché quella strategia diventasse realtà. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: l’egemonia culturale si è trasformata in senso comune e il dissenso è percepito come una colpa morale. Anche come colpa mortale.
Sergio Ramelli è stato ucciso e ancora si irride la sua morte. La storia di Sergio Ramelli è una di quelle che mettono a disagio perché non si lasciano archiviare con una formula. Non è una «tragica fatalità», non è un «clima di tensione», non è nemmeno un «errore». È una storia semplice e proprio per questo intollerabile: un ragazzo di 18 anni ucciso a colpi di chiave inglese per un tema scolastico scritto «male», o forse scritto troppo bene, o semplicemente scritto. Ramelli non era un personaggio con un qualche peso politico, non era un capo, non era nulla di particolarmente pericoloso. Era uno studente. Ma negli anni Settanta nell’Italia che custodiva il più potente Partito comunista del mondo occidentale, bastava poco per diventare colpevoli: bastava non essere dalla parte giusta. La sua colpa fu di pensare fuori dal perimetro consentito. Il suo tema esprimeva concetti su cui si poteva e si può essere d’accordo o meno, ma era senza dubbio un tema molto ben argomentato.
Nei tempi decenti i temi potevano essere solo sull’analisi de L’Infinito di Giacomo Leopardi o sulla figura di don Abbondio. In tempi ignobili i temi sono di «attualità», vale a dire di politica, vale a dire di indottrinamento, perché il tema di Ramelli era comunque un ottimo tema e prese un’insufficienza, dimostrando che la libertà di opinione millantata dalla nostra costituzione è, insieme a «La legge è uguale per tutti», uno spettacolare esempio di umorismo involontario. E l’insufficienza è ancora il meno. La scuola, che avrebbe dovuto proteggerlo, lo segnalò. La politica, che avrebbe dovuto ignorarlo, lo marchiò. La violenza, che non aveva bisogno di molte giustificazioni, fece il resto. Sergio Ramelli morì dopo settimane di agonia. Ne dà una dolente testimonianza sua madre, che giorno dopo giorno gli tenne la mano sperando in un miracolo che non venne, mentre sui muri e sui ciclostili si sghignazzava per l’agonia e la morte del suo ragazzo. E per molto tempo, più della sua morte, fece rumore il silenzio. Un silenzio educato, responsabile, quasi morale, quello degli educati moralmente superiori, quello dei responsabili, perché alcune vittime disturbano l’educato e sempre etico arredamento ideologico. E allora si preferisce non nominarle, come certi parenti imbarazzanti alle cene di famiglia.
La storia di Sergio Ramelli non insegna nulla, dicono. Ed è proprio questo che fa paura. Insisto: un buon professore - come un buon magistrato - dovrebbe essere qualcuno di cui è impossibile indovinare le idee politiche. Non perché non ne abbia, ma perché non le manifesta nel suo lavoro e rinuncia persino a esibirle nello spazio pubblico, consapevole che la sua imparzialità, come la virtù della moglie di Cesare, deve essere al di sopra di ogni sospetto. Dove l’imparzialità è al di sotto di ogni sospetto, prendiamo atto che la moglie di Cesare è di facili costumi. Magistrati ufficialmente schierati arricchiscono la giurisprudenza di sentenze indubbiamente creative, mentre professori apertamente schierati stigmatizzano e deridono non solo idee politiche diverse dalle loro, ma anche posizioni etiche e religiose tradizionali. Il cristianesimo «forte» viene trattato come un residuo imbarazzante: dalla condanna dell’aborto come omicidio alla considerazione dell’cosiddetta omosessualità come peccato, ogni visione non conforme viene liquidata come segno di spregevole arretratezza morale. Per inciso: anche in epoca di pandemia Covid non pochi professori hanno manifestato pubblicamente la loro perplessità per gli studenti non inoculati e li hanno indicati al pubblico ludibrio come potenziali untori. I professori che non si sono inoculati sono stati sospesi senza stipendio e i loro colleghi lo hanno trovato giustissimo, vista la mancanza di una qualsiasi forma di solidarietà. Quando poi sono rientrati, questi docenti non hanno potuto subito insegnare: c’era il rischio che insegnassero la libertà e il coraggio. Sono stati rinchiusi negli sgabuzzini e nei sottoscala a contare i ragni. Così la scuola, da luogo del sapere, diventa spazio di rieducazione. E il professore imparziale resta, appunto, una creatura mitologica.
A chiarire la natura profonda di questo processo è stato il filosofo francese Jacques Ellul. Nel suo libro Propaganda, Ellul spiega che il mezzo più potente di indottrinamento nelle società moderne non è la propaganda esplicita dei regimi totalitari, bensì quella silenziosa e pervasiva delle democrazie avanzate, una propaganda che «educa». Secondo Ellul, la scuola rappresenta lo strumento privilegiato di questo meccanismo, perché non solo in non pochi casi arrotondi la realtà, per cui, ad esempio, le decine di milioni di vittime del comunismo sono scomparse, ma perché seleziona i quadri mentali attraverso cui le nozioni vengono interpretate. L’indottrinamento moderno non consiste nel dire cosa pensare, bensì nel delimitare ciò che è pensabile. Una volta interiorizzati certi presupposti morali e ideologici, il soggetto crede di ragionare liberamente, mentre in realtà si muove all’interno di un recinto invisibile. Ellul sottolinea come l’educazione sia particolarmente efficace proprio perché rivolta ai giovani, quando le difese critiche non sono ancora formate e l’autorità dell’istituzione scolastica gode di una legittimazione quasi sacrale. Ciò che viene insegnato a scuola non viene percepito come opinione, ma come evidenza, non come ideologia, ma come neutralità scientifica. È in questo modo che la propaganda diventa totalizzante: quando smette di apparire come tale. Applicata al contesto contemporaneo, l’analisi di Ellul illumina con precisione inquietante il funzionamento della scuola odierna. Non si tratta più di discutere la storia, ma di giudicarla; non di comprenderla, ma di condannarla. L’Occidente non è studiato come civiltà complessa, contraddittoria e plurale, bensì come colpevole originario da decostruire. E lo studente non è chiamato a formarsi un’opinione, ma a espiare. Solo odiando l’Occidente e spaccando la testa di Sergio Ramelli o del poliziotto che cerca di proteggere Torino guadagnerà l’innocenza. In questo quadro, il pluralismo non è assente per caso: è strutturalmente incompatibile con l’obiettivo. Perché, come Ellul avvertiva, la propaganda più riuscita è quella che riesce a presentarsi come educazione morale. E la scuola, da luogo del sapere, diventa così il più efficiente laboratorio di conformismo spietato. Sia coloro che hanno spaccato le ossa del cranio di Sergio Ramelli, che quelli che hanno tentato di spaccare quelle del poliziotto aggredito a Torino, sono studenti: frutti di una scuola ideologizzata, quindi, per definizione, una scuola cattiva, anzi pessima, l’ultimo baluardo della mai veramente defunta Unione sovietica. È la scuola che ha armato con la chiave inglese o il martello.
Continua a leggereRiduci
«Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» (Disney+)
Allora, si dice la passione fosse ormai sopita, logorata da un'esposizione mediatica eccessiva, da incomprensioni e battibecchi, da un chiacchiericcio che, a distanza di oltre venticinque anni, ancora non ha perso veemenza. Cosa sia successo dentro quell'amore da filma, tra persone che sembravano essersi scelte senza riserve, sole tra mille, nessuno lo ha mai saputo con certezza. La cerchia di John F. Kennedy Jr. riferisce di sensibilità diverse, cuori distanti. Voleva figli, l'erede della dinastia Kennedy. Si avvicinava ai quaranta e avrebbe voluto la moglie gli consentisse di allargare la famiglia.
Ma Carolyn non avrebbe avuto alcun istinto materno. Carolyn, ex commessa con un lavoro nella moda. Carolyn, che le cronache descrivono cocainomane. Carolyn, che nei racconti degli amici voltava la testa dall'altra parte, ogniqualvolta il marito toccava l'argomento.Gli affetti più cari di John John sostengono lui stesse per chiedere il divorzio. Prima, però, sarebbe andato al matrimonio della cugina, portando con sé la moglie, un abito nero di Yves Saint Laurent comprato da Saks, e la cognata. Guidava lui il Piper Saratoga che, il 16 luglio 1999, è decollato alla volta di Martha's Vineyard, senza mai arrivarvi. Quel piccolo aereo è caduto nel mare, John e Carolyn sono morti, con loro la sorella di lei. L'amore da film s'è interrotto quel giorno, è finito prima che un giudice lo rendesse carta straccia, prima che i giornali facessero a pezzi il ricordo di quel che erano stati. La coppia più bella degli Stati Uniti d'America è morta, e - venticinque anni più tardi - è una serie tv a ritrovarla.
Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, su Disney+ a partire da venerdì 13 febbraio, vuole ricostruire quell'amore da film. Dagli inizi, dal primo incontro all'interno di Calvin Klein, quando Carolyn, bionda ed etera, si era ormai affrancata dal ruolo di commessa per diventare dirigente e confidente di CK. Lo show, che alla regia porta la firma di Ryan Murphy, racconta come la coppia si sia innamorata, come lo scapolo d'oro sia diventato marito, gli americani pazzi di quel duo-gioiello. Ma racconta altresì come i media, la sovraesposizione, abbiano pian piano minato la serenità della coppia. Di Carolyn, in particolare, una donna della porta accanto che non avrebbe mai voluto essere oggetto della bulimia dei rotocalchi.
Continua a leggereRiduci
A spiegarci di che cosa si tratti è stato anche il Corriere della Sera, che giovedì così titolava la recensione: «Gestazione per altri, storia di solidarietà». Ovvero, come far passare la pratica dell’utero in affitto per «una storia d’amore, solidarietà, rispetto, al di là di ogni ideologia». Potenza artistica della rappresentazione, di e con Rossella Fava, autrice e attrice, che sui social racconta di aver «preso spunto dalle interviste che ho realizzato nel giro di un anno, a uomini e donne che hanno affrontato percorsi di Pma e Gpa».
Sulla piattaforma del Teatro della Cooperativa lo spettacolo viene presentato come «un testo importante e necessario che affronta un tema complesso e ancora troppo poco conosciuto, di estrema delicatezza, e che nel nostro Paese, a differenza di altri, fatica ancora a trovare una legislazione più giusta e più umana».
Senza mezzi termini, si definisce dunque disumana la legge italiana che vieta la surrogata e la rende reato universale. Non bastasse, viene lanciata questa provocazione: «Oggi chi è madre? Chi un bambino lo partorisce o chi lo desidera e lo cresce?».
E per togliere anche l’ultimo dubbio sulla collocazione ideologica dell’iniziativa, il pubblico è informato che domenica 15 febbraio «al termine dello spettacolo, ci sarà un incontro con Francesca Re, avvocato e consigliere generale dell’Associazione Luca Coscioni Aps», che vuole la legalizzazione dell’eutanasia, la gestazione per altri e le tecniche di fecondazione assistita per le coppie dello stesso sesso. Venerdì prossimo, 20 febbraio, sempre al termine dello spettacolo «ci sarà un incontro con l’Associazione Famiglie Arcobaleno», composta da genitori Lgbt.
«Non conosco questo spettacolo ma il modo in cui viene presentato è sufficientemente eloquente. C’è un continuo, tenace tentativo di presentare l’utero in affitto come un gesto solidale, mentre è una organizzazione commerciale, sempre regolata da un contratto e da passaggi di denaro», interviene con fermezza Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità. «È una pratica che lede nel profondo la dignità delle donne e i diritti dei bambini. Nonostante la ricerca spasmodica di storie che dimostrino il contrario, la verità è che dietro l’utero in affitto c’è un mercato transnazionale che commercializza i corpi, i bambini, la genitorialità. Ci sono dei contratti molto rigidi, delle penali, uffici legali e clausole durissime, cataloghi di ovociti come fossero merce da banco, giri vertiginosi di denaro, del quale di norma alle donne bisognose che portano avanti le gravidanze vanno le briciole».
Il ministro sottolinea: «In Italia l’organizzazione, la realizzazione e anche la pubblicizzazione di queste pratiche è reato da più di vent’anni, e la legge approvata in questa legislatura, che impedisce di aggirare il divieto e rende l’utero in affitto punibile per i cittadini italiani anche se vanno all’estero a praticarlo, pone il nostro Paese all’avanguardia nella lotta per i diritti delle donne e dei bambini. Siamo un esempio per il mondo, e stiamo lavorando per costruire un’alleanza internazionale contro questa barbarie. Nessun tentativo di “normalizzarla” o spacciarla per una pratica solidale potrà cambiare la realtà».
Invece, in questi giorni la maternità surrogata viene spacciata come un gesto altruistico lanciando un messaggio devastante dal palcoscenico di un teatro che riceve contributi statali e regionali. L’associazione, fondata nel 2002 dal drammaturgo, regista e attore Renato Sarti e che ha come obiettivo «fin dalla sua fondazione, la promozione dei valori della memoria storica e dell’antifascismo», mostra la contabilità solo fino al 2024. In quell’anno aveva ricevuto dal ministero della Cultura 113.838 euro; dalla direzione Cultura area spettacolo del Comune di Milano 52.898,18 euro; dalla Regione Lombardia, direzione generale cultura, tre acconti per complessivi 20.800 euro. Gli anticipi 2025 del ministero della Cultura sono di 63.555,76 euro; dalla Regione Lombardia di 27.000 euro. L’acconto contributo per le attività 2026 è di 18.900 euro, 18.900 euro l’importo per quelle del 2027. Sicuramente le cifre liquidate saranno ben superiori. Nella graduatoria Next - Laboratorio delle idee per la produzione e programmazione dello spettacolo lombardo 2025/2026, «M(Other)» era stato selezionato con il punteggio 73 su 100. E aveva ricevuto un «rimborso spese» di 10.500 euro.
Alla trasmissione Il Suggeritore Night Live di Radio Popolare, a cura di Ira Rubini, Rossella Fava ha spiegato di essere cresciuta «con l’immagine della donna con il pancione e che partorendo sarebbe stata lei la mamma del bambino ma oggi, grazie al progresso della scienza e della tecnica in maniera di procreazione, grazie alla gestazione per altri, di madri tra virgolette ce ne possono essere fino a tre. La donna che partorisce il bambino, la donna che fornisce il materiale genetico e la donna che invece lo desidera e lo crescerà. La mamma diventa doppia o trina». Ecco, con quale atteggiamento si affronta a teatro un reato universale. Sempre a Radio Popolare, il regista Sarti (che a settembre era tra coloro che manifestavano «giù le mani dal Leoncavallo»), ha definito «bella l’dea di tre donne in un unico corpo, soprattutto in un periodo di maschilismo esasperato».
Continua a leggereRiduci