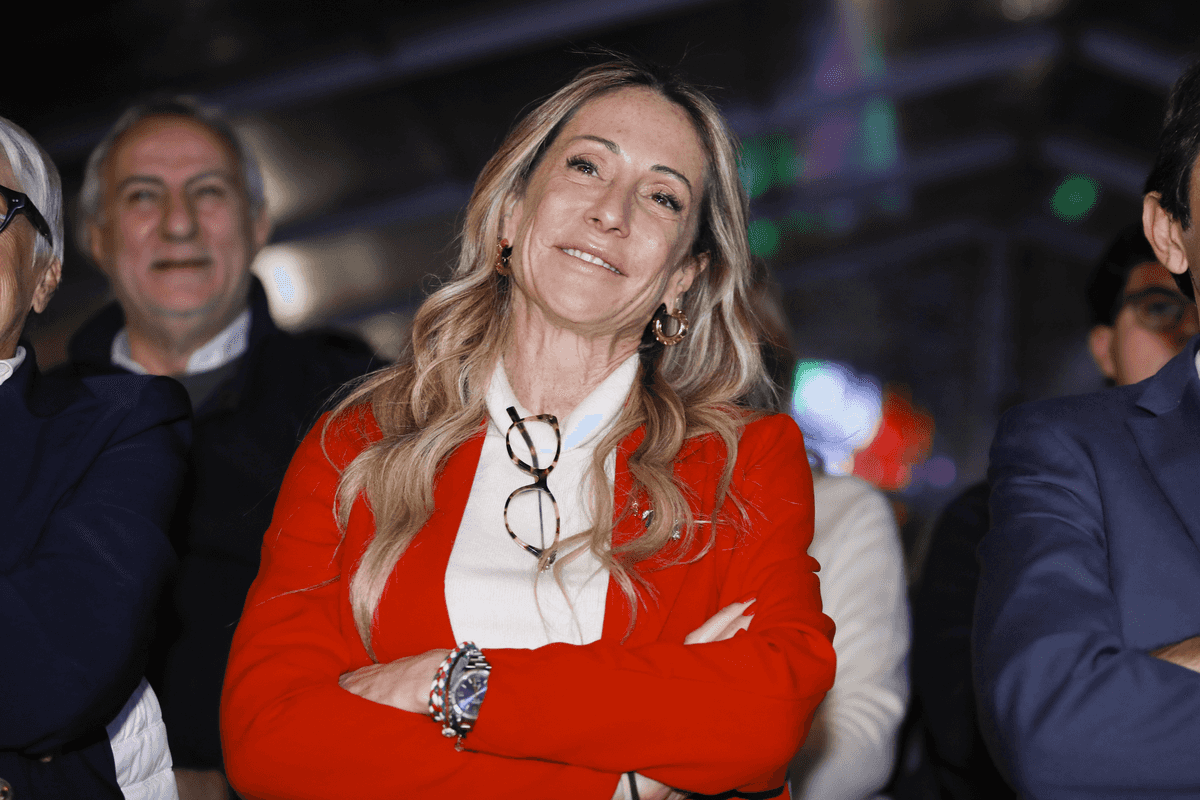I migranti ci pagheranno le pensioni, ridando vitalità e freschezza ai nostri Paesi. Soprattutto, ci aiuteranno a superare l'inverno demografico. Perché sono loro, e solo loro, la nostra speranza. È quanto assicurano da anni i soloni progressisti, convinti che l'Europa del futuro sarà multietnica o semplicemente non sarà. Chiusura delle frontiere vorrebbe dunque dire morte, seguendo questa logica.
Peccato che l'Ungheria del vituperato Viktor Orbán, uno che i migranti non li vuol vedere manco dipinti, racconti un'altra storia. La storia di un Paese che non solo non collassa, ma pare avviato verso una nuova primavera demografica. A farlo presente non è qualche esaltato populista, bensì Lyman Stone, ricercatore presso l'Institute for Family Studies formatosi alla George Washington University, il quale in una lunga analisi significativamente intitolata Is Hungary Experiencing a Policy-Induced Baby Boom? racconta proprio questo: in un'Europa dalla natalità cimiteriale, l'Ungheria si sta rialzando. Lentamente e faticosamente, ma lo sta facendo. Per spiegare questo fenomeno inaspettato, Stone si addentra in profondità nei dati facendo anche una cronistoria delle politiche pro family varate sotto Orbán.
Nel 2015, viene per esempio ricordato, il governo ungherese aveva introdotto un'importante politica di nuovi sussidi per chi intende acquistare o costruire nuove case, in misura favorevolmente progressiva in base al numero dei figli. Le più agevolate dal provvedimento erano difatti le coppie sposate con tre o più figli, nuclei ai quali andava l'equivalente di 36.000 dollari di sovvenzione per l'acquisto di una nuova casa, in aggiunta ad altre detrazioni e a un prestito a interesse limitato per parte del valore dell'immobile. Un signor aiuto, nulla da dire.
Ma se le donne ungheresi stanno tornando a fare figli, segnala Stone, non lo si deve a questi pur generosi aiuti, per lo più destinati a famiglie già formate e che numerose lo erano già. Tanto è vero che i grafici delle nascite mensili non mostrano crescite, anzi l'inizio del 2018 risulta peggiore di quello del 2017. «Tuttavia, se dal dato mensile grezzo dei nati ci si focalizza sul tasso di fecondità totale, valore che riassume in una cifra la capacità riproduttiva di una generazione di 1.000 donne non toccate da mortalità», osserva Stone, «vediamo come questo stia aumentando rapidamente. Ed è cosa insolita, dal momento che la maggior parte dei Paesi in tutto il mondo sta attualmente vivendo una fertilità stabile o in calo, soprattutto in Europa». «Quindi», conclude lo studioso spiegando che il Paese è passato da 1,2 nascite per donna nel 2011 a 1,5 nel 2017, «molto probabilmente sta accadendo qualcosa di interessante nella fertilità ungherese, qualcosa che merita di essere esplorato». Già, ma se non sono stati i sussidi per la casa, come si spiega tutto questo? Le cause della ripresa della natalità sembrano essere due. La prima, più prevedibile, riguarda le esenzioni fiscali. Infatti, nel 2011 e nel 2012, in Ungheria sono state varate esenzioni per i figli.
Una scelta politica che, secondo alcune stime, nel 2011 e nei due anni successivi ha favorito la nascita di un numero tra i 6.000 e i 18.000 bambini in più. Fatto positivo, ma strano se si considera che queste esenzioni erano economicamente inferiori rispetto ai sussidi per la casa. Significa che negli incentivi alla natalità il messaggio culturale prevale sul dato economico. Una cosa talmente vera che, secondo Stone, il segreto della crescita del tasso di fecondità totale, più che nei pur utili aiuti economici, risiede in un secondo fattore: l'aumento del numero dei matrimoni.
Si è infatti visto come, a partire dal 2012, ma con segnali consistenti nel 2015 e nel 2016, in Ungheria le donne si siano mostrate rispetto agli anni precedenti più propense a sposarsi. Come mai? Grazie alla discussa Costituzione modificata nel 2011. Accusato di essere anacronistico e patriarcale, è un testo che in effetti ripone grande fiducia nelle nuove generazioni, specie laddove recita: «Noi mettiamo la nostra fede in un avvenire modellato insieme, nella vocazione delle giovani generazioni. Noi crediamo che i nostri bambini e i nostri nipoti avranno il talento, la tenacia e la forza morale per restituire la grandezza dell'Ungheria».
Sarebbe dunque questo fiducioso richiamo ai «nostri bambini e nipoti» il primo, vero incentivo alla famiglia e dunque alla natalità ungherese. Beninteso, questo non significa che Orbán faccia i miracoli, anzi con 1,5 figli per donna i tassi di fertilità sono ancora bassi e probabilmente, a detta di Stone, nonostante gli enormi sforzi governativi il Paese non raggiungerà a breve il tasso di sostituzione, pari a 2,1 figli per donna. Meglio andarci piano, insomma, prima di gridare al baby boom.
Tuttavia, in un'Europa moribonda quella ungherese suona come una lezione. Perché ci ricorda l'inscindibile legame tra matrimonio e figli, più volte sottolineato da studiosi come Roberto Volpi, che ha spesso evidenziato come per la natalità il fattore culturale conti come quello economico, se non di più. Soprattutto, la lezione ungherese fa a pezzi la narrativa immigrazionista secondo cui senza stranieri addio, siamo fritti. Chi ancora lo pensa faccia pure un giro dalle parti di Budapest. Poi ne riparliamo.