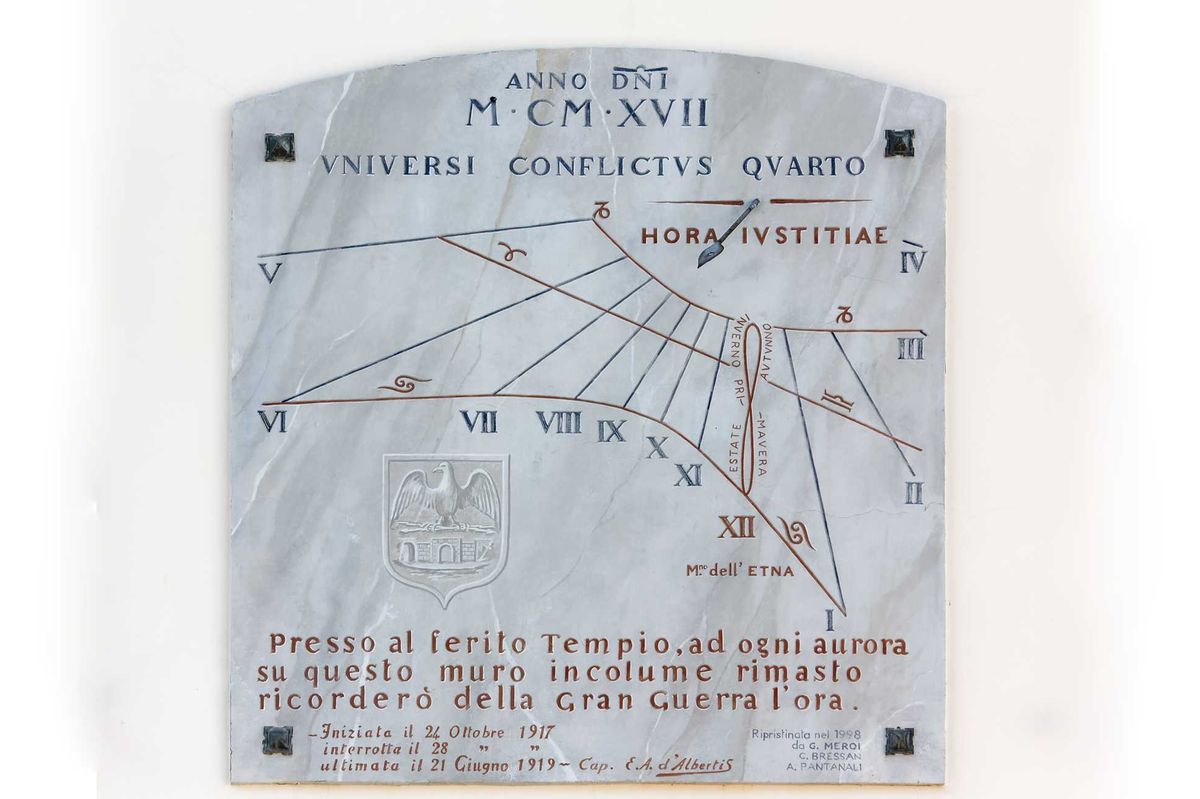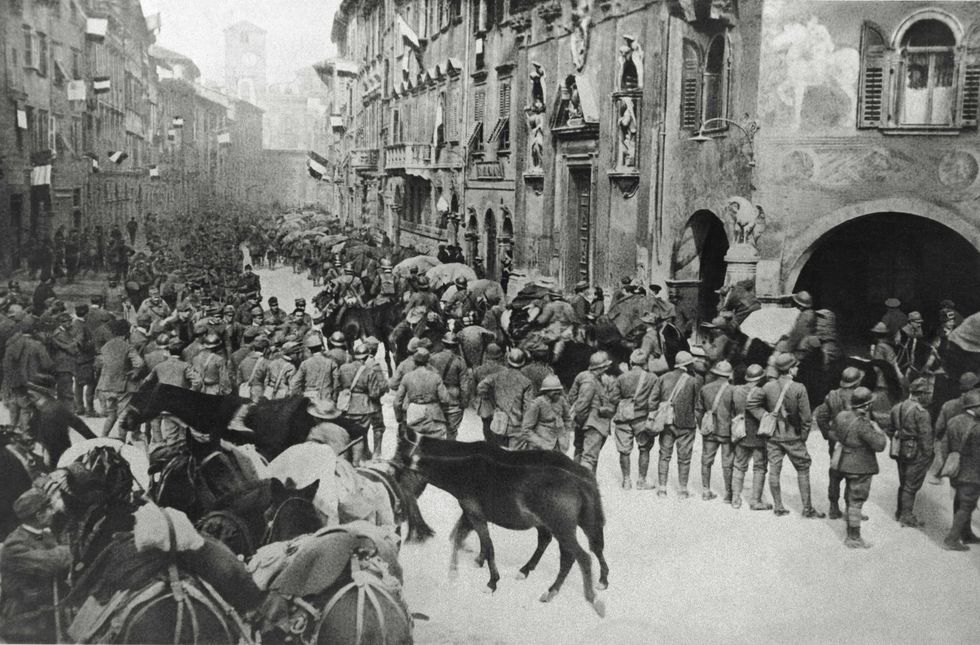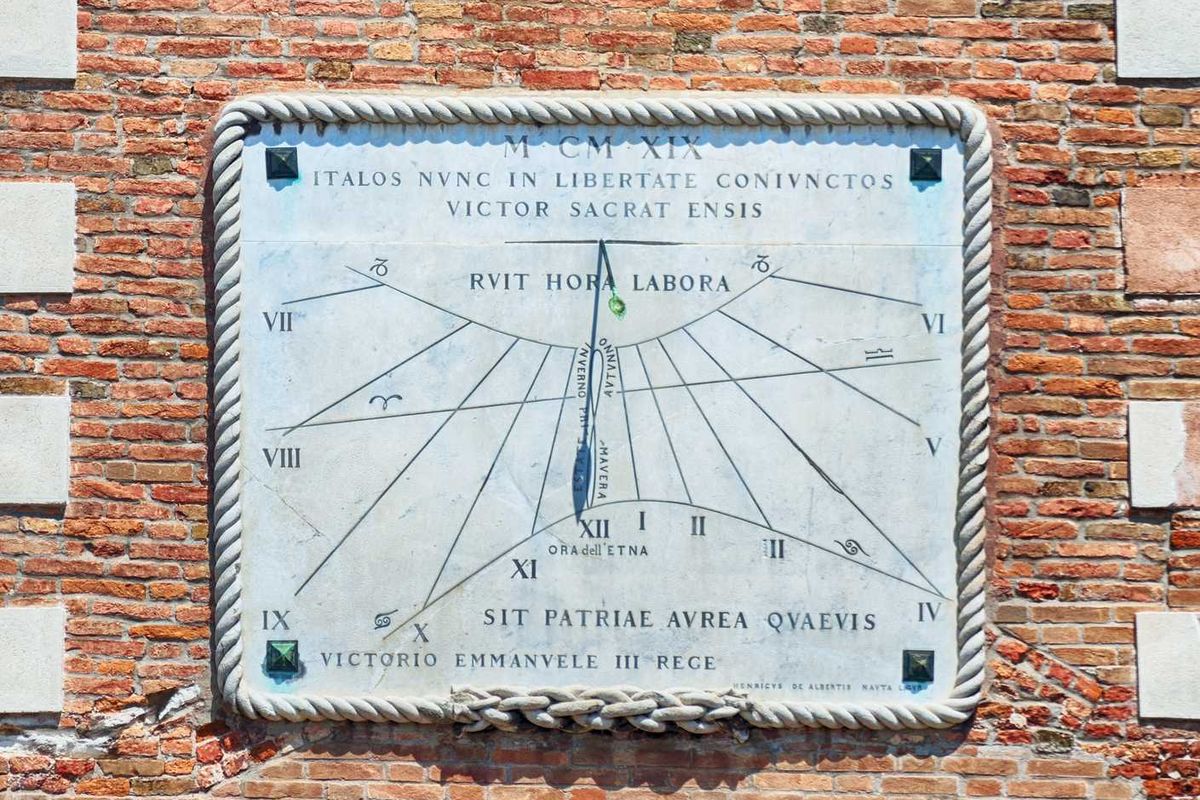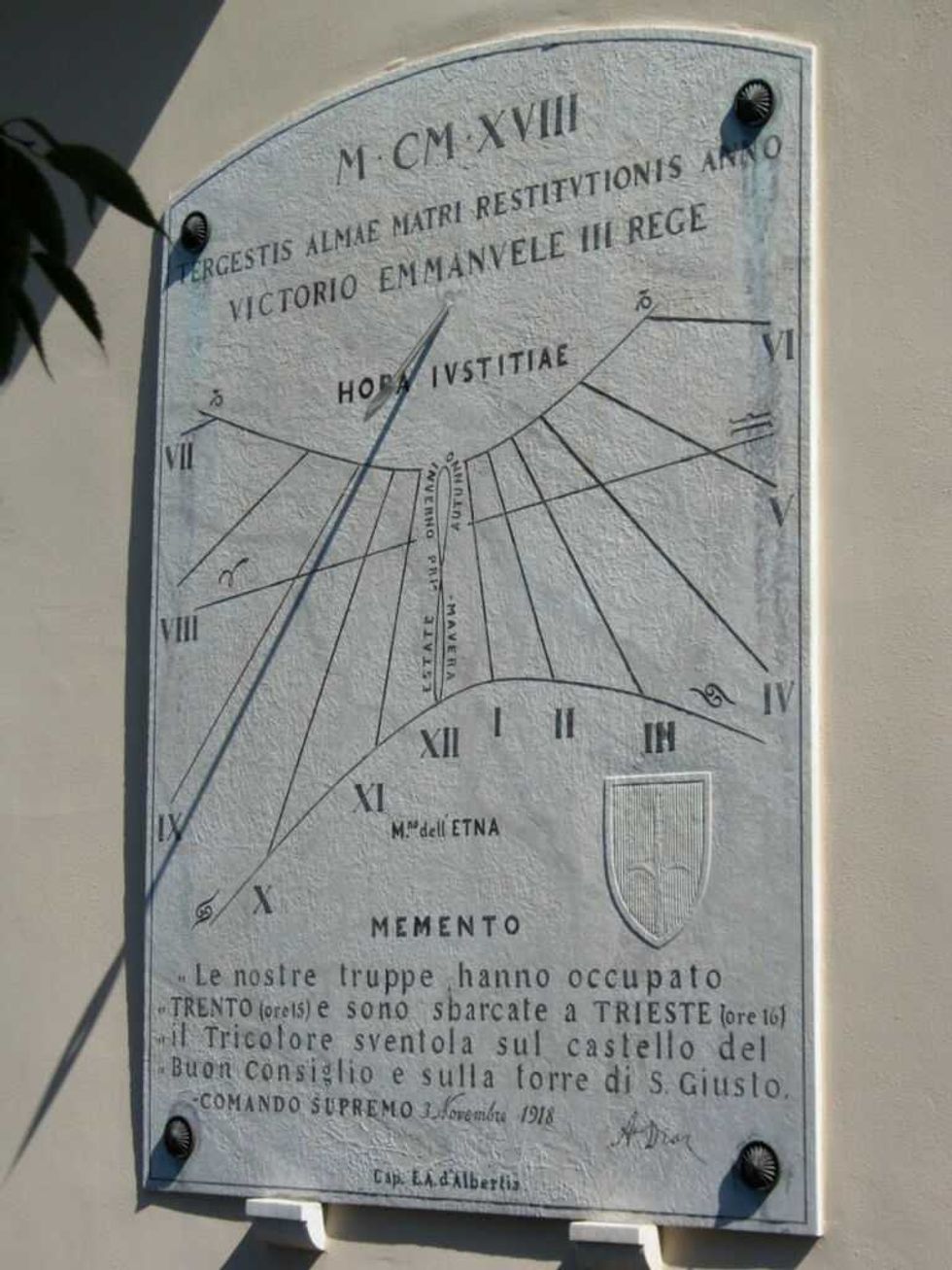«Ho riletto gli atti del caso di Erba. Su Rosa e Olindo non ci sono dubbi, sono colpevoli»

Più che un detective, Luciano Garofano preferisce essere definito un esperto. La mission della sua carriera si è fondata sulla scrupolosa applicazione dell’analisi scientifica agli elementi della scena di un delitto. Divenne noto volto televisivo nell’inverno 2002, all’epoca dell’incredibile caso dell’infanticidio di Cogne. Romano, classe 1953, biologo forense, comandante del Ris di Parma dal settembre 1995 al novembre 2009, oggi generale in congedo dei carabinieri, le sue investigazioni nelle più infinitesimali tracce biologiche repertate proseguono, essendo assai richiesto come consulente dall’autorità giudiziaria o da studi legali. Il suo viaggio alla ricerca nell’imperfezione del crimine iniziò nel 1978 al Centro carabinieri investigazioni scientifiche (Cis). Si è occupato dei più clamorosi fatti di sangue accaduti in Italia, con risultati spesso risolutivi. È specialista nell’analisi del Dna e della morfo-dinamica delle macchie di sangue (Bpa) e ha scritto numerosi libri. Ogni venerdì sera appare a Quarto grado, su Rete 4. La sua divulgazione di dettagli scientifici per far emergere verità su orribili crimini, nel ciclo L’altra metà del crimine, su La7d, ha fatto scuola.
Quando è nata la sezione d’investigazione scientifica dei carabinieri e oggi a che punto siamo?
«La prima costituzione di una branca tecnico-scientifica dei carabinieri risale al 1955, con compiti soprattutto formativi. Nel 1976, con la nascita, a Roma, del Cis, si ebbe una svolta. Poi, negli anni ’90, furono costituiti i Ris di Roma, Messina, Parma e Cagliari, che si occupano dei casi più importanti. Nel 1978 eravamo poco meno di 20. Oggi la struttura annovera circa 400 persone, con sempre più personale laureato».
Che differenza c’è tra un indizio e una prova?
«La prova scientifica ha una forza dimostrativa intrinseca. Un’analisi del Dna che corrisponde al profilo dell’indagato non basta, ma ha una forza dimostrativa maggiore. Un indizio, invece, deve essere dimostrato. Gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti. Un solo indizio non è sufficiente per dimostrare la colpevolezza di una persona».
I processi indiziari sono diminuiti?
«Indubbiamente sì, perché l’apporto tecnico-scientifico è notevole, pensiamo ai cellulari, ai sistemi di video-sorveglianza, all’analisi di tracce e reperti. Però i processi indiziari esistono ancora e sono i più difficili».
E gli errori giudiziari?
«Gli errori giudiziari sono diminuiti, ma non dobbiamo illuderci che la prova scientifica sia infallibile, perché, innamorandoci di essa, si rischiano clamorosi errori».
La correlazione tra Dna e profilo del colpevole è sempre inoppugnabile?
«Quasi sempre. Ma le porto il caso di Meredith Kercher. Le attività di sopralluogo furono eseguite secondo canoni non precisi di correttezza e completezza. L’analisi del Dna ha vacillato fino a non poter essere utilizzata. Oggi le tecniche analitiche sono talmente sensibili che siamo esposti al rischio di contaminazione. Se nel first responder non ci si muove con ordine rispetto ai protocolli, si rischia di devastare la scena del delitto».
Come evitare compromissioni?
«È il nostro tallone di Achille. La parte più esposta è quella dell’intervento dei soccorritori e della prima pattuglia. Bisogna entrare con guanti, mascherina e calzari, essere dotati di una body-cam che riprenda quella scena, ovviamente senza ritardare il soccorso».
Ci indica due casi di cui si è occupato in cui l’indagine scientifica ha fornito risposte inconfutabili?
«Ad esempio per il sequestro e l’omicidio di Tommaso Onofri (bambino di 17 mesi rapito a Casalbaroncolo, vicino a Parma, e ucciso, nel 2006, ndr). Attraverso un’impronta digitale su un frammento di nastro adesivo da pacchi, con cui i due autori avevano tentato di immobilizzare la famiglia Onofri, siamo risaliti a Salvatore Raimondi e poi a Mario Alessi, riconosciuti inconfutabilmente colpevoli e condannati. Poi, nel caso di Donato Bilancia (13 ergastoli, deceduto in carcere per Covid, nel 2020, ndr), noi del Ris di Parma, per primi abbiamo stabilito che in 8 omicidi su cui nessuno aveva capito esistere una connessione con i precedenti, sparava sempre la stessa arma. La raccolta di altri elementi attraverso il Dna e l’analisi dei residui dello sparo ci ha consentito di arrivare a Bilancia, tra i più feroci serial killer europei, 17 omicidi in 6 mesi. Abbiamo risolto il caso in 40 giorni, facendo un lavoro di squadra, con carabinieri e forze di polizia territoriali, un’osmosi che spesso manca».
Nelle indagini sull’assassinio di Desirée Piovanelli, 14 anni, accoltellata e sgozzata il 28 settembre 2002 in una cascina a Leno (Brescia), dopo un tentato stupro, da 3 coetanei e un adulto, tutti condannati, la tecnica della Bpa è stata fondamentale. E quella traccia di Dna di un maschio sconosciuto?
«La Bpa ci ha consentito di ricostruire tutte le fasi dell’aggressione, e la modalità con cui la povera Desirée cercava di sfuggire ai propri aguzzini, smascherando bugie degli indagati. La famiglia di Desirée vorrebbe una riapertura del processo, ritenendo che le cose non siano andate in quel modo. Io invece credo che siano andate così come sono state ricostruite, cioè che non ci sia stato nessun altro e che quel profilo maschile si riferisca a una contaminazione che non ha nulla a che vedere con l’omicidio».
Per l’uccisione del piccolo Samuele, a Cogne (Aosta) il 30 gennaio 2002, è stata condannata la madre, Anna Maria Franzoni. Che idea ha di quel presunto stato amnesico-crepuscolare della donna?
«Anche in questo caso la Bpa è stata fondamentale, perché ci ha consentito di ricostruire una dinamica che escludeva, nelle diverse fasi di aggressione al bambino, l’intervento di un estraneo. Non è stata condannata per esclusione, ma la dinamica con cui è stato ucciso Samuele, le bugie e tutti gli aspetti emersi nel processo, hanno portato a riconoscere la sua colpevolezza. Poi, che la signora Franzoni avesse sue problematiche psicologiche, è stato riconosciuto da un pool di periti. Il mio parere è che quando è tornata dopo aver accompagnato il figlio più grande a scuola e l’omicidio era già avvenuto, la gestione della scena del crimine è stata molto lucida e proprio lì abbiamo trovato contraddizioni rispetto alla sua dichiarata innocenza».
La traccia di Dna sul battitacco dell’auto di Olindo Romano è stata decisiva nello stabilire la colpevolezza dei coniugi Romano nella strage di vicinato a Erba (Como) dell’11 dicembre 2006 - 3 uccisi, fra cui un bambino - con spranga e coltello. Le è rimasto qualche dubbio?
«Ci sono tornato ultimamente, perché è stata fatta una richiesta di revisione dal procuratore generale di Milano Tarfusser. Quell’analisi l’ha fatta il professor Previderè e, il repertamento della traccia, i carabinieri. Rivedendo gli atti del processo e le testimonianze che raccontavano le modalità di raccolta della traccia e della sua trasmissione al prof. Previderè, non ho trovato nulla che possa segnalare un errore e che negherebbe la responsabilità dei coniugi Romano».
Si parla ancora della strage di via Caravaggio, a Napoli, 30 ottobre 1975. Prima di cena, padre, madre, figlia sterminati con ferocia nel loro appartamento, cagnolino Dick compreso. Assassino mai catturato. Cicche senza filtro «Gitanes» repertate e ancora disponibili. All’epoca l’analisi del Dna non esisteva…
«Le probabilità che il Dna si conservi sono elevate. Quelle analisi sulle cicche sono state fatte, hanno dato esiti, ma non utilizzabili per l’individuazione di responsabilità precise. Non entro nel merito, essendo stato recentemente consulente di uno dei parenti. Se una traccia di Dna è ormai secca, si conserva per sempre, per quanto particolari condizioni ambientali possano favorirne la degradazione. Ma un indumento conservato da 30 anni in uno scatolone, in un ufficio corpi di reato, oggi potrebbe darci con alta probabilità risultati definitivi».
Se ne desume che i reperti andrebbero conservati dall’autorità giudiziaria. Talvolta non è così.
«I reperti possono essere eliminati solo con provvedimento dell’autorità giudiziaria. Ma la revisione di un processo bisogna sempre considerarla. Se non si è arrivati a una soluzione, i reperti vanno certamente conservati. Tanti casi, accaduti prima dell’avvento dell’analisi del Dna, potrebbero essere riaperti. La cultura dei cold case, che in alcuni Paesi è molto sviluppata, da noi non ha preso molto piede. Pensiamo al cold case per eccellenza, l’omicidio della contessa Alberica Filo della Torre (Roma, 10 luglio 1991, ndr). Si è risolto nel 2011 attraverso l’analisi del Dna. Ci sono tantissimi delitti precedenti al 1990 senza nessun presunto colpevole».
In un’intervista alla Verità dell’ottobre 2022, il criminologo Francesco Bruno, mancato l’11 gennaio 2023, disse che gli assassini a piede libero, mai condannati, sono molti. È d’accordo?
«Intanto a Francesco va il mio pensiero affettuoso. Credo ci sia stato un miglioramento generale in Italia. Nel 1991 si sono verificati quasi 2.000 omicidi, nel 2022 sono stati poco più di 300. Quindi, se gli omicidi diminuiscono, ci sono meno assassini in libertà. Credo che gli errori ci siano, qualche assassino in libertà e qualche innocente in galera».
Nella sua giovinezza pensava di fare l’investigatore scientifico?
«Volevo fare il ricercatore, mio padre era un ufficiale dei carabinieri. Mi sono laureato in scienze biologiche. Il servizio militare lo feci nell’Arma, ma non pensavo di rimanere. Poi, da allievo ufficiale, ci portarono a vedere i laboratori del Cis e fu amore a prima vista. Capii che amore per la scienza e amore per l’Arma si fondevano».