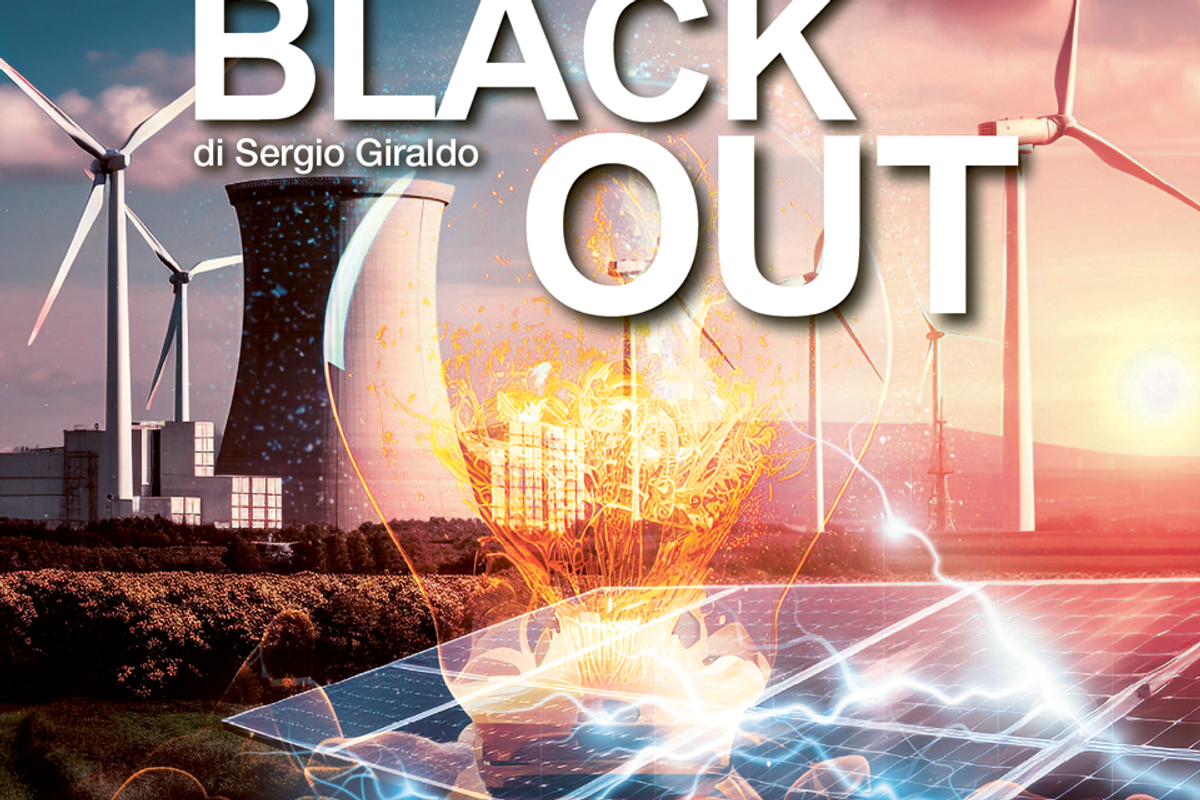True
2022-06-27
L'autonomia tradita
Arrivati al giro di boa, meglio affidarsi alla concretezza. L’autonomia non si può più rimandare. Le prime tre Regioni ad aver avviato il processo che porta al regionalismo differenziato - Veneto, Lombardia, Emilia Romagna - sanno di non poter perdere altro tempo. Dopo quasi cinque anni di attese (in mezzo un referendum, tre governi, una serie lunghissima di discussioni, tavoli e commissioni) tra i governatori del Nord si è fatta largo una convinzione: la legge quadro, cioè la cornice dentro cui inserire le intese tra lo Stato e le Regioni sulle materie da trasferire, deve arrivare in Consiglio dei ministri il prima possibile. O almeno non più tardi del prossimo autunno, quando tra i palazzi della politica si comincerà a discutere solo di legge di bilancio. E pazienza se qualche limatura al testo dovrà essere apportata, come pensa il presidente del Veneto Luca Zaia.
Da qualche parte si dovrà pur cominciare: «Facciamo il primo passo; se avesse seguito il criterio della perfezione, Cristoforo Colombo sarebbe ancora fermo a Palos», confida chi sta seguendo l’evoluzione del dossier per conto delle Regioni. «La fase decisiva non è quella delle pregiudiziali, ma la successiva», quando le intese dovranno essere esaminate, dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri e prima del definitivo passaggio in aula, dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il pieno coinvolgimento del Parlamento è una delle materie di scontro tra gli autonomisti e chi predica cautela sulla strada che porta al regionalismo: in risposta a un’interrogazione sull’Autonomia differenziata, il ministro per il Sud, Mara Carfagna, l’ha posta come una delle condizioni «imprescindibili» per l’approvazione del disegno di legge. «Nel processo di approvazione dell’intesa preliminare tra lo Stato e le Regioni, il Parlamento è già adeguatamente coinvolto», ribatte Andrea Giovanardi, professore di diritto tributario all’università di Trento. «La Commissione competente esprime il suo parere su un accordo che, in ultima battuta, verrà approvato dalle Camere a maggioranza assoluta dei suoi componenti. L’errore, semmai, è pensare di poter emendare un testo su cui Stato e Regioni hanno raggiunto un’intesa: è come se due parti stipulassero un contratto e un terzo modificasse l’accordo concluso, indipendentemente dalla loro volontà. Siamo di fronte a un problema logico, prima ancora che giuridico».
Tra i nodi più ingarbugliati della riforma, ci sono i Livelli essenziali delle prestazioni (Lep), cioè gli standard minimi per le prestazioni e i servizi che lo Stato deve garantire su tutto il territorio nazionale, che le Regioni aspettano di conoscere da più di dieci anni. La bozza di legge messa a punto dal ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, li considera «una condizione necessaria» per il trasferimento di alcune funzioni, come la sanità, l’istruzione, l’assistenza e il trasporto pubblico locale.
Peccato che i primi a mettere in dubbio il vincolo dei Lep siano stati proprio gli esperti scelti dal ministero per fornire un parere sull’autonomia: nella relazione conclusiva consegnata alla Gelmini, il gruppo di lavoro presieduto dal professor Beniamino Caravita (recentemente scomparso) esclude la possibilità di subordinare l’attuazione del regionalismo differenziato alla preventiva definizione dei Lep. Restando inerte, infatti, lo Stato potrebbe rinviare indefinitamente ogni possibilità di accordo con le Regioni su alcune delle materie più importanti. «Siamo in una situazione ridicola e paradossale: chi avrebbe dovuto provvedere fa ricadere sulle Regioni la mancata definizione dei Lep, rischiando di impantanare tutto il processo», spiega alla Verità il professor Mario Bertolissi, costituzionalista e membro della Commissione veneta per l’autonomia.
In attesa che lo Stato si decida a intervenire, nella bozza di legge quadro si è scelta la più classica delle mediazioni: Veneto e Lombardia avrebbero voluto inserire il criterio della spesa storica media pro capite italiana, una volta trascorsi tre anni dall’intesa senza un passo avanti sui Lep, ma si sono dovute accontentare della quota attuale di spesa storica a loro già oggi attribuita, che è inferiore, secondo i dati della Ragioneria generale dello Stato, alla media italiana. «Il criterio dei costi storici è perverso: lo Stato rimborsa la Regione senza una valutazione di merito, ma sulla base di quanto è stato speso l’anno precedente», ricorda chi ha partecipato alla trattativa per conto di Regione Lombardia. Di fatto, significa premiare chi spende di più e peggio. «Al ministero dell’Economia», prosegue Bertolissi, «hanno fatto i conti e si sono accorti che superare il criterio dei costi storici significherebbe rimetterci dei soldi. E di trasferire fondi alle Regioni, a Roma, non hanno alcun interesse: per questo, preferiscono lasciare tutto com’è».
Contro le «repubblichette» e la «secessione dei ricchi», sono tornati a farsi sentire giuristi, accademici e sindacati, preoccupati dalla possibile accelerazione del percorso verso l’autonomia, che metterebbe in discussione - a loro dire - l’unità nazionale. «Chi più ha, più ottiene; chi meno ha, si frega», ha scritto l’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Per impedire il regionalismo differenziato, circa 200 intellettuali hanno sottoscritto un disegno di legge costituzionale d’iniziativa popolare, con l’obiettivo di modificare la potestà legislativa delle Regioni e il rapporto tra periferia e Stato centrale. «Manutenzione straordinaria», la chiama il professor Massimo Villone, emerito di diritto costituzionale all’università Federico II di Napoli, tra i firmatari della proposta di legge. «Agli attacchi pieni di slogan e non argomentati siamo abituati», ragiona ancora il professor Giovanardi. «Eppure, al di là di quello che pensano Villone e gli altri, la formulazione dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione non lascia spazio a dubbi. Si può provare a cambiarlo, certamente, ma finché quell’articolo c’è deve essere attuato. Non si tratta di un atto eversivo, come ha ribadito il presidente Zaia: le iniziative regionali rispettano la nostra Costituzione, che non può essere utilizzata a sostegno di argomentazioni di parte solo quando fa comodo».
«Salvini doveva metterci la faccia. Ora siamo su un binario morto»
«Il terreno dell’autonomia differenziata è disseminato di trappole, c’è un’altissima probabilità che la questione settentrionale finisca su un binario morto». Nei Comitati per l’autonomia del Veneto c’è una certa delusione, l’incontro tra il ministro degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, e i governatori del Nord non è bastato a far cambiare idea ai venetisti, convinti che la bozza di legge quadro sia una «riforma annacquata».
Paolo Franco, ex senatore leghista e responsabile dei Comitati per l’autonomia del Veneto, lei parla senza mezzi termini di «autonomia tradita», perché?
«La legge quadro, così come è scritta, è incostituzionale. L’articolo 116 della Costituzione prevede due fasi: l’intesa tra lo Stato e le Regioni e poi l’approvazione dell’accordo da parte delle Camere, a maggioranza assoluta dei componenti. La legge quadro cambia completamente il procedimento legislativo, rendendolo contorto e contraddittorio».
In quali punti?
«I passaggi iniziali sono più che raddoppiati: c’è la richiesta della Regione, il negoziato che produce lo schema di intesa preliminare, la discussione del testo nelle commissioni parlamentari, la trasmissione della legge alle Camere da parte del governo e infine la deliberazione».
Cosa non va in tutto ciò?
«Il testo di intesa che il governo trasmette alle Camere può cambiare in base al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Di fatto, potremmo ritrovarci con due testi: il primo sottoscritto dalle Regioni che chiedono l’autonomia e un secondo sul quale le Regioni non possono intervenire, né tantomeno firmare, perché il testo Gelmini non lo prevede. Un presidente di Regione che approva l’intesa preliminare potrebbe ritrovarsi con una intesa definitiva modificata, sulla quale non avrà alcun potere: si porta a casa ciò che la commissione e il governo avranno deciso di cambiare, punto».
Sulle materie principali - sanità, assistenza, istruzione e trasporto pubblico - la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (i famosi Lep) è la condizione necessaria per il trasferimento delle funzioni. Porre tale vincolo significa non voler trasferire affatto queste materie?
«Tra il 2010 e il 2013, sono stato vicepresidente della Bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale e già allora si parlava dei Lep».
Perché non sono mai stati definiti?
«La definizione dei Lep metterebbe in difficoltà alcune Regioni, che per i settori più importanti preferiscono continuare a spendere in base al criterio delle spesa storica. Se per oltre 10 anni nessuno ha mai messo mano ai Lep, è perché non c’è la volontà politica di farlo. Non mi stupisce che abbiano voluto inserire questa trappola nella legge quadro, significa impedire la concessione delle materie».
«Le modalità di finanziamento delle funzioni conferite devono essere individuate anche tra i tributi propri della Regione», si legge nella bozza di legge quadro. La convince questa disposizione?
«La legge sul federalismo fiscale del 2009 dice che, nel momento in cui si attribuiscono maggiori competenze alle Regioni, viene lasciata una compartecipazione corrispondente al costo sostenuto a livello periferico. La legge quadro invece parla anche di riserva di imposta e tributi propri: ciò vuol dire che lo Stato non darà indietro 100, ma magari 80. Il resto sono tributi propri, ma ciò non è scritto nella legge sul federalismo fiscale».
Lei ha scritto che «la Lega, il partito alfiere del progetto, ha abdicato ai propri principi originari».
«Non è da ieri o dal mese scorso che Matteo Salvini ha abbandonato la questione settentrionale. Il progetto dell’autonomia è rimasto orfano almeno dall’inizio della legislatura. Non imponendo l’attuazione dell’autonomia differenziata, Salvini ha commesso un grave errore: per le sue mire personali, siamo finiti nella mani di chi spera che il regionalismo non abbia mai luogo».
Ritiene che le incertezze sul regionalismo abbiano influito sul voto delle amministrative?
«È evidente. E non perché la Lega di Salvini è diventata un partito nazionale, ma perché oggi è un partito centralista: ragionano solamente in base alle funzioni dello Stato centralista, per questo al nord sono stati puniti».
Come giudica il lavoro dei governatori?
«Mi infastidisce il gioco di rimessa che stanno portando avanti. C’è una specie di paura, di giustificazione nelle loro parole. Sembra che si vergognino di questa battaglia».
La legge quadro sarà anche imperfetta, ma tra i governatori si è fatta largo una convinzione: da qualche parte si dovrà pur partire.
«Noto un certo imbarazzo tra i governatori: sanno benissimo che la legge quadro è una tomba per l’autonomia differenziata. Sono consapevoli del fatto che se non portano a casa nulla faranno fatica a ripresentarsi agli elettori nella prossima legislatura. Quindi dicono “turiamoci il naso e portiamo a casa questa schifezza”, ma io questa schifezza non la accetto. Ci sono dei punti che devono essere modificati e resi aderenti a quanto previsto dalla Costituzione».
«La legge va approvata in fretta. Dopo non si può tornare indietro»
Nella trattativa politica sull’autonomia differenziata, tutte le mosse vanno pesate: ci sono posizioni da limare, compromessi da accettare. Ogni parola rischia di sollevare un polverone: «Molti aspetti di questa vicenda sono stati usati ad arte per buttare la palla in tribuna», racconta alla Verità Stefano Bruno Galli, Assessore all’Autonomia e alla Cultura di Regione Lombardia. Il percorso verso il regionalismo differenziato è ancora lungo, ma qualche punto fermo si comincia a intravedere: «Una volta approvata la legge quadro, non ci sono più alibi».
Assessore, il tema del contendere è proprio la legge quadro: i più intransigenti in Veneto non la vedono proprio di buon occhio.
«Quella messa a punto dal ministro Gelmini è sostanzialmente una legge procedurale, che colma una lacuna emersa nelle trattative del 2018, primo governo Conte. Dalla riforma del Titolo V della Costituzione (2001) a oggi, l’articolo 116 è rimasto di fatto inattuato: le Regioni possono chiedere al governo di iniziare un percorso per ottenere maggiore autonomia politica e amministrativa, ma nessuno ha mai spiegato come fare. Per 20 anni si è brancolato nel buio».
Insomma, meglio una legge imperfetta che nessuna legge?
«Si poteva anche fare a meno di questa legge quadro. Però, se è volontà esplicita del ministro procedere in questa direzione, si faccia presto e con minori danni possibili per le Regioni sedute al tavolo della trattativa».
Che tipo di danni intravede?
«Temo che al governo possano sorgere delle frizioni, che potrebbero riversarsi nel passaggio parlamentare».
Il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, la forzista Mara Carfagna, pone alcune questioni imprescindibili per l’approvazione del Disegno di legge: fondo perequativo, l’abbandono della spesa storica e, soprattutto, la definizione dei LEP, che per i venetisti renderebbe impossibile l’autonomia nelle materie fondamentali.
«Più rapidamente si approva questa legge, meglio è. È chiaro che devono esserci dei compromessi».
Altrimenti non verrebbe neanche approvata.
«Esatto. Una volta che viene approvata la legge quadro, non si torna più indietro. Ciò vale per il governo e per il Parlamento. Come Regione Lombardia, i nostri compiti li abbiamo fatti e siamo pronti a mettere le carte sul tavolo. Si proceda alla svelta, perché ogni volta che si fanno dei passi in avanti si alza la crociata, per lo più una battaglia di retroguardia, dei vari intellettuali, pronti a strumentalizzare i dati e i concetti per buttare fango sull’autonomia».
La chiamano «secessione dei ricchi», è così?
«Niente affatto. Questa è una riforma che non crea danni. Semmai, consentirà alle Regioni con un sistema produttivo avanzato e una capacità fiscale forte di sviluppare ulteriormente queste attitudini e aumentare le risorse da redistribuire con il resto del Paese. La partita dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione si spiega con due parole».
Quali?
«Efficienza e responsabilità. Se una Regione chiede di avere maggiori margini di autonomia, deve dimostrare la propria efficienza. Qualsiasi forma di servizio, erogato dalla Lombardia, dal Veneto, dall’Emilia Romagna o dal Piemonte, deve costare meno e garantire una maggiore qualità, nell’interesse di tutti i cittadini. Stiamo parlando di un elemento di innovazione per il sistema istituzionale di questo Paese, per dimostrare finalmente di essere più moderni, agili e meno incancreniti. Dobbiamo renderci conto che questo Paese, dal 1970 a oggi, ha perseguito quello che tecnicamente si chiama regionalismo ordinario dell’uniformità, che ha come obiettivo la garanzia di uguali diritti e tutele per tutti i cittadini della Repubblica».
Cosa c’è di male in questo?
«Assolutamente nulla, si stratta di uno scopo nobilissimo e fondamentale. Tuttavia, è stato proprio il regionalismo ordinario dell’uniformità a rivelare le differenze di rendimento istituzionale. Se in Lombardia esiste il turismo sanitario, significa che i diritti di welfare che può garantire la nostra Regione sono nettamente superiori rispetto a quelli di altre Regioni, dalle quali proviene chi si fa curare. Se i sistemi di welfare di quelle Regioni non migliorano in termini di qualità, efficienza e riduzione degli sprechi, il Paese andrà sempre peggio».
Secondo l’ex presidente dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio, l’economista Giuseppe Pisauro, rischiamo di ritrovarci con «20 Regioni a statuto speciale».
«Non è così. Il regionalismo differenziato esiste già nelle Regioni a Statuto speciale. I margini di autonomia del Friuli Venezia Giulia, l’ultima Regione tra quelle a Statuto speciale, sono nettamente inferiori rispetto a quelle della Sicilia. La specialità si differenzia in base agli aspetti fiscali, alle competenze legislative e amministrative riconosciute e risiede negli Statuti di autonomia delle cinque Regioni. Il 116 comma 3, invece, ha l’obiettivo di applicare il principio dei differenti margini di autonomia anche alle altre Regioni. Le 15 Regioni ordinarie non diventeranno mai a Statuto speciale, dal punto di vista teorico è una stupidaggine».
Continua a leggereRiduci
Cinque anni fa in Lombardia e Veneto un plebiscito approvò i referendum. Si unì anche l’Emilia Romagna. Ora la legislatura è agli sgoccioli. E i ministri di centrodestra non riescono a dare una risposta seria alle richieste dei cittadini.«Salvini doveva metterci la faccia. Ora siamo su un binario morto». Paolo Franco, l'ex senatore leghista responsabile dei Comitati veneti: «Il progetto è rimasto lettera morta già dal governo Conte 1. Il testo presentato dalla Gelmini è annacquato e incostituzionale. C’è imbarazzo tra i governatori».«La legge va approvata in fretta. Dopo non si può tornare indietro». L’assessore lombardo Stefano Bruno Galli: «Chiediamo poteri simili agli enti locali con Statuto speciale».Lo speciale comprende tre articoli. Arrivati al giro di boa, meglio affidarsi alla concretezza. L’autonomia non si può più rimandare. Le prime tre Regioni ad aver avviato il processo che porta al regionalismo differenziato - Veneto, Lombardia, Emilia Romagna - sanno di non poter perdere altro tempo. Dopo quasi cinque anni di attese (in mezzo un referendum, tre governi, una serie lunghissima di discussioni, tavoli e commissioni) tra i governatori del Nord si è fatta largo una convinzione: la legge quadro, cioè la cornice dentro cui inserire le intese tra lo Stato e le Regioni sulle materie da trasferire, deve arrivare in Consiglio dei ministri il prima possibile. O almeno non più tardi del prossimo autunno, quando tra i palazzi della politica si comincerà a discutere solo di legge di bilancio. E pazienza se qualche limatura al testo dovrà essere apportata, come pensa il presidente del Veneto Luca Zaia.Da qualche parte si dovrà pur cominciare: «Facciamo il primo passo; se avesse seguito il criterio della perfezione, Cristoforo Colombo sarebbe ancora fermo a Palos», confida chi sta seguendo l’evoluzione del dossier per conto delle Regioni. «La fase decisiva non è quella delle pregiudiziali, ma la successiva», quando le intese dovranno essere esaminate, dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri e prima del definitivo passaggio in aula, dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il pieno coinvolgimento del Parlamento è una delle materie di scontro tra gli autonomisti e chi predica cautela sulla strada che porta al regionalismo: in risposta a un’interrogazione sull’Autonomia differenziata, il ministro per il Sud, Mara Carfagna, l’ha posta come una delle condizioni «imprescindibili» per l’approvazione del disegno di legge. «Nel processo di approvazione dell’intesa preliminare tra lo Stato e le Regioni, il Parlamento è già adeguatamente coinvolto», ribatte Andrea Giovanardi, professore di diritto tributario all’università di Trento. «La Commissione competente esprime il suo parere su un accordo che, in ultima battuta, verrà approvato dalle Camere a maggioranza assoluta dei suoi componenti. L’errore, semmai, è pensare di poter emendare un testo su cui Stato e Regioni hanno raggiunto un’intesa: è come se due parti stipulassero un contratto e un terzo modificasse l’accordo concluso, indipendentemente dalla loro volontà. Siamo di fronte a un problema logico, prima ancora che giuridico». Tra i nodi più ingarbugliati della riforma, ci sono i Livelli essenziali delle prestazioni (Lep), cioè gli standard minimi per le prestazioni e i servizi che lo Stato deve garantire su tutto il territorio nazionale, che le Regioni aspettano di conoscere da più di dieci anni. La bozza di legge messa a punto dal ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, li considera «una condizione necessaria» per il trasferimento di alcune funzioni, come la sanità, l’istruzione, l’assistenza e il trasporto pubblico locale. Peccato che i primi a mettere in dubbio il vincolo dei Lep siano stati proprio gli esperti scelti dal ministero per fornire un parere sull’autonomia: nella relazione conclusiva consegnata alla Gelmini, il gruppo di lavoro presieduto dal professor Beniamino Caravita (recentemente scomparso) esclude la possibilità di subordinare l’attuazione del regionalismo differenziato alla preventiva definizione dei Lep. Restando inerte, infatti, lo Stato potrebbe rinviare indefinitamente ogni possibilità di accordo con le Regioni su alcune delle materie più importanti. «Siamo in una situazione ridicola e paradossale: chi avrebbe dovuto provvedere fa ricadere sulle Regioni la mancata definizione dei Lep, rischiando di impantanare tutto il processo», spiega alla Verità il professor Mario Bertolissi, costituzionalista e membro della Commissione veneta per l’autonomia. In attesa che lo Stato si decida a intervenire, nella bozza di legge quadro si è scelta la più classica delle mediazioni: Veneto e Lombardia avrebbero voluto inserire il criterio della spesa storica media pro capite italiana, una volta trascorsi tre anni dall’intesa senza un passo avanti sui Lep, ma si sono dovute accontentare della quota attuale di spesa storica a loro già oggi attribuita, che è inferiore, secondo i dati della Ragioneria generale dello Stato, alla media italiana. «Il criterio dei costi storici è perverso: lo Stato rimborsa la Regione senza una valutazione di merito, ma sulla base di quanto è stato speso l’anno precedente», ricorda chi ha partecipato alla trattativa per conto di Regione Lombardia. Di fatto, significa premiare chi spende di più e peggio. «Al ministero dell’Economia», prosegue Bertolissi, «hanno fatto i conti e si sono accorti che superare il criterio dei costi storici significherebbe rimetterci dei soldi. E di trasferire fondi alle Regioni, a Roma, non hanno alcun interesse: per questo, preferiscono lasciare tutto com’è». Contro le «repubblichette» e la «secessione dei ricchi», sono tornati a farsi sentire giuristi, accademici e sindacati, preoccupati dalla possibile accelerazione del percorso verso l’autonomia, che metterebbe in discussione - a loro dire - l’unità nazionale. «Chi più ha, più ottiene; chi meno ha, si frega», ha scritto l’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Per impedire il regionalismo differenziato, circa 200 intellettuali hanno sottoscritto un disegno di legge costituzionale d’iniziativa popolare, con l’obiettivo di modificare la potestà legislativa delle Regioni e il rapporto tra periferia e Stato centrale. «Manutenzione straordinaria», la chiama il professor Massimo Villone, emerito di diritto costituzionale all’università Federico II di Napoli, tra i firmatari della proposta di legge. «Agli attacchi pieni di slogan e non argomentati siamo abituati», ragiona ancora il professor Giovanardi. «Eppure, al di là di quello che pensano Villone e gli altri, la formulazione dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione non lascia spazio a dubbi. Si può provare a cambiarlo, certamente, ma finché quell’articolo c’è deve essere attuato. Non si tratta di un atto eversivo, come ha ribadito il presidente Zaia: le iniziative regionali rispettano la nostra Costituzione, che non può essere utilizzata a sostegno di argomentazioni di parte solo quando fa comodo».<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/lautonomia-tradita-2657565586.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="salvini-doveva-metterci-la-faccia-ora-siamo-su-un-binario-morto" data-post-id="2657565586" data-published-at="1656283949" data-use-pagination="False"> «Salvini doveva metterci la faccia. Ora siamo su un binario morto» «Il terreno dell’autonomia differenziata è disseminato di trappole, c’è un’altissima probabilità che la questione settentrionale finisca su un binario morto». Nei Comitati per l’autonomia del Veneto c’è una certa delusione, l’incontro tra il ministro degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, e i governatori del Nord non è bastato a far cambiare idea ai venetisti, convinti che la bozza di legge quadro sia una «riforma annacquata». Paolo Franco, ex senatore leghista e responsabile dei Comitati per l’autonomia del Veneto, lei parla senza mezzi termini di «autonomia tradita», perché? «La legge quadro, così come è scritta, è incostituzionale. L’articolo 116 della Costituzione prevede due fasi: l’intesa tra lo Stato e le Regioni e poi l’approvazione dell’accordo da parte delle Camere, a maggioranza assoluta dei componenti. La legge quadro cambia completamente il procedimento legislativo, rendendolo contorto e contraddittorio». In quali punti? «I passaggi iniziali sono più che raddoppiati: c’è la richiesta della Regione, il negoziato che produce lo schema di intesa preliminare, la discussione del testo nelle commissioni parlamentari, la trasmissione della legge alle Camere da parte del governo e infine la deliberazione». Cosa non va in tutto ciò? «Il testo di intesa che il governo trasmette alle Camere può cambiare in base al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Di fatto, potremmo ritrovarci con due testi: il primo sottoscritto dalle Regioni che chiedono l’autonomia e un secondo sul quale le Regioni non possono intervenire, né tantomeno firmare, perché il testo Gelmini non lo prevede. Un presidente di Regione che approva l’intesa preliminare potrebbe ritrovarsi con una intesa definitiva modificata, sulla quale non avrà alcun potere: si porta a casa ciò che la commissione e il governo avranno deciso di cambiare, punto». Sulle materie principali - sanità, assistenza, istruzione e trasporto pubblico - la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (i famosi Lep) è la condizione necessaria per il trasferimento delle funzioni. Porre tale vincolo significa non voler trasferire affatto queste materie? «Tra il 2010 e il 2013, sono stato vicepresidente della Bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale e già allora si parlava dei Lep». Perché non sono mai stati definiti? «La definizione dei Lep metterebbe in difficoltà alcune Regioni, che per i settori più importanti preferiscono continuare a spendere in base al criterio delle spesa storica. Se per oltre 10 anni nessuno ha mai messo mano ai Lep, è perché non c’è la volontà politica di farlo. Non mi stupisce che abbiano voluto inserire questa trappola nella legge quadro, significa impedire la concessione delle materie». «Le modalità di finanziamento delle funzioni conferite devono essere individuate anche tra i tributi propri della Regione», si legge nella bozza di legge quadro. La convince questa disposizione? «La legge sul federalismo fiscale del 2009 dice che, nel momento in cui si attribuiscono maggiori competenze alle Regioni, viene lasciata una compartecipazione corrispondente al costo sostenuto a livello periferico. La legge quadro invece parla anche di riserva di imposta e tributi propri: ciò vuol dire che lo Stato non darà indietro 100, ma magari 80. Il resto sono tributi propri, ma ciò non è scritto nella legge sul federalismo fiscale». Lei ha scritto che «la Lega, il partito alfiere del progetto, ha abdicato ai propri principi originari». «Non è da ieri o dal mese scorso che Matteo Salvini ha abbandonato la questione settentrionale. Il progetto dell’autonomia è rimasto orfano almeno dall’inizio della legislatura. Non imponendo l’attuazione dell’autonomia differenziata, Salvini ha commesso un grave errore: per le sue mire personali, siamo finiti nella mani di chi spera che il regionalismo non abbia mai luogo». Ritiene che le incertezze sul regionalismo abbiano influito sul voto delle amministrative? «È evidente. E non perché la Lega di Salvini è diventata un partito nazionale, ma perché oggi è un partito centralista: ragionano solamente in base alle funzioni dello Stato centralista, per questo al nord sono stati puniti». Come giudica il lavoro dei governatori? «Mi infastidisce il gioco di rimessa che stanno portando avanti. C’è una specie di paura, di giustificazione nelle loro parole. Sembra che si vergognino di questa battaglia». La legge quadro sarà anche imperfetta, ma tra i governatori si è fatta largo una convinzione: da qualche parte si dovrà pur partire. «Noto un certo imbarazzo tra i governatori: sanno benissimo che la legge quadro è una tomba per l’autonomia differenziata. Sono consapevoli del fatto che se non portano a casa nulla faranno fatica a ripresentarsi agli elettori nella prossima legislatura. Quindi dicono “turiamoci il naso e portiamo a casa questa schifezza”, ma io questa schifezza non la accetto. Ci sono dei punti che devono essere modificati e resi aderenti a quanto previsto dalla Costituzione». <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/lautonomia-tradita-2657565586.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="la-legge-va-approvata-in-fretta-dopo-non-si-puo-tornare-indietro" data-post-id="2657565586" data-published-at="1656283949" data-use-pagination="False"> «La legge va approvata in fretta. Dopo non si può tornare indietro» Nella trattativa politica sull’autonomia differenziata, tutte le mosse vanno pesate: ci sono posizioni da limare, compromessi da accettare. Ogni parola rischia di sollevare un polverone: «Molti aspetti di questa vicenda sono stati usati ad arte per buttare la palla in tribuna», racconta alla Verità Stefano Bruno Galli, Assessore all’Autonomia e alla Cultura di Regione Lombardia. Il percorso verso il regionalismo differenziato è ancora lungo, ma qualche punto fermo si comincia a intravedere: «Una volta approvata la legge quadro, non ci sono più alibi». Assessore, il tema del contendere è proprio la legge quadro: i più intransigenti in Veneto non la vedono proprio di buon occhio. «Quella messa a punto dal ministro Gelmini è sostanzialmente una legge procedurale, che colma una lacuna emersa nelle trattative del 2018, primo governo Conte. Dalla riforma del Titolo V della Costituzione (2001) a oggi, l’articolo 116 è rimasto di fatto inattuato: le Regioni possono chiedere al governo di iniziare un percorso per ottenere maggiore autonomia politica e amministrativa, ma nessuno ha mai spiegato come fare. Per 20 anni si è brancolato nel buio». Insomma, meglio una legge imperfetta che nessuna legge? «Si poteva anche fare a meno di questa legge quadro. Però, se è volontà esplicita del ministro procedere in questa direzione, si faccia presto e con minori danni possibili per le Regioni sedute al tavolo della trattativa». Che tipo di danni intravede? «Temo che al governo possano sorgere delle frizioni, che potrebbero riversarsi nel passaggio parlamentare». Il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, la forzista Mara Carfagna, pone alcune questioni imprescindibili per l’approvazione del Disegno di legge: fondo perequativo, l’abbandono della spesa storica e, soprattutto, la definizione dei LEP, che per i venetisti renderebbe impossibile l’autonomia nelle materie fondamentali. «Più rapidamente si approva questa legge, meglio è. È chiaro che devono esserci dei compromessi». Altrimenti non verrebbe neanche approvata. «Esatto. Una volta che viene approvata la legge quadro, non si torna più indietro. Ciò vale per il governo e per il Parlamento. Come Regione Lombardia, i nostri compiti li abbiamo fatti e siamo pronti a mettere le carte sul tavolo. Si proceda alla svelta, perché ogni volta che si fanno dei passi in avanti si alza la crociata, per lo più una battaglia di retroguardia, dei vari intellettuali, pronti a strumentalizzare i dati e i concetti per buttare fango sull’autonomia». La chiamano «secessione dei ricchi», è così? «Niente affatto. Questa è una riforma che non crea danni. Semmai, consentirà alle Regioni con un sistema produttivo avanzato e una capacità fiscale forte di sviluppare ulteriormente queste attitudini e aumentare le risorse da redistribuire con il resto del Paese. La partita dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione si spiega con due parole». Quali? «Efficienza e responsabilità. Se una Regione chiede di avere maggiori margini di autonomia, deve dimostrare la propria efficienza. Qualsiasi forma di servizio, erogato dalla Lombardia, dal Veneto, dall’Emilia Romagna o dal Piemonte, deve costare meno e garantire una maggiore qualità, nell’interesse di tutti i cittadini. Stiamo parlando di un elemento di innovazione per il sistema istituzionale di questo Paese, per dimostrare finalmente di essere più moderni, agili e meno incancreniti. Dobbiamo renderci conto che questo Paese, dal 1970 a oggi, ha perseguito quello che tecnicamente si chiama regionalismo ordinario dell’uniformità, che ha come obiettivo la garanzia di uguali diritti e tutele per tutti i cittadini della Repubblica». Cosa c’è di male in questo? «Assolutamente nulla, si stratta di uno scopo nobilissimo e fondamentale. Tuttavia, è stato proprio il regionalismo ordinario dell’uniformità a rivelare le differenze di rendimento istituzionale. Se in Lombardia esiste il turismo sanitario, significa che i diritti di welfare che può garantire la nostra Regione sono nettamente superiori rispetto a quelli di altre Regioni, dalle quali proviene chi si fa curare. Se i sistemi di welfare di quelle Regioni non migliorano in termini di qualità, efficienza e riduzione degli sprechi, il Paese andrà sempre peggio». Secondo l’ex presidente dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio, l’economista Giuseppe Pisauro, rischiamo di ritrovarci con «20 Regioni a statuto speciale». «Non è così. Il regionalismo differenziato esiste già nelle Regioni a Statuto speciale. I margini di autonomia del Friuli Venezia Giulia, l’ultima Regione tra quelle a Statuto speciale, sono nettamente inferiori rispetto a quelle della Sicilia. La specialità si differenzia in base agli aspetti fiscali, alle competenze legislative e amministrative riconosciute e risiede negli Statuti di autonomia delle cinque Regioni. Il 116 comma 3, invece, ha l’obiettivo di applicare il principio dei differenti margini di autonomia anche alle altre Regioni. Le 15 Regioni ordinarie non diventeranno mai a Statuto speciale, dal punto di vista teorico è una stupidaggine».
Maurizio Gasparri, Galeazzo Bignami e Clotilde Minasi (Imagoeconomica)
Il centrodestra si schiera compatto al fianco della Verità, sostenendo la sottoscrizione lanciata dal nostro giornale per dare una mano al vicebrigadiere Emanuele Marroccella, che deve pagare nel giro di pochi giorni una provvisionale di 125.000 euro ai parenti del pregiudicato siriano Jamal Badawi, ucciso dallo stesso Marroccella dopo che aveva aggredito un collega il 20 settembre 2020 durante il tentativo di sventare un furto in uno stabile di Roma. Oltre a una condanna penale a tre anni per «eccesso colposo nell’uso legittimo di armi», a fronte tra l’altro di una richiesta più tenue del pm che aveva chiesto due anni e sei mesi, il quarantaquattrenne carabiniere originario di Napoli deve versare alle parti civili una somma ingente, 125.000 euro, pari a sei anni di lavoro nell’Arma. Se è vero che le spese legali sono coperte da un apposito fondo, è infatti altrettanto vero che la somma da versare ricade sulle spalle del carabiniere. «È una decisione surreale», dice alla Verità il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, «dei soliti giudici ideologizzati che puniscono chi ci difende. Va sostenuta qualsiasi iniziativa per il vicebrigadiere, aspettando che i prossimi giudici ristabiliscano il buon senso». Sulla stessa lunghezza d’onda il vicecapogruppo di Fdi a Montecitorio, Augusta Montaruli: «Si dovrebbe escludere», ci dice la Montaruli, «qualunque tipo di risarcimento a favore della cosiddetta persona offesa che ha determinato la reazione dell’agente per difendere sé e gli altri. Quello che ancora non prevede la legislazione è compensato negli effetti dall’iniziativa del vostro quotidiano che è meritoria perché solleva un dibattito sul risarcimento del danno in casi come questo». Da Fratelli d’Italia a Forza Italia, non fa mancare il suo appoggio alla nostra iniziativa il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri, che parteciperà anche alla sottoscrizione: «Sacrosanta iniziativa della Verità», commenta Gasparri, «a sostegno del carabiniere che ha subito una incredibile condanna con addirittura il supplizio di un oneroso risarcimento da erogare. Sono da sempre dalla parte del popolo in divisa, accetto ogni accertamento ma non le vessazioni. Pertanto elogio e apprezzo l’iniziativa della Verità e annuncio anche che parteciperò alla sottoscrizione in corso a sostegno di questo carabiniere. Siamo dalla parte della legge e dell’ordine contro tanti criminali impuniti che circolano nelle nostre città e che seminano violenza per colpa della magistratura inerte che vanifica il sacrificio delle forze di polizia o addirittura le perseguita. Questa vicenda è una ulteriore vergogna per il popolo togato». Non manca nel sostegno alla nostra sottoscrizione la Lega: di lodevole iniziativa della Verità» parla la senatrice del Carroccio Clotilde Minasi, che annuncia la sua partecipazione e sottolinea: «Di fronte a vicende come questa sembra di vivere in un mondo al contrario, in cui anche la giustizia è capovolta. Vengono tutelati i criminali e vengono invece puniti i tutori della legge. Chi protegge la nostra incolumità a costo di sacrifici personali altissimi viene condannato, recluso, sanzionato, mentre la nostra quotidianità è continuamente sotto attacco di malviventi senza scrupoli, che agiscono sapendo che rimarranno il più delle volte impuniti. È certamente terribile», aggiunge la Minasi, «che un uomo abbia perso la vita, ma non bisogna in questo caso dimenticare che questa tragedia nasce da un’azione di difesa della sicurezza da parte dei carabinieri, uno dei quali era stato aggredito dal malvivente. Solidarizzo dunque con il militare che si trova oggi sotto accusa. Il sistema va cambiato, chi viene in Italia non può pensare di poter vivere rubando, aggredendo, violentando. Queste sono le conseguenze di anni di immobilismo , ma stiamo lavorando e lavoreremo ancora perché i tutori della legge non debbano mai più trovarsi sotto processo per aver protetto i cittadini». Sempre dalla Lega ci arriva il commento della eurodeputata Silvia Sardone, vicesegretario nazionale del Carroccio: «Complimenti alla Verità per questa importante iniziativa», argomenta la Sardone, «a favore del carabiniere condannato. Purtroppo questa condanna rappresenta una scelta che lascia davvero senza parole, che allontana dal principio di equità e dal comune buon senso condiviso dai cittadini. Chi ogni giorno indossa una divisa, mette a rischio la propria incolumità e interviene in situazioni difficili per difendere la sicurezza della comunità non può essere trattato come se fosse lui il criminale. La posizione della Lega è chiara: saremo sempre schierati al fianco delle forze dell’ordine», aggiunge la Sardone, «difendendo il loro ruolo, la loro dignità professionale e il loro operato, e continueremo a dire basta a pregiudizi ideologici che sembrano colpire chi tutela la legalità invece di chi la viola».
Continua a leggereRiduci
Nel riquadro: Ivana, moglie di Emanuele Marroccella (Imagoeconomica)
Il carabiniere, nato 44 anni fa a Napoli, durante un intervento della radiomobile di Roma per sventare un presunto furto in uno stabile dell’Eur, la notte del 20 settembre 2020 aveva sparato per difendere il collega Lorenzo Grasso, ferito dal pregiudicato siriano Jamal Badawi, 56 anni, quattro fogli di espulsione mai eseguiti, che stava scappando.
Voleva anche proteggere la pattuglia all’esterno dell’immobile, vista la pericolosità del soggetto in fuga e aveva cercato di colpirlo alle gambe ma nello scatto per saltare il cancello il siriano era stato raggiunto al torace. Oltre alla pena, inasprita rispetto alla richiesta del pm che aveva indicato due anni e sei mesi, Marroccella deve versare subito alle parti civili una provvisionale ingente, 125.000 euro pari a sei anni di lavoro nell’Arma. E la richiesta di risarcimento dei numerosi familiari del siriano è di 800.000 euro. La signora, da più di vent’anni accanto al vice brigadiere, racconta alla Verità il dramma che è esploso nella loro casa.
Come riesce ad affrontare la valanga che vi ha travolti?
«È molto dura ma non posso permettermi di crollare. Cerco di mostrarmi serena per contenere la disperazione di Emanuele e per il bene dei nostri figli, di 14 e 12 anni».
Non sarà stato facile spiegare loro quello che è successo.
«L’abbiamo detto solo tre giorni fa, perché dopo la sentenza il nome Marroccella e di Ardea, il centro urbano laziale dove viviamo da 14 anni, è finito su tutti i giornali e temevamo che potessero apprendere la notizia da altri. Nel 2020 erano troppo piccoli e per fortuna se ne parlava poco».
Quali parole avete usato?
«Emanuele, che è il loro babbo eroe, ha raccontato che durante un’operazione avevano aggredito Lorenzo (il vice brigadiere ferito dal siriano, ndr) e che per difenderlo papà non voleva ma purtroppo ha dovuto sparare al ladro. E quella persona era morta».
La reazione?
«Il più piccolo è scoppiato a piangere, ha chiesto se il papa finiva in carcere, l’altro si è chiuso nel silenzio. Il giorno dopo, piangendo pure lui mi ha chiesto: “Se Lorenzo fosse morto che cosa sarebbe successo?”. Lo dico a lei, che cosa sarebbe accaduto».
La ascolto.
«Saremmo qui a piangere l’ennesimo carabiniere caduto in servizio, la bimba di Grasso che il giorno dopo l’aggressione compiva un anno sarebbe rimasta senza padre e senza risarcimento. La moglie avrebbe ricevuto l’ennesima medaglia al valore. Dietro l’uniforme non c’è un robot ma un uomo, una famiglia».
Come è la quotidianità accanto a chi rischia la vita tutti i giorni?
«Ho sempre saputo che poteva capitare qualsiasi cosa, comunque cerchi di condurre una vita normale. La casa, la scuola, lo sport dei ragazzi. Certo, hai un marito che può essere impegnato in turni di 24 ore se ci sono degli arresti e l’apprensione è una costante, ma è un po’ come se mi fossi arruolata pure io. Quello che successe, il 20 settembre, ci ha sconvolto anche perché una persona è morta».
Quale è stata la reazione attorno a voi?
«Una grandissima solidarietà. Di colleghi di Emanuele, di amici. Adesso, la straordinaria sottoscrizione lanciata dalla Verità. Fa bene al cuore, a volte le forze dell’ordine vengono fatte passare per un nemico d’abbattere. Mi hanno ferito due commenti letti sui social, dove mio marito veniva definito “esaltato” e “scellerato”. Non è affatto così».
Ce lo dica lei, chi è il vice brigadiere Marroccella?
«Un operatore di pubblica sicurezza leale, corretto, benvoluto dai suoi colleghi. Nessuno che abbia mormorato “te la sei voluta”. Si considera al servizio dei cittadini e non sono solo belle parole. Le racconto un episodio. Un paio d’anni prima di quel tragico evento, avevo letto su un social dei carabinieri la lettera di ringraziamento di una coppia che, bloccata dal traffico alla Magliana, rischiava di veder nascere la bimba in auto. Una pattuglia era intervenuta e li avevano scortati in 5 minuti al San Camillo dove la piccola era nata. Racconto l’episodio la sera a tavola e mio marito commenta che era stato lui, a far largo nel traffico. Perché non me lo hai detto, gli ho chiesto. Questo è il mio lavoro, ha risposto semplicemente».
Poi una mattina torna a casa e le dice che ha dovuto sparare e che un uomo è morto.
«È stato terribile. Non riusciva più a dormire, per mesi ha avuto bisogno del sostegno dello psicologo. Pensiamo di dare un aiuto anche ai nostri ragazzi. Ci vorrebbe pure per me, però intanto stringo i denti e penso a loro. Trovo conforto nella preghiera e nell’affetto che tanti ci dimostrano».
Adesso la sentenza di condanna, suo marito colpevole «oltre ogni ragionevole dubbio».
«Mi ha fatto male l’inasprimento della pena. Sono delusa. Quando l’ho detto a mia suocera ha avuto un malore, mia madre non riesce a riprendersi. Emanuele era uscito di casa per andare al lavoro, come ogni giorno e ogni notte in cui è di turno, non per andare a rubare. Se scegli di fare del male, sai che cosa ti può capitare. Chi ci restituirà questi anni, annientati da tanta sofferenza?».
Avete anche una grossa preoccupazione economica.
«Come facciamo a pagare una somma così alta oltre a tutte le spese legali? Emanuele prende 1.500 euro al mese, 1.800 se fa le domeniche, le notti, gli straordinari e c’è solo il suo stipendio che entra. Trovo assurdo dover chiedere aiuto, indebitarci per poter far fronte all’obbligo imposto dal tribunale. Ma se a morire fosse stato un carabiniere, chi avrebbe pagato? Quanto vale la vita di chi si occupa della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica?».
Continua a leggereRiduci
Le major americane già in pista a Caracas. Rio Tinto-Glencore, fusione miliardaria? Gli USA escono da 65 organizzazioni internazionali. Blackout a Berlino nel gelo.
Donald Trump (Ansa)
Eppure, nonostante il significativo aumento della pressione statunitense sulla Repubblica islamica, Trump non ha per ora abbandonato una certa cautela. Giovedì, il presidente americano ha infatti reso noto di non essere ancora pronto a ricevere il principe ereditario iraniano, Reza Pahlavi, che si era offerto di guidare un’eventuale transizione di potere a Teheran. «Penso che dovremmo lasciare che tutti escano e vedere chi emerge», ha affermato Trump. È quindi possibile ipotizzare che l’inquilino della Casa Bianca punti, almeno nel breve termine, a una «soluzione venezuelana» per l’Iran. Qualora Khamenei dovesse cadere, il presidente americano potrebbe, cioè, cercare di «addomesticare» un pezzo del vecchio regime, guardando probabilmente al settore delle forze armate. Questo non significa che Trump escluda del tutto un futuro sostegno a Reza Pahlavi. Significa semmai che, nel breve termine, potrebbe far leva su uno scenario intermedio: come fatto in Venezuela, dove, anziché appoggiare María Corina Machado, ha scelto come interlocutrice, almeno per ora, la vice di Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.
Al di là del suo storico scetticismo nei confronti delle operazioni di nation building, Trump vuole ridurre al minimo il rischio di instabilità tanto a Caracas quanto a Teheran. E, venendo specificamente all’Iran, guarda con interesse a due dossier principali: quello nucleare e quello petrolifero. Per quanto riguarda il primo, non è un mistero che il presidente americano punti a firmare con Teheran un nuovo accordo che impedisca all’Iran di conseguire l’arma atomica. Un obiettivo, questo, a cui tendono anche gli israeliani e i sauditi. La risoluzione della questione nucleare iraniana è quindi, agli occhi di Trump, una delle precondizioni essenziali per rilanciare ed espandere gli Accordi di Abramo: quegli accordi il cui futuro appare oggi a rischio per almeno tre ragioni. Le tensioni tra Riad e Gerusalemme sullo Stato palestinese, le fibrillazioni tra sauditi ed emiratini sullo Yemen e sul Sudan, senza infine trascurare la crescente instabilità che si registra in seno alla Siria. In tal senso, in caso di (probabile) caduta di Khamenei, il presidente americano spera in un governo stabile, che, messo adeguatamente sotto pressione, gli consenta di arrivare il prima possibile a un accordo sul nucleare.
Ma anche il secondo dossier, quello petrolifero, è particolarmente attenzionato da Trump. Il che lega, in qualche modo, la questione iraniana a quella venezuelana. L’altro ieri, il presidente americano ha affermato che gli Usa sono pronti a vendere a Cina e Russia il greggio di Caracas, finito sotto il controllo statunitense a seguito della cattura di Maduro. Segno, questo, del fatto che, oltre alla lotta al narcotraffico e alle esigenze di approvvigionamento energetico, l’operazione Absolute Resolve è stata condotta anche per riaffermare il predominio del dollaro nelle transazioni petrolifere e per disarticolare i Brics sul fronte energetico e finanziario. È vero che il Venezuela non fa formalmente parte di questo blocco, ma è altrettanto vero che Maduro intratteneva solide relazioni con tre membri dei Brics, come Pechino, Mosca e la stessa Teheran. Ricordiamo, per inciso, che la Cina era il principale acquirente di greggio venezuelano così come è il principale acquirente di greggio iraniano. In entrambi i casi, la Repubblica popolare aggirava le sanzioni statunitensi ed effettuava pagamenti in renminbi. Il che, insieme alla corsa all’oro degli ultimi due anni, era ed è fonte di preoccupazione per Washington.
Ora, l’ex presidente del Council of Economic Advisers della Casa Bianca e attuale membro del board dei governatori della Fed, Stephen Miran, ha ripetutamente sostenuto la necessità di preservare lo status globale del dollaro. E infatti, già a gennaio 2025 Trump minacciò i Brics di pesanti dazi, qualora avessero continuato a portare avanti i loro propositi di de-dollarizzazione. È quindi altamente verosimile che il presidente americano punti a controllare anche il greggio iraniano, per ribadire la supremazia del dollaro in funzione anti cinese. Ma attenzione: Pechino è nel mirino di Washington anche su un altro fronte. Sbloccando e incamerando il petrolio di Caracas e (forse) di Teheran, Trump mira a far crollare ulteriormente il costo dell’energia: il che, oltre a combattere l’inflazione statunitense in vista delle elezioni di metà mandato, ha l’obiettivo di indebolire la dipendenza degli Usa dalla tecnologia green. Tecnologia che è notoriamente in buona parte in mano ai cinesi. Ecco quindi che anche il recente annuncio dell’addio americano all’Unfccc assume una chiara connotazione di carattere geopolitico in funzione anti Pechino.
Continua a leggereRiduci