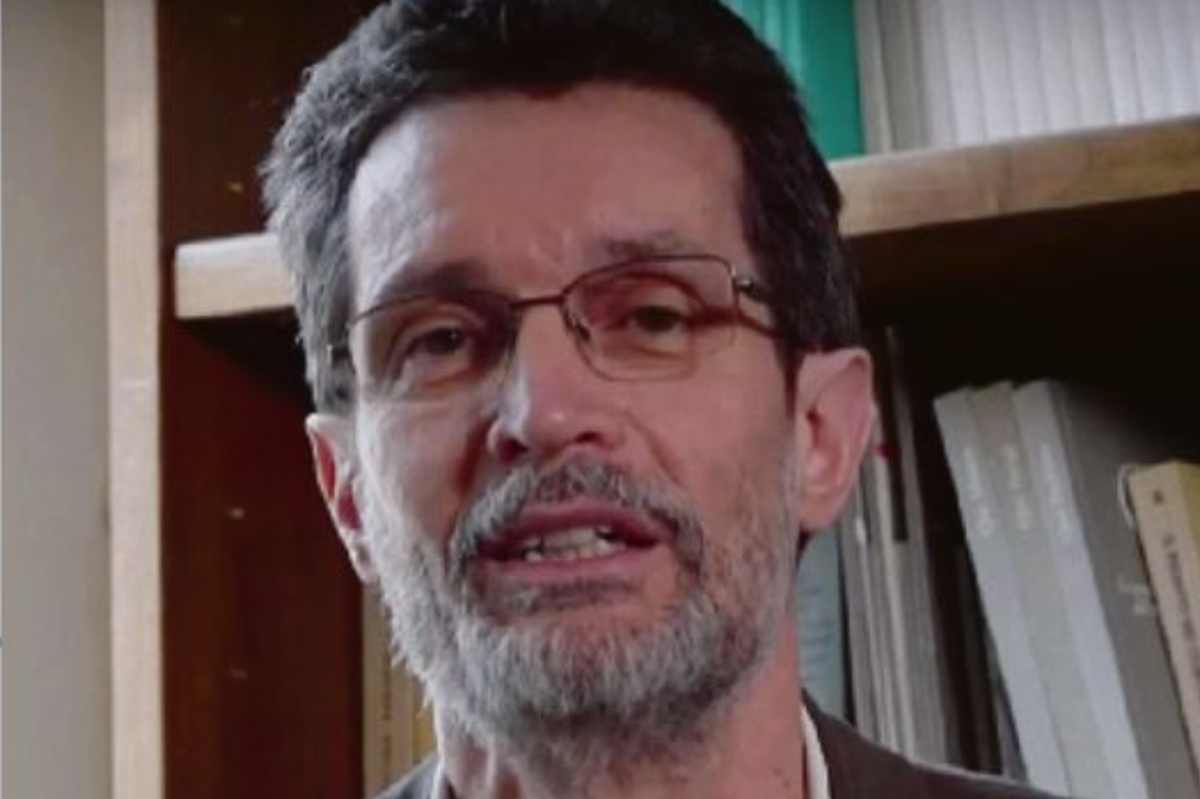
Benedetto Rocchi, economista e professore all’Università di Firenze, ha scelto da qualche tempo di inoltrarsi in un terreno da cui molti suoi pur illustri colleghi si tengono alla larga, ovvero quello dei cosiddetti «temi etici». Lo ha fatto, in ogni caso, sempre restando fedele al suo approccio scientifico. Ha affrontato, ad esempio, la questione della maternità surrogata, ma tenendo da parte valutazioni di carattere morale.
«Questo mio approccio non dovrebbe stupire troppo», dice. «In fondo, tutta la procreatica, cioè la tecnologia applicata alla riproduzione umana, si è ormai strutturata in una filiera di cui fanno parte imprese, investimenti, regolamentazioni, scambi commerciali, importazioni, esportazioni, anche di semilavorati (embrioni congelati, gameti)… Siccome c’è un mercato e ci sono delle transazioni economiche, l’economista può essere interessato da questo fenomeno e può studiarlo con la cassetta degli attrezzi che gli economisti hanno a disposizione per studiare i mercati».
Che cosa è esattamente quella che lei chiama «filiera procreatica»?
«La descriverei come una catena di aventi in cui, all’inizio, abbiamo l’immagine della coppia sterile e, alla fine, l’immagine di una famiglia felice con il bambino in braccio. L’obiettivo finale della filiera è, appunto, quello di ottenere un bambino attraverso un processo tecnologico che può essere suddiviso in diverse fasi. C’è la fase della produzione dei gameti e la fase della produzione dell’embrione umano. C’è la fase medica che riguarda l’impianto dell’embrione, quindi una gravidanza che talvolta viene fatta dai genitori, dagli acquirenti finali, cioè da chi paga per il servizio, oppure viene affidata a un’altra donna. E questo è il caso dell’utero in affitto. Ebbene, questa è la filiera. E l’obiettivo finale, ripeto, è quello di avere il bambino in braccio, il che è già un elemento rilevante».
Perché?
«Perché se alla fine della filiera la coppia deve avere il bambino in braccio, chi acquista il servizio deve avere anche delle garanzie. E, infatti, ci sono numerose offerte che contemplano varie ipotesi. Ad esempio ne ho trovata una in cui si prevede che, se il figlio muore entro tre anni dalla nascita, la coppia può ripetere gratuitamente il percorso».
Se capisco bene, adottare un approccio economico serve a mettere in luce aspetti come quest’ultimo.
«Sicuramente l’approccio economico non è esaustivo, non esaurisce le problematiche e l’approccio bioetico e l’approccio giuridico sono tutti fondamentali per formulare una valutazione. Ma l’approccio economico può mostrare alcuni aspetti di questi mercati che possono non funzionare o funzionare male e possono portare a ulteriori problemi».
Lei, ad esempio, potrebbe valutare i contratti che si utilizzano per la maternità surrogata.
«Sì. Io dico sempre utero in affitto perché, dal punto di vista economico, è la forma più corretta. Se si utilizza “gestazione per altri”, la parola gestazione dice che c’è solo una funzione in gioco nella transazione tra la coppia sterile e la donna che fornisce il servizio, cioè la funzione riproduttiva. In realtà qui abbiamo una transazione di tipo economico, esiste una contropartita monetaria, per cui affitto è un termine corretto».
Da economista, che cosa nota in questa transazione?
«Intanto possiamo affrontare il tema dei contratti e della loro incompletezza. Perché le transazioni economiche funzionino bene, il contratto deve essere completo, cioè l’accordo tra le parti - formale o informale che sia - dovrebbe includere tutte le possibili situazioni che si potrebbero verificare in questo scambio, così che la prestazione economica e la controprestazione monetaria siano equilibrate. Ma nel caso dell’utero in affitto è molto difficile avere un contratto completo che definisca tutti gli aspetti. Consideriamo, per esempio, il periodo della gravidanza: come fare a definire esattamente quali siano le funzionalità della donna coinvolte dal contratto e quali no? Come si possono definire tutte le possibili situazioni sanitarie riguardanti la salute della donna e del bambino? Insomma, quanti imprevisti ci possono essere che è difficile regolamentare prima?».
Parecchi, il che rende il contratto incompleto.
«Prendiamo un altro aspetto. Psicologi e filosofi ci dicono che la gravidanza sia un’esperienza trasformativa, cioè la donna che intraprende una gravidanza, di fatto, ne esce cambiata. Dunque il fatto di avere accettato alcune condizioni iniziali potrebbe non essere più accettabile alla fine della gravidanza. E, infatti, ci sono molti casi in cui la donna, alla fine della gravidanza, vuole tenere il bambino. Esiste una ampia casistica di battaglie legali, per esempio negli Stati Uniti, tra la madre surrogata e la coppia sterile che vuole l’affidamento del bambino. Capite che, dal punto di vista della transazione economica, è un bel problema perché innalza quelli che, tecnicamente, si chiamano costi di transazione».
Tanto meglio, no? Così almeno si eliminano un po’ di potenziali acquirenti…
«Mica tanto. Vede, ogni transazione economica ha da una parte una prestazione e dall’altra una controprestazione economica che si chiama prezzo, poi ci sono dei costi aggiuntivi che non sono inclusi nel prezzo e, però, vanno sostenuti. Se il contratto è per definizione incompleto, i costi tendono a essere molto alti. Qual è la possibile conseguenza di tutto questo? Che la transazione tende a spostarsi in mercati dove la regolamentazione degli scambi e le garanzie per le persone sono più bassi, perché questo abbassa i costi. Ecco che negli Stati Uniti una maternità surrogata può costare anche 100.000 dollari, mentre in Ucraina può costarne 40.000».
Insomma, esaminare i contratti ci fa capire che le transazioni tenderanno sempre a virare verso nazioni in cui ci sono meno diritti e più rischi.
«Poi dobbiamo considerare le cosiddette esternalità negative».
Spieghi.
«In uno scambio economico sono coinvolti due soggetti che fanno la transazione. Quando c’è un’esternalità, questa transazione genera dei costi o, al limite, dei benefici per persone terze che non sono coinvolte nello scambio. Esempio: quando un’industria inquina, nel produrre fa pagare una parte del costo di produzione a chi subisce l’inquinamento, cioè al un soggetto che non è coinvolto nello scambio tra l’industria e il compratore del prodotto. Nel caso dell’utero in affitto c’è sempre un terzo soggetto, il bambino, il quale inevitabilmente subisce gli effetti dello scambio».
Quali, ad esempio?
«Alle donne, durante la gravidanza, vengono imposte regole molto rigide: non devono cantare sotto la doccia, non devono accarezzarsi la pancia, devono seguire terapie piscologiche per non legarsi troppo al bambino. A che servano queste regole, è chiaro. Gli esperti di riproduzione, i medici, gli scienziati dicono che il rapporto tra la madre e il bambino comincia nella fase prenatale. Ci sono legami importantissimi che si formano in quel momento: il bambino riconosce la voce della madre, ne sente le emozioni. Normalmente, il rapporto con la madre continua dopo il parto ed è estremamente simbiotico. L’utero in affitto crea un taglio in questo rapporto immediato che può essere fonte di stress e di tensione per il bambino. Oltre che per la madre».
Di nuovo, l’analisi economica ci aiuta a mettere in luce aspetti negativi.
«Faccio un altro esempio. I nati da utero in affitto, programmaticamente, non verranno allattati al seno. Questa è una fonte di rischi sanitari, e di stress per il bambino».
Ciò significa che, in futuro, un bambino potrebbe persino decidere di impugnare il contratto o di agire legalmente contro chi gli ha causato problemi?
«Non so se esiste questa possibilità. Dico solo che, dal mio punto di vista, il contratto per l’utero in affitto è incompleto per definizione e, quindi, ha dei grossi rischi e dei costi di transazione che tendono a esplodere favorendo i mercati meno regolamentati, che sono quelli più pericolosi per le persone. In più, si tratta di una transazione che produce esternalità. Che possono essere immediate ma anche mostrarsi molto tempo dopo. In sostanza, parliamo di una transazione che non può funzionare bene».
E che ha moltissime incognite, visto che a volte coinvolge anche più di tre soggetti (i committenti, il bambino, la gestante, la fornitrice di ovuli…).
«A tale proposito, vorrei fare una precisazione. Si parla sempre di donatrici di ovuli e di donatori di semi ma è bene avere chiaro che tutte queste prestazioni avvengono dietro contropartite economiche. Come se io mi facessi pagare per donare il sangue».
Ha senso, secondo lei, immaginare una forma di «surrogata solidale»?
«Non penso sia possibile. Il dono deve avere due caratteristiche: bisogna farlo senza aspettarsi nulla in cambio. E bisogna mettere nelle condizioni chi lo riceve di poter ricambiare, un giorno, nello stesso modo gratuito. Se fai un dono troppo grande a una persona molto più povera di te, in realtà stai creando una forma di subalternità psicologica. Pertanto, il dono deve avere un elemento di parità. È evidente che, in una prestazione come l’utero in affitto, sia molto difficile pensare che l’acquirente, cioè la persona che riceve, non si senta in un debito forte nei confronti dell’altro. L’unico modo che ha per sentirsi libera da questa situazione è, appunto, pagare. Non c’è soltanto la questione dello sfruttamento legata al bisogno della madre surrogata. Anche la coppia sterile, proprio per sentirsi meno legata, vorrà pagare. Dunque no, non credo sia possibile una surrogata solidale o gratuita».






