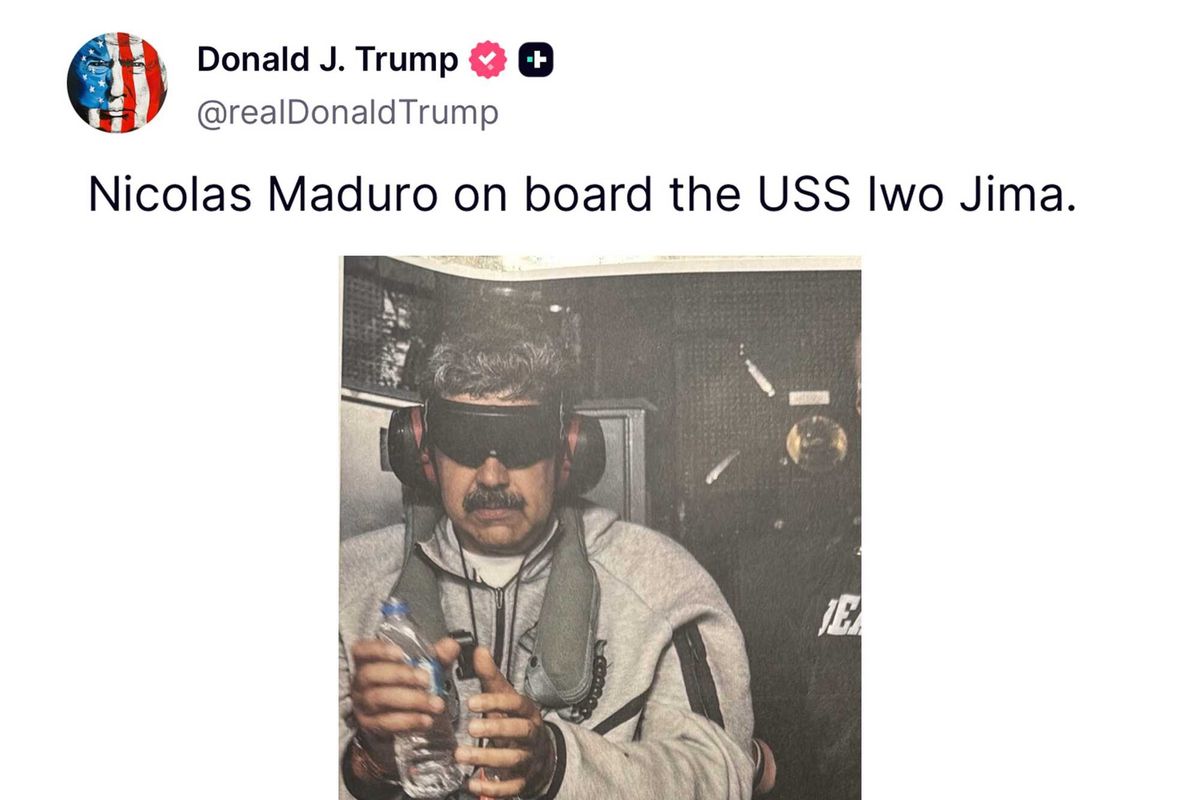Quella di oggi sarà una domenica delle Palme tecno-minimalista: poche palme e ulivi, messe solo televisive, niente asine bardate, tappeti in terra, niente «Osanna al Figlio di Davide», lavande dei piedi e tanti altri riti. Ancora una volta, l'infernale Covid-19 ci mostra come siamo stati stupidi a perderci o spesso annoiarci ai nostri riti antichi e preziosi, cui i soliti avidi cinesi (più attenti di noi) arrivavano con i bus per partecipare senza perdersi un coro, un affresco, un canto. Ma va bene così; purché si riesca ad uscire dalla pandemia, dopo averne imparate le molte lezioni, che ora si può forse cominciare a riconoscere. La prima (come anche lo Sguardo selvatico ha già cominciato a raccontare) è che probabilmente è finito il trentennio della «vita globalizzata»: un'estroversione no-stop in cui casa, interiorità, famiglia e tranquillità venivano considerati vecchi arnesi del passato, sinonimi di cattivo gusto e inaccettabile bigottismo.
In realtà il mondo ha sempre funzionato così: una successione di spinte verso l'esterno, come si fosse obbligati a correre «fuori» e lontano, con poi inevitabili rientri in sé stessi, «a casa», nei propri territori tradizionali, di sempre. La globalizzazione, infatti, non l'abbiamo mica inventata noi, come avevano fatto credere i suoi cantori dall'Università di Harvard (Massachusetts), o Busto Arsizio (Varese), e altrove. Già Alessandro Magno e poi l'Impero romano avevano creato le globalizzazioni dell'epoca. Cui era poi seguita la grande introversione dello studioso e operoso Medio evo, con i suoi monaci e i preziosi codici. Seguita poi ancora dalla successiva estroversione di Umanesimo e Rinascimento, in cui i maestri (d'armi, arti e mestieri, come Leonardo, e tanti altri) passavano dall'Italia alla Francia alla Germania come niente fosse.
«Fuori» e «dentro» sono insomma i due tempi di ogni fenomeno vitale, corrispondenti in natura (spiegano Goethe, filosofia della natura e molta antropologia) al respiro con la sua inspirazione e espirazione o alla sistole e diastole del battito cardiaco. È comunque indispensabile che i poli opposti ci siano entrambi, bene accordati, e che nessuno dei due tempi pretenda di cancellare l'altro, credendosi l'Unico, l'«ultimo grido» del pensiero o della storia (vedi dichiarazioni di Giuseppi sulla Storia che starebbe scrivendo assieme alla Merkel). Altrimenti c'è l'infarto.
È significativo che alla generazione delle sardine sia stata presentata fin dalla scuola solo la teoria finalistico-illuminista, tagliando di netto quella realista con Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer, Vilfredo Pareto, Isaiah Berlin, Raymond Aron, Henry Kissinger e tanti altri di cui questi ragazzi di solito ignorano anche l'esistenza: una lacuna che spiega molti aspetti della meteora delle sardine e del suo caratteristico mixing di apparente idealismo e sostanziale cinismo. Il principale scopo dell'idealismo illuminista è, ovviamente, il potere e i soldi. «Dio voglia che le nostre mani non restino inattive nelle nostra tasche», scriveva Georg Hegel, capofila dell'idealismo, all'amico filosofo Friedrich Schelling.
Non solo soldi, però: anche vanità e superficialità hanno una notevole importanza nel finalismo illuminista di ieri e di oggi. Convincersi di essere gli inesorabili portatori del futuro lì per lì toglie un sacco di problemi: basta - come fa il branco di sardine- seguire i due che stanno avanti: Mefistofele e l'Imperatore inetto e spendaccione del Faust, anch'egli del resto succube del diavolo. In questo modo, e contrariamente a Gesù e al cristiano, non devi neppure risorgere con la Pasqua, perché neanche muori (o così speri). Il «sogno faustiano» di onnipotenza è in fondo un'idiozia, e chi lo sa fin dall'inizio, naturalmente, è Mefistofele. Che oggi con la sua sperimentata freddezza uccide in tutto il mondo «globalizzato», spedendoci per via aerea un virus specializzato in disturbi polmonari che attacca appunto il respiro (il rapporto tra la psiche e lo Spirito), e manda in tilt tutto il sistema. Così basta estroversione coatta, volo intercontinentale come simbolo di status, tradimento obbligatorio del coniuge magari anche amato, naturalmente droga magari leggera sennò non sei nessuno. Tutte le costruzioni della vanità umana vengono alla fine distrutte, come nel Faust dove l'«orrenda vecchia», (l'angoscia per l'ansia di potere e ricchezza, mai completamente soddisfatta), raggiunge il Dottore nel suo sfarzoso castello, facendogli capire che: «Sia felice o no, è capriccio/ lo consuma l'abbondanza / solo ha in mente l'avvenire / è incapace di finire». Così è -del resto- l'inquieto «cuore dell'uomo» finché non riconosce il divino.
Molti, in questi giorni, si sono sentiti come Faust: costretti a fermarsi, bloccati non dall'angoscia faustiana ma dall'arrivo del Covid-19, con i tardivi e contraddittori editti dei Giuseppi, ognuno con la sua diversa autocertificazione di giornata. Però dopo il primo sconcerto e rabbia, quando hanno visto che forse riuscivano a scamparla è andata spesso meglio. Mentre prima erano come Faust: «sensi fuori perfetti/, ma dentro tenebre./ Da tutti i tesori del mondo/, non sa come trarre profitto».
Ciò che Faust soprattutto non tollera però, è la coppia duratura e felice: i vecchietti Filemone e Bauci, con quella loro casa da niente e quella chiesetta altrettanto semplice, lì davanti, di cui sono fedeli custodi. Il tutto piazzato nel mezzo della proprietà che gli ha regalato l'Imperatore, e che Faust ha trasformato in una meraviglia mai vista. Ernst Jünger (nel suo saggio Filemone e Bauci) vede Faust come il moderno «programmatore» della vita, posseduto dalla gelida tecnica e ormai incapace di amore, interiorità e profondità negli affetti e nelle relazioni. L'amore fedele della coppia, la loro devozione a Dio e alla semplicità, le grandi piante della quercia e del tiglio che proteggono la chiesetta interrompendo i grandi spazi aperti dalle superbe riforme di Faust, mettono in crisi la grandiosità inquieta del Dottore.
È nello scenario della presunzione sconfitta, fatalmente ricorrente nella storia umana, che l'arresto in casa, la quarantena in famiglia, la sparizione dell'esteriorità, della velocità, la scomparsa delle automobili, degli arei, delle programmazioni, del denaro, con neppur troppo sullo sfondo l'immagine della morte, ha avuto (più spesso di quanto si creda) l'effetto di una psicoterapia straordinariamente efficace e veloce. L'ordinaria intimità (cui non c'era più possibilità di sfuggire) è apparsa improvvisamente un dono bellissimo e profondo. Un regalo inaspettato. Non dover più fare la star e poter finalmente calarsi nella potente immagine del «servo sofferente» del profeta Isaia (una delle Letture di questi giorni), ha tolto di mezzo e polverizzato i più venerati maestri cafonal minimal horror o trash. Tanto da rendere possibile, tra sette giorni, l'altra super trasgressiva (ormai quasi clandestina) esperienza dell'antropologia e civiltà cristiana: la Resurrezione.