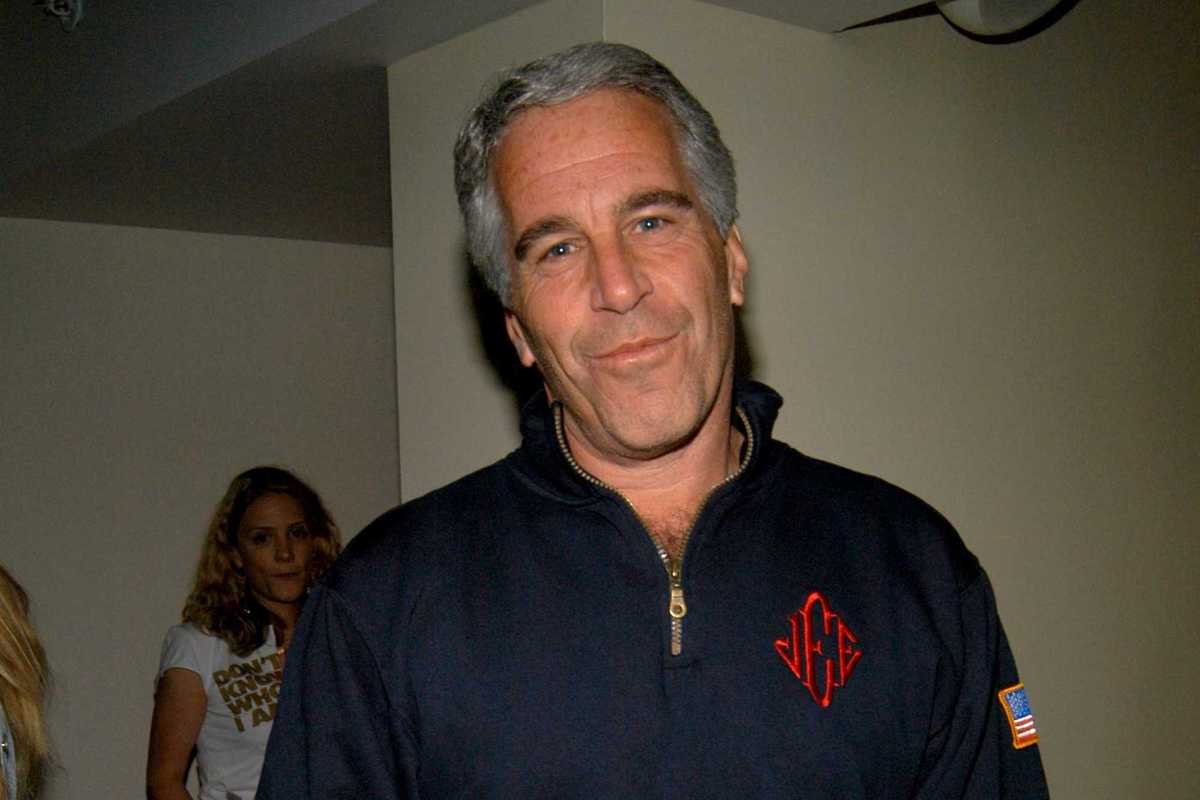True
2019-02-19
La legge per farla finita con l’utero in affitto
iStock
Vedremo chi avrà il coraggio di appoggiarlo, questo disegno di legge. Vedremo chi sarà capace di dare un calcio all'ideologia e di schierarsi a favore di una causa sacrosanta. Il nuovo testo che ha per primo firmatario il senatore leghista Simone Pillon è, a tutti gli effetti, uno spartiacque. Approvarlo significa bloccare una volta per tutte quella pratica ignobile chiamata, in tragico burocratese, «maternità surrogata». Una pratica proibita dalla legge italiana, condannata dai legislatori, da numerosi giudici e pure dal buonsenso, ma che è in corso di sdoganamento grazie ai volonterosi difensori dei diritti arcobaleno.
«Le tristi pratiche dell'utero in affitto e della compravendita di gameti umani», si legge nel testo del disegno di legge, «pur essendo considerate delittuose dal nostro ordinamento (legge n. 40 del 2004) sono purtroppo impunemente utilizzate da alcuni nostri connazionali che non si fanno scrupolo di acquistare gameti umani scelti su veri e propri cataloghi online, impiegando poi le donne quali autentiche incubatrici».
Come noto, infatti, sono numerose le coppie (sia gay sia eterosessuali) che fanno ricorso alla surrogazione all'estero, per poi tornare in Italia e registrare all'anagrafe i bambini. Purtroppo, come notano Pillon e i suoi colleghi, «non è possibile per il giudice italiano sanzionare tali reati commessi all'estero in quanto non rientrano nella previsione di cui all'articolo 7 del codice penale». Il nuovo disegno di legge serve proprio a colmare questo vuoto e a porre un freno «al triste fenomeno del cosiddetto “turismo riproduttivo", inasprendo inoltre le rispettive pene onde aumentare l'effetto deterrente della norma».
Le pene previste, infatti, sono severe. All'articolo due si legge: «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 800.000 a un milione di euro».
Sono misure più che condivisibili. Del resto, è stata la Corte costituzionale, nel 2017, a ribadire che la maternità surrogata «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane». E, pochi giorni fa, è stata la Cassazione a spiegare che il ricorso all'utero in affitto è comunque un reato, anche se non c'è stato passaggio di denaro.
Non è finita, però. Questo disegno di legge ha un ulteriore obiettivo, cioè quello di rendere «impossibile iscrivere o trascrivere atti di nascita di minori con due padri o con due madri, in violazione delle più elementari esigenze naturali oltre che del primario e superiore interesse del minore a non essere separato dai propri genitori naturali, come previsto dalla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia».
Questo, ovviamente, è il punto più delicato. Da parecchi mesi, vari Comuni italiani hanno cominciato a registrare i bambini delle coppie arcobaleno come «figli di due padri o due madri». Come sempre accade, sono stati tirati in ballo i «diritti» degli omosessuali. La registrazione si è trasformata in una sorta di battaglia di civiltà contro i bigotti cattivi che non vogliono rassegnarsi al progresso. Sotto le frasi commoventi e dietro le parole altisonanti, tuttavia, si cela la truffa. Registrare i «figli di due padri» significa, nei fatti, legittimare il ricorso all'utero in affitto. Ovvero aggirare la legge italiana, fingendo che le coppie arcobaleno abbiano trovato i pargoli sotto un cavolo durante un viaggio oltre confine.
Possiamo già prevedere quello che succederà. Gli attivisti Lgbt diranno che il ddl proposto da Pillon è omofobo e retrogrado, che punta alla discriminazione delle «famiglie omogenitoriali» e via dicendo. Ecco perché questo disegno di legge è fondamentale: permetterà di scoprire finalmente tutte le carte. Come voteranno i 5 stelle? Come si schiererà il Partito democratico? Staranno dalla parte dell'ordinamento italiano, dalla parte della Cassazione e della Consulta, oppure chiameranno in causa l'omofobia e difenderanno lo sfruttamento del corpo femminile per non fare dispetto agli amici rainbow? Sceglieranno di tutelare le donne e i bambini oppure respingeranno il testo perché lo ha proposto un leghista cattivo?
Il fronte che si oppone all'utero in affitto è molto ampio. Ci sono i cattolici e i conservatori, ma anche femministe, attiviste lesbiche, pensatori di sinistra. Per esempio la autorevole sociologa Daniela Danna, le cui parole andrebbero scolpite nella pietra: «Che cosa dà diritto ai medici di disporre di alcuni corpi femminile come “terapia" per l'incapacità di altri di avere dei figli?», scrive la studiosa. «Che cosa dà loro diritto di impiantare embrioni in una donna dicendo che sono di altri? Nulla, se non leggi ingiuste che configurano un nuovo campo di potere e un nuovo mercato che, come tutti i mercati, in parte risponde alla domanda e in parte la crea».
Ecco, è il momento di farla finita con questo mercato orrendo. È il momento di fermare una volta per tutte l'utero in affitto. La legge è scritta, sono appena tre articoletti. Basta semplicemente approvarla. Vedremo chi avrà il coraggio di farlo, chi oserà andare oltre l'appartenenza politica e schierarsi a favore di una buona battaglia. Una lotta per i diritti: ma i diritti veri, questa volta.
Francesco Borgonovo
Navratilova campionessa contro il pensiero unico: «Niente trans in campo»
Una tennista lesbica contro gli atleti transessuali. Martina Navratilova, leggenda del tennis, sul Sunday Times si è scagliata contro la moda di far gareggiare i trans con le donne. Secondo la sportiva, questa regola «ricompensa gli imbrogli e punisce l'innocente». La Navratilova non è andata per il sottile: «Lasciare che degli uomini gareggino come donne semplicemente perché hanno cambiato nome e assumono ormoni è ingiusto». Equiparare atleti trans ad atlete donne, in definitiva, è «una pratica folle».
Parole di buon senso. Perché il fisico di un transessuale rimane pur sempre quello di un uomo, anche se con i farmaci spunta il seno e si perde la peluria in eccesso. Le prestazioni non sono equiparabili: rimane un vantaggio strutturale che penalizza una donna, solo in quanto biologicamente tale. Il tutto, nel nome dell'ideologia arcobaleno, che pretende di costringere la realtà ad adeguarsi alla sua farneticazione sui «generi» distinti dai «sessi». Niente più maschi e femmine per volere divino o, semplicemente, per caso. Al posto della natura e della biologia, la fantasia al potere: ognuno può essere quel che preferisce, uomo, donna, transgender, non binario... A New York, già da parecchi mesi l'anagrafe propone oltre trenta opzioni diverse.
La tesi della Navratilova, però, assume una particolare rilevanza non solamente per la sua storia sportiva, ma anche e soprattutto perché la tennista con doppia nazionalità, statunitense e ceca, è un'icona gay. Fece coming out negli anni Ottanta, si è battuta per i diritti degli omosessuali ed è sposata con una donna, la modella russa Julia Lemigova. Inevitabilmente, se è lei a dire che bisogna «deplorare la tirannia» degli attivisti trans, i quali «denunciano chiunque si opponga a loro», la stoccata fa più effetto. Set, game, match, come si dice nella disciplina che l'ha resa celebre. La Navratilova è l'atleta più anziana ad aver vinto una prova del Grande slam: nel 2006, quasi cinquantenne, trionfò nel doppio misto agli Us open. A metà degli anni Settanta, si trasferì negli Stati Uniti, di cui divenne cittadina nel 1981. Dato che si rincorrevano le indiscrezioni su una sua relazione saffica con la scrittrice Rita Mae Brown, poco dopo aver ottenuto la cittadinanza americana, la Navratilova ammise di essere lesbica. Questo la rese un mito per la comunità omosessuale, mentre la turbolenta separazione dalla compagna Judy Nelson, avvenuta dopo una relazione durata otto anni, contribuì a tenere la sua vita privata sotto i riflettori.
In teoria, alla Navratilova non manca nessun requisito per conservare la sua aura di eroina Lgbt. È stata anche un'attivista dei diritti degli animali, per un certo periodo ha scelto un regime alimentare vegetariano e alla fine si è convertita al «pescetarianismo». Le carte del politicamente corretto, in breve, parrebbero tutte in regola. Eppure, l'idea che bastino la bizzarra dicotomia tra sesso e genere e qualche artificio legale per consentire a un uomo di gareggiare contro atlete donne, strutturalmente svantaggiate, proprio non le va giù. E non le va giù che chi esige quest'equiparazione, proprio perché è un'operazione che cozza con qualunque evidenza scientifica, pretenda di imporla attraverso la censura ideologica.
La battaglia della Navratilova contro quelli che vogliono vincere facile, per usare lo slogan di una nota pubblicità, dura in effetti già da qualche mese. Lo scorso dicembre, una delle sue seguaci su Twitter le aveva chiesto un parere sui transgender nello sport. Evidentemente, gli atleti arcobaleno si aspettavano una convinta sponsorizzazione da un'animalista lesbica sposata con una donna. E invece, lei aveva risposto così: «Chiaramente non può essere giusto. Non puoi semplicemente proclamarti una femmina e competere con le donne. Ci devono essere degli standard e avere un pene e competere come una donna non sarebbe adatto a quello standard». Paradosso esistenziale: un'omosessuale che scrive cose omofobe. Tipo che gli uomini hanno un pene. E che nello sport servono degli standard, affinché si possa gareggiare in condizioni di parità. Dinanzi a un tale saggio di intolleranza, la comunità transgender non poteva restare in silenzio.
Rachel McKinnon, ciclista trans che - coincidenza - a ottobre aveva vinto il titolo femminile iridato della pista ai campionati mondiali di Los Angeles, si era subito ribellata: «Martina è gravemente responsabile dei commenti transfobici pubblici fatti contro persone di sesso alternativo alla nascita. La incito a chiedere pubblicamente scusa, non si gioca a tennis con i genitali». Un perfetto esempio di inquisizione Lgbt. Parola d'ordine: sesso alternativo. Capo d'imputazione: transfobia. Condanna: pubblica ammenda. Pena tutto sommato indulgente, forse per i trascorsi meriti della rea. La quale, infatti, cancellò il tweet e si scusò: «Sono dispiaciuta se ho detto qualcosa di transfobico, non volevo offendere nessuno, cercherò di informarmi meglio e, nel frattempo, non ne parlerò più». Perché chi, nonostante le dosi quotidiane di propaganda Lgbt, ha un'idea diversa, per la lobby arcobaleno fa meglio a stare zitto. Ma il silenzio non si confaceva alla Navratilova, che domenica è tornata a dire la sua, osando stigmatizzare la furia censoria degli attivisti transgender. Ora, vista la reiterazione del reato, la punizione rischia di essere molto più severa.
Alessandro Rico
Luxuria debutta come cantante a colpi di insulti rivolti ai maschi
Vladimir Luxuria si è reiventata cantante. L'ex parlamentare, che a fine gennaio ha tentato di infarcire le testoline dei bambini Rai con favole su uccelli in gabbia e vecchie cattive, ha pubblicato oggi il suo primo singolo. E al diavolo chiunque le dica che il troppo stroppia.
«Sicuramente qualcuno penserà: “Questa ha fatto la parlamentare, la televisione, le battaglie per i diritti civili e ora vuole fare pure la cantante?". Ebbene sì, voglio fare anche la cantante», ha dichiarato Luxuria a VanityFair.it, presentando l'ultima sua fatica. Sono un uomo, brano deputato ad anticipare l'album Vladyland, è stato definito una «ballata ironica sulla retorica machista». Ma ad ascoltare il singolo e a guardarne il video, recitato da un Ken di Barbie con mutandina e divisa daranger, di ironico vi si ritrova ben poco. Protetta dallo spauracchio del sarcasmo, Luxuria ha potuto riversare in musica una morale spiccia, per cui l'uomo è un essere di caratura infima, «stravaccato sul divano» con «sei telecomandi in mano».
«Vorrei non banalizzare, dir qualcosa di speciale, ma sono un uomo e non credo che l'amore vada oltre un bel sedere», ha cantato, sciorinandoli tutti i luoghi comuni sull'universo maschile. La birra, le suocere, le fidanzate.
E, ancora, l'incapacità di ascoltare, la fobia del medico, la matrice spaccona che ogni maschio degno di un tale epiteto dovrebbe sentire connaturata al proprio io. Luxuria ha passato in rassegna ogni stereotipo associato all'uomo. Peccato solo si sia data la pena di farlo nell'era di Facebook, quando tutto è già stato meme e nulla è più capace di produrre un sorriso.
Sono un uomo, di cui VanityFair.it ha tenuto a mettere in luce l'origine satirica, l'intento parodistico, non è riuscito ad assolvere il proprio compito. Non ha divertito e nemmeno intrattenuto. Anzi. Quasi si è prodotto nell'effetto opposto, sostanziando l'ipotesi di una Luxuria certa della propria invincibilità.
L'ex parlamentare, nell'arco di un mese, ha tenuto la propria lezione sul gender ai bambini di Alla Lavagna!, su Rai3, e poi ne ha rivendicato la bontà a Non è l'Arena, su La7, imbarcandosi in una diatriba con Daniela Santanchè culminata in un elegante: «Sei più trans di me». La Santanchè, al cospetto di Massimo Giletti, aveva osato chiamare in causa la natura, associando un pene al sesso maschile e una vagina al sesso femminile. Di qui la logica conclusione: «Con tutto il rispetto, lei ha il pene e quindi è un uomo». Banalizzazione, questa, che a Luxuria è risultata indigesta.
L'attivista, che su Twitter non lesina ramanzine sull'importanza delle parole e l'orrore del bullismo, ha liquidato la Santanchè con una frase non esattamente di classe: «Non mi parli di natura proprio lei che ha fatto molti più interventi estetici di me». Come se, in un dibattito ponderato sull'identità sessuale, potesse giocare un qualche ruolo l'esistenza del filler per le labbra.
Luxuria, su La7, ha rivendicato il proprio diritto di essere donna. Poi, però, ha negato quello della Santanchè alla cura della propria immagine. L'ha denigrata perché rifatta, Luxuria, protetta da una gonna in nome della quale non tutto può essere detto e perdonato.
L'impressione, infatti, è che Vladimir Luxuria usi sé stessa, l'identità sessuale per la quale ha lottato fuori e dentro le piazze, (anche) per dire quel che a nessun uomo sarebbe mai scusato. E il debutto musicale non eccede la regola. Sono un uomo, canzone banale che alla bonaria rivalità tra sessi non è stata capace di aggiungere alcunché, è giudicata ironica perché cantata da una donna e rivolta all'uomo balordo.
Ma se, per assurdo, il progetto fosse stato inverso, se fosse stato un uomo a cantare, parodiandole, le donne, il cielo si sarebbe aperto e uno sciame di piccole Boldrini inferocite sarebbe calato sull'umanità. Se la canzone si fosse chiamata Sono una donna e avesse irriso, con tanto di Barbie, bionda e seminuda, nel video, l'incapacità femminile di parcheggiare, il ciclo mestruale e i telefoni roventi, la bandiera della satira sarebbe stata bruciata al grido di #MeToo.
Federico Rossi
Continua a leggereRiduci
Il leghista Simone Pillon primo firmatario di una proposta che prevede il carcere da 3 a 6 anni e multe fino a 1 milione di euro per chi sfrutta il corpo femminile. Verranno puniti anche i «turisti della riproduzione» che vanno all'estero per aggirare le norme italiane.Sul Times, la tennista lesbica scrive: «È un imbroglio farli gareggiare con le donne». Mesi fa l'aveva detto in tweet ma fu costretta a rimuoverlo.L'ex parlamentare ha presentato «Sono un uomo», il brano singolo che anticipa l'album «Vladyland». Vorrebbe essere un pezzo satirico, ma si rivela una rassegna di banalità.Lo speciale contiene tre articoli.Vedremo chi avrà il coraggio di appoggiarlo, questo disegno di legge. Vedremo chi sarà capace di dare un calcio all'ideologia e di schierarsi a favore di una causa sacrosanta. Il nuovo testo che ha per primo firmatario il senatore leghista Simone Pillon è, a tutti gli effetti, uno spartiacque. Approvarlo significa bloccare una volta per tutte quella pratica ignobile chiamata, in tragico burocratese, «maternità surrogata». Una pratica proibita dalla legge italiana, condannata dai legislatori, da numerosi giudici e pure dal buonsenso, ma che è in corso di sdoganamento grazie ai volonterosi difensori dei diritti arcobaleno. «Le tristi pratiche dell'utero in affitto e della compravendita di gameti umani», si legge nel testo del disegno di legge, «pur essendo considerate delittuose dal nostro ordinamento (legge n. 40 del 2004) sono purtroppo impunemente utilizzate da alcuni nostri connazionali che non si fanno scrupolo di acquistare gameti umani scelti su veri e propri cataloghi online, impiegando poi le donne quali autentiche incubatrici». Come noto, infatti, sono numerose le coppie (sia gay sia eterosessuali) che fanno ricorso alla surrogazione all'estero, per poi tornare in Italia e registrare all'anagrafe i bambini. Purtroppo, come notano Pillon e i suoi colleghi, «non è possibile per il giudice italiano sanzionare tali reati commessi all'estero in quanto non rientrano nella previsione di cui all'articolo 7 del codice penale». Il nuovo disegno di legge serve proprio a colmare questo vuoto e a porre un freno «al triste fenomeno del cosiddetto “turismo riproduttivo", inasprendo inoltre le rispettive pene onde aumentare l'effetto deterrente della norma».Le pene previste, infatti, sono severe. All'articolo due si legge: «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 800.000 a un milione di euro». Sono misure più che condivisibili. Del resto, è stata la Corte costituzionale, nel 2017, a ribadire che la maternità surrogata «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane». E, pochi giorni fa, è stata la Cassazione a spiegare che il ricorso all'utero in affitto è comunque un reato, anche se non c'è stato passaggio di denaro. Non è finita, però. Questo disegno di legge ha un ulteriore obiettivo, cioè quello di rendere «impossibile iscrivere o trascrivere atti di nascita di minori con due padri o con due madri, in violazione delle più elementari esigenze naturali oltre che del primario e superiore interesse del minore a non essere separato dai propri genitori naturali, come previsto dalla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia».Questo, ovviamente, è il punto più delicato. Da parecchi mesi, vari Comuni italiani hanno cominciato a registrare i bambini delle coppie arcobaleno come «figli di due padri o due madri». Come sempre accade, sono stati tirati in ballo i «diritti» degli omosessuali. La registrazione si è trasformata in una sorta di battaglia di civiltà contro i bigotti cattivi che non vogliono rassegnarsi al progresso. Sotto le frasi commoventi e dietro le parole altisonanti, tuttavia, si cela la truffa. Registrare i «figli di due padri» significa, nei fatti, legittimare il ricorso all'utero in affitto. Ovvero aggirare la legge italiana, fingendo che le coppie arcobaleno abbiano trovato i pargoli sotto un cavolo durante un viaggio oltre confine. Possiamo già prevedere quello che succederà. Gli attivisti Lgbt diranno che il ddl proposto da Pillon è omofobo e retrogrado, che punta alla discriminazione delle «famiglie omogenitoriali» e via dicendo. Ecco perché questo disegno di legge è fondamentale: permetterà di scoprire finalmente tutte le carte. Come voteranno i 5 stelle? Come si schiererà il Partito democratico? Staranno dalla parte dell'ordinamento italiano, dalla parte della Cassazione e della Consulta, oppure chiameranno in causa l'omofobia e difenderanno lo sfruttamento del corpo femminile per non fare dispetto agli amici rainbow? Sceglieranno di tutelare le donne e i bambini oppure respingeranno il testo perché lo ha proposto un leghista cattivo?Il fronte che si oppone all'utero in affitto è molto ampio. Ci sono i cattolici e i conservatori, ma anche femministe, attiviste lesbiche, pensatori di sinistra. Per esempio la autorevole sociologa Daniela Danna, le cui parole andrebbero scolpite nella pietra: «Che cosa dà diritto ai medici di disporre di alcuni corpi femminile come “terapia" per l'incapacità di altri di avere dei figli?», scrive la studiosa. «Che cosa dà loro diritto di impiantare embrioni in una donna dicendo che sono di altri? Nulla, se non leggi ingiuste che configurano un nuovo campo di potere e un nuovo mercato che, come tutti i mercati, in parte risponde alla domanda e in parte la crea». Ecco, è il momento di farla finita con questo mercato orrendo. È il momento di fermare una volta per tutte l'utero in affitto. La legge è scritta, sono appena tre articoletti. Basta semplicemente approvarla. Vedremo chi avrà il coraggio di farlo, chi oserà andare oltre l'appartenenza politica e schierarsi a favore di una buona battaglia. Una lotta per i diritti: ma i diritti veri, questa volta.Francesco Borgonovo<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/la-legge-per-farla-finita-con-lutero-in-affitto-2629319529.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="navratilova-campionessa-contro-il-pensiero-unico-niente-trans-in-campo" data-post-id="2629319529" data-published-at="1772588956" data-use-pagination="False"> Navratilova campionessa contro il pensiero unico: «Niente trans in campo» Una tennista lesbica contro gli atleti transessuali. Martina Navratilova, leggenda del tennis, sul Sunday Times si è scagliata contro la moda di far gareggiare i trans con le donne. Secondo la sportiva, questa regola «ricompensa gli imbrogli e punisce l'innocente». La Navratilova non è andata per il sottile: «Lasciare che degli uomini gareggino come donne semplicemente perché hanno cambiato nome e assumono ormoni è ingiusto». Equiparare atleti trans ad atlete donne, in definitiva, è «una pratica folle». Parole di buon senso. Perché il fisico di un transessuale rimane pur sempre quello di un uomo, anche se con i farmaci spunta il seno e si perde la peluria in eccesso. Le prestazioni non sono equiparabili: rimane un vantaggio strutturale che penalizza una donna, solo in quanto biologicamente tale. Il tutto, nel nome dell'ideologia arcobaleno, che pretende di costringere la realtà ad adeguarsi alla sua farneticazione sui «generi» distinti dai «sessi». Niente più maschi e femmine per volere divino o, semplicemente, per caso. Al posto della natura e della biologia, la fantasia al potere: ognuno può essere quel che preferisce, uomo, donna, transgender, non binario... A New York, già da parecchi mesi l'anagrafe propone oltre trenta opzioni diverse. La tesi della Navratilova, però, assume una particolare rilevanza non solamente per la sua storia sportiva, ma anche e soprattutto perché la tennista con doppia nazionalità, statunitense e ceca, è un'icona gay. Fece coming out negli anni Ottanta, si è battuta per i diritti degli omosessuali ed è sposata con una donna, la modella russa Julia Lemigova. Inevitabilmente, se è lei a dire che bisogna «deplorare la tirannia» degli attivisti trans, i quali «denunciano chiunque si opponga a loro», la stoccata fa più effetto. Set, game, match, come si dice nella disciplina che l'ha resa celebre. La Navratilova è l'atleta più anziana ad aver vinto una prova del Grande slam: nel 2006, quasi cinquantenne, trionfò nel doppio misto agli Us open. A metà degli anni Settanta, si trasferì negli Stati Uniti, di cui divenne cittadina nel 1981. Dato che si rincorrevano le indiscrezioni su una sua relazione saffica con la scrittrice Rita Mae Brown, poco dopo aver ottenuto la cittadinanza americana, la Navratilova ammise di essere lesbica. Questo la rese un mito per la comunità omosessuale, mentre la turbolenta separazione dalla compagna Judy Nelson, avvenuta dopo una relazione durata otto anni, contribuì a tenere la sua vita privata sotto i riflettori. In teoria, alla Navratilova non manca nessun requisito per conservare la sua aura di eroina Lgbt. È stata anche un'attivista dei diritti degli animali, per un certo periodo ha scelto un regime alimentare vegetariano e alla fine si è convertita al «pescetarianismo». Le carte del politicamente corretto, in breve, parrebbero tutte in regola. Eppure, l'idea che bastino la bizzarra dicotomia tra sesso e genere e qualche artificio legale per consentire a un uomo di gareggiare contro atlete donne, strutturalmente svantaggiate, proprio non le va giù. E non le va giù che chi esige quest'equiparazione, proprio perché è un'operazione che cozza con qualunque evidenza scientifica, pretenda di imporla attraverso la censura ideologica. La battaglia della Navratilova contro quelli che vogliono vincere facile, per usare lo slogan di una nota pubblicità, dura in effetti già da qualche mese. Lo scorso dicembre, una delle sue seguaci su Twitter le aveva chiesto un parere sui transgender nello sport. Evidentemente, gli atleti arcobaleno si aspettavano una convinta sponsorizzazione da un'animalista lesbica sposata con una donna. E invece, lei aveva risposto così: «Chiaramente non può essere giusto. Non puoi semplicemente proclamarti una femmina e competere con le donne. Ci devono essere degli standard e avere un pene e competere come una donna non sarebbe adatto a quello standard». Paradosso esistenziale: un'omosessuale che scrive cose omofobe. Tipo che gli uomini hanno un pene. E che nello sport servono degli standard, affinché si possa gareggiare in condizioni di parità. Dinanzi a un tale saggio di intolleranza, la comunità transgender non poteva restare in silenzio. Rachel McKinnon, ciclista trans che - coincidenza - a ottobre aveva vinto il titolo femminile iridato della pista ai campionati mondiali di Los Angeles, si era subito ribellata: «Martina è gravemente responsabile dei commenti transfobici pubblici fatti contro persone di sesso alternativo alla nascita. La incito a chiedere pubblicamente scusa, non si gioca a tennis con i genitali». Un perfetto esempio di inquisizione Lgbt. Parola d'ordine: sesso alternativo. Capo d'imputazione: transfobia. Condanna: pubblica ammenda. Pena tutto sommato indulgente, forse per i trascorsi meriti della rea. La quale, infatti, cancellò il tweet e si scusò: «Sono dispiaciuta se ho detto qualcosa di transfobico, non volevo offendere nessuno, cercherò di informarmi meglio e, nel frattempo, non ne parlerò più». Perché chi, nonostante le dosi quotidiane di propaganda Lgbt, ha un'idea diversa, per la lobby arcobaleno fa meglio a stare zitto. Ma il silenzio non si confaceva alla Navratilova, che domenica è tornata a dire la sua, osando stigmatizzare la furia censoria degli attivisti transgender. Ora, vista la reiterazione del reato, la punizione rischia di essere molto più severa. Alessandro Rico <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/la-legge-per-farla-finita-con-lutero-in-affitto-2629319529.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="luxuria-debutta-come-cantante-a-colpi-di-insulti-rivolti-ai-maschi" data-post-id="2629319529" data-published-at="1772588956" data-use-pagination="False"> Luxuria debutta come cantante a colpi di insulti rivolti ai maschi Vladimir Luxuria si è reiventata cantante. L'ex parlamentare, che a fine gennaio ha tentato di infarcire le testoline dei bambini Rai con favole su uccelli in gabbia e vecchie cattive, ha pubblicato oggi il suo primo singolo. E al diavolo chiunque le dica che il troppo stroppia. «Sicuramente qualcuno penserà: “Questa ha fatto la parlamentare, la televisione, le battaglie per i diritti civili e ora vuole fare pure la cantante?". Ebbene sì, voglio fare anche la cantante», ha dichiarato Luxuria a VanityFair.it, presentando l'ultima sua fatica. Sono un uomo, brano deputato ad anticipare l'album Vladyland, è stato definito una «ballata ironica sulla retorica machista». Ma ad ascoltare il singolo e a guardarne il video, recitato da un Ken di Barbie con mutandina e divisa daranger, di ironico vi si ritrova ben poco. Protetta dallo spauracchio del sarcasmo, Luxuria ha potuto riversare in musica una morale spiccia, per cui l'uomo è un essere di caratura infima, «stravaccato sul divano» con «sei telecomandi in mano». «Vorrei non banalizzare, dir qualcosa di speciale, ma sono un uomo e non credo che l'amore vada oltre un bel sedere», ha cantato, sciorinandoli tutti i luoghi comuni sull'universo maschile. La birra, le suocere, le fidanzate. E, ancora, l'incapacità di ascoltare, la fobia del medico, la matrice spaccona che ogni maschio degno di un tale epiteto dovrebbe sentire connaturata al proprio io. Luxuria ha passato in rassegna ogni stereotipo associato all'uomo. Peccato solo si sia data la pena di farlo nell'era di Facebook, quando tutto è già stato meme e nulla è più capace di produrre un sorriso. Sono un uomo, di cui VanityFair.it ha tenuto a mettere in luce l'origine satirica, l'intento parodistico, non è riuscito ad assolvere il proprio compito. Non ha divertito e nemmeno intrattenuto. Anzi. Quasi si è prodotto nell'effetto opposto, sostanziando l'ipotesi di una Luxuria certa della propria invincibilità. L'ex parlamentare, nell'arco di un mese, ha tenuto la propria lezione sul gender ai bambini di Alla Lavagna!, su Rai3, e poi ne ha rivendicato la bontà a Non è l'Arena, su La7, imbarcandosi in una diatriba con Daniela Santanchè culminata in un elegante: «Sei più trans di me». La Santanchè, al cospetto di Massimo Giletti, aveva osato chiamare in causa la natura, associando un pene al sesso maschile e una vagina al sesso femminile. Di qui la logica conclusione: «Con tutto il rispetto, lei ha il pene e quindi è un uomo». Banalizzazione, questa, che a Luxuria è risultata indigesta. L'attivista, che su Twitter non lesina ramanzine sull'importanza delle parole e l'orrore del bullismo, ha liquidato la Santanchè con una frase non esattamente di classe: «Non mi parli di natura proprio lei che ha fatto molti più interventi estetici di me». Come se, in un dibattito ponderato sull'identità sessuale, potesse giocare un qualche ruolo l'esistenza del filler per le labbra. Luxuria, su La7, ha rivendicato il proprio diritto di essere donna. Poi, però, ha negato quello della Santanchè alla cura della propria immagine. L'ha denigrata perché rifatta, Luxuria, protetta da una gonna in nome della quale non tutto può essere detto e perdonato. L'impressione, infatti, è che Vladimir Luxuria usi sé stessa, l'identità sessuale per la quale ha lottato fuori e dentro le piazze, (anche) per dire quel che a nessun uomo sarebbe mai scusato. E il debutto musicale non eccede la regola. Sono un uomo, canzone banale che alla bonaria rivalità tra sessi non è stata capace di aggiungere alcunché, è giudicata ironica perché cantata da una donna e rivolta all'uomo balordo. Ma se, per assurdo, il progetto fosse stato inverso, se fosse stato un uomo a cantare, parodiandole, le donne, il cielo si sarebbe aperto e uno sciame di piccole Boldrini inferocite sarebbe calato sull'umanità. Se la canzone si fosse chiamata Sono una donna e avesse irriso, con tanto di Barbie, bionda e seminuda, nel video, l'incapacità femminile di parcheggiare, il ciclo mestruale e i telefoni roventi, la bandiera della satira sarebbe stata bruciata al grido di #MeToo. Federico Rossi
Ermanno Scervino (Getty Images)
Da dove parte una sua collezione: da un’immagine, da un tessuto, da una donna reale?
«L’ispirazione non ha orari né confini. Vivo in Toscana, nella bellezza, affascinante quanto il paesaggio è il lavoro delle première: un’idea può scaturire dalla loro manualità come dagli imprevisti. Le capitali del mondo, comunque, rimangono grandi fonti di ispirazione: la gente per strada, nei locali, la vita di tutti i giorni, i giovani».
Il suo stile è spesso definito «romanticismo sexy»: cosa significa questa espressione e come si traduce in silhouette, materiali e lavorazioni?
«Una sottoveste di pizzo, una gonna di organza, un vestito di chiffon acquistano grazia e carattere soprattutto quando indossate con qualcosa di insolito, magari di maschile o sportivo. Questo accostamento è forse il mio modo più significativo di vedere un romanticismo contemporaneo, una sensualità vissuta con personalità».
Cosa le chiedono oggi le sue clienti?
«Sicuramente la portabilità, la funzionalità e il dialogo col corpo rimangono caratteristiche sempre richieste. Negli anni tutto cambia ma non il gusto per il bello. La donna contemporanea rischia di più, la strada offre e cerca stimoli sempre maggiori; vestirsi bene, oggi, non significa essere convenzionali. Io mi rivolgo a una donna libera, che non ama gli stereotipi, ma moderna e attuale».
Ha vestito molte personalità del cinema, della musica e della società internazionale. Per un abito da red carpet quanto conta il dialogo con la persona che lo indossa?
«Ogni donna è un universo da scoprire, e sono tante quelle con cui abbiamo condiviso momenti di bellezza e di arte. Il dialogo conta: gli abiti nascono non per imporre un’identità ma per accompagnare e valorizzare chi li indossa. La vera eleganza è essere sé stesse e il mio lavoro è facilitare questo processo».
La produzione made in Italy è un valore centrale per il suo brand. Cosa significa oggi difendere e promuovere l’artigianalità italiana in un mercato globale?
«È una missione. Il made in Italy è frutto di una tradizione secolare, intere generazioni hanno primeggiato nella maestria sartoriale lasciando al Paese un’eredità diventata patrimonio mondiale».
Quali sono oggi i mercati più importanti? Nota differenze di gusto tra Europa, America e Asia?
«I mercati più importanti sono Europa e America. Non ci sono differenze di gusto nei mercati, ma nelle donne sì, nella loro individualità. Immagino le mie creazioni al di là del Paese di provenienza di chi le indosserà».
Come riesce a coniugare tecniche sartoriali tradizionali con la sperimentazione su tessuti e lavorazioni innovative?
«La ricerca è fondamentale: creare nuovi tessuti, provare lavaggi e trattamenti. Tradizione e innovazione devono camminare assieme per realizzare un prodotto contemporaneo, ma il gesto artigianale resterà sempre al centro».
Quanto influisce Firenze sul Dna del marchio? È solo sede produttiva o anche fonte di ispirazione estetica?
«Firenze è sinonimo di casa. Territorio di tradizione e sapere, custodisce e tramanda competenze uniche. È questo patrimonio umano e culturale che alimenta il nostro lavoro e predispone alla creatività e da cui il brand continua ad attingere».
Le sue lavorazioni knit e i tessuti ricercati sono diventati un segno distintivo. Quanto conta la ricerca sui materiali nello sviluppo di ogni collezione?
«Prima ancora di disegnare penso ai materiali, li provo sul manichino, osservo il loro movimento e la luce, e mentre li studio penso a come trasformarli e a quello che possono diventare».
In che modo la maison affronta il tema della sostenibilità senza rinunciare al lusso e alla qualità?
«La sostenibilità è una responsabilità, non una scelta. Oltre a selezionare materiali e lavorazioni nel rispetto dell’ambiente, un capo ben realizzato nasce per durare a lungo ed è per definizione sostenibile: le mie collezioni sono concepite per vivere attraverso gli anni».
Dopo tanti anni di successi, quali sono oggi le sue nuove sfide e quali sogni desidera ancora realizzare?
«I successi non li considero un punto di arrivo ma una direzione. C’è la volontà di sviluppare senza tradire il nostro percorso, e di tramandare una visione ambiziosa che nasce dalla sapienza del nostro territorio. Abbiamo in programma molte aperture in alcune delle città più importanti e prestigiose del mondo».
Continua a leggereRiduci
Matteo Zuppi (Imagoeconomica)
L’allarme arriva dal cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo della città e presidente della Cei: «È un segnale molto preoccupante, specchio di una trasformazione sociale rapidissima. Non si tratta di una crisi di fede ma di un radicale mutamento del territorio. Gli alti affitti hanno spinto fuori le famiglie, gli studenti hanno preso il loro posto per poi essere a loro volta sostituiti dalla proliferazione di Bed&breakfast e uffici. Il centro rischia di diventare una vetrina vuota. Questi processi vanno governati e non subìti». Lo dice con struggente preoccupazione. Lo dice come se fosse arrivato da Marte con l’ultima navicella spaziale; invece da dieci anni è il più importante pastore di anime del territorio.
L’analisi sociologica (parziale e un minimo interessata) per quello zero in religione è completata da don Giovanni Bonfiglioli, parroco delle centralissime chiese di San Giuliano e della Santissima Trinità: «Quando andiamo nelle case per le benedizioni di rito ci accorgiamo che non c’è nulla da benedire, solo Bed&breakfast e uffici. Un vero e proprio spopolamento nel cuore della città». Ed ecco che torna ad aleggiare l’anatema del cardinale Giacomo Biffi, quel «Bologna sazia e disperata» con il quale, 40 anni fa, l’alto prelato intendeva svegliare la società dal sonno consumistico e nichilista.
Sarà anche colpa dei B&b, delle sedi di società e banche, dei locali da apericena ma la sindrome da catechismo deserto non coincide con quella da vetrina vuota. Ed è anche conseguenza delle politiche sociali dell’amministrazione turbo-progressista degli ultimi 15 anni (prima Virginio Merola, poi Matteo Lepore), in prima linea nell’incentivare l’immigrazione con l’imprinting cofferatiano «senza se e senza ma». Con il risultato che, nelle case popolari del centro, buona parte degli abitanti è di origine straniera, spesso di altre religioni. Nel 2021 ne erano stati censiti 7.500. Una società multietnica che non ha alcuna intenzione di integrarsi e va ad aggiungersi a una quota fisiologica di abitanti radical, atei e per nulla interessati al messaggio cristiano. Il resto è turismo mordi e fuggi.
Molte famiglie sono spinte ad abbandonare il centro storico con pochi spazi per l’infanzia (se non al chiuso) dalla mancanza di sicurezza, dalla microcriminalità dilagante, dal degrado determinato dai clandestini, dai raid dei maranza stranieri. E dalle scelte urbanistiche che tendono a escludere - con le Ztl sulle porte - l’osmosi sociale. Un dentro e un fuori sempre più rigido. Una realtà sotto gli occhi di tutti, che ha preso forma con la benedizione del cardinal Zuppi medesimo, fautore principe dell’accoglienza diffusa, nume tutelare di ogni accelerazione woke voluta dal Comune.
L’Osservatorio della Curia aggiunge che «lo spopolamento del cuore della città è dovuto anche alle difficoltà di ingresso nella zona, al degrado (soprattutto nelle zone calde come Montagnola e la parte finale di via Indipendenza) e ai costi dell’affitto e della vita in generale, non compatibile con gli stipendi attuali». Ma al di là delle problematiche urbanistiche c’è qualcosa di più profondo: l’abdicazione della diocesi stessa nel farsi garante dei valori cristiani e della dottrina. E nel difendere i simboli cattolici da chi tenta di annientare don Camillo 70 anni dopo con spirito di rivalsa.
Il silenzio davanti a provocazioni come «il crocifisso è un simbolo medioevale» (Merola), ai tentativi di abolizione del presepe (Lepore), alla laicizzazione strutturale in nome del globalismo sociale, alla demonizzazione dell’identità e della tradizione per non urtare la (molto presunta) suscettibilità islamica hanno provocato ferite profonde nel tessuto religioso. Così, quando Zuppi afferma che «non si tratta di crisi di fede» incrocia le dita. E quando aggiunge che «questi processi vanno governati e non subìti», chiama in causa anche le proprie amnesie.
Ribaltare il paradigma? Forse è tardi. E quei bambini assenti, lasciati più felicemente dai genitori alla dottrina dello smartphone, sono il segnale politico di una sconfitta. Il «catechismo zero» è anche l’effetto più triste del disincanto davanti a sacerdoti che non credono più. Senza contare una piccola dose di ipocrisia, come fa notare con spirito caustico un cittadino bolognese su Facebook. «Strada Maggiore, incrocio Piazzetta dei Servi, palazzo storico di proprietà della Curia: due Bed&breakfast. Da che pulpito. Forse è il caso di cominciare a guardarsi dentro».
Continua a leggereRiduci
Jeffrey Epstein (Getty Images)
E infatti, negli Stati Uniti al suicidio di Jeffrey Epstein si crede sempre meno. Un tema che qui sarebbe un tabù, benché il racconto ufficiale sulla morte del faccendiere lasci dubbi a molti, lì è oggetto di discussione sulle tv nazionali. Ad alimentare il dibattito, oltre alle varie anomalie già raccontate su queste pagine - telecamere non funzionanti, finte salme mostrate ai media, comunicati sul decesso datati prima della morte ufficiale, testimonianze agghiaccianti girate sul Web, compagni di cella spostati due giorni prima - si è aggiunto un altro documento piuttosto bizzarro. Si tratta di una email riservata dal contenuto piuttosto chiaro: «Sono un Ausa (Assistant United States Attorney, assistente procuratore federale Usa, ndr) presso l’Edny (Eastern District of New York, ndr) e sto lavorando a un’indagine sulla morte di un detenuto presso il Brooklyn Mdc (Metropolitan Detention Center di Brooklyn, ndr). L’Ocme (Office of Chief Medical Examiner, cioè l’Ufficio del medico legale capo di New York, ndr) mi ha detto di aver firmato un accordo di riservatezza in relazione all’indagine sull’omicidio di Jeffrey Epstein. Speravamo di estendere un accordo simile e volevo vedere se potessi condividerlo con me». L’email è di giugno 2020, quasi un anno dopo la morte del faccendiere, e si conclude con un numero di cellulare (oscurato) e l’invito a parlarne per telefono.
Proprio così: indagini segrete sull’omicidio di Jeffrey Epstein. Il procuratore federale che a giugno del 2020 stava lavorando su un caso di morte in carcere a Brooklyn voleva «copiare» il modello di accordo di riservatezza usato per Epstein. Eppure, la sua morte è stata subito venduta come un suicidio, fatto confermato dall’autopsia pochi giorni dopo.
E a proposito di indagini, mentre la Procura del New Mexico ne ha avviate di nuove sullo Zorro Ranch, la tenuta di Epstein nel New Mexico, si è scoperto che nel 2019 il lavoro degli inquirenti fu bloccato dall’alto. Una villa di 2.800 metri quadri e perfettamente isolata. Meta di tanti personaggi famosi, luogo in cui tante vittime raccontano di essere state abusate, nonché sede di possibili esperimenti eugenetici. Un’inchiesta statale sulle azioni di Epstein è stata rilevata dai procuratori federali, nel 2019, per poi arenarsi. «Non solo è stata messa in ombra, è stata completamente ignorata», ha detto Eddy Aragon, un noto conduttore radiofonico del New Mexico che da anni fa ricerca sulle attività di Epstein. Proprio a lui era indirizzata la soffiata - presente negli Epstein files - dell’ex dipendente dello Zorro sulle due presunte ragazze morte durante gli abusi e seppellite nel ranch.
Continua a leggereRiduci
«Marshals: A Yellowstone story» (Paramount+)
Un universo inedito, in grado di espandere il nucleo originale fino a dargli una forma imprevista. Improvvisa. Non più un ranch, ma il Montana.
Marshals: A Yellowstone story, disponibile su Paramount+ da lunedì 2 marzo, non ritrova l'interezza di Yellowstone. Solo, quella di Kayce Dutton, deciso a rompere con il proprio passato. Kayce, che nel corso della serie originale è stato detto avere con il padre un rapporto complesso e altalenante, ha scelto, in questo nuovo spin-off, di lasciarsi alle spalle il ranch familiare. Gliel'aveva dato il padre, una volta diventato Governatore del Montana. Doveva servirgli ad assicurare un futuro solido, brillante, al figlio. Sarebbe stato uno fra i più grandi centri di allevamento bestiame degli Stati Uniti. Ma Dutton ha voluto fare altrimenti. Di qui, dunque, la decisione di dedicargli un'intera serie televisiva.
Marshals: A Yellowstone story, con Luke Grimes a riprendere il ruolo svolto in Yellowstone, racconta un presente diverso. Un Kayce Dutton diverso, non più allevatore, ma parte di un'unità d’élite degli U.S. Marshals. Cambia la forma, non, però, la sostanza. Lo show, ad oggi articolato in tredici episodi, continua - come l'originale - a saltare dal western al drama, mescolando i patemi personali di Dutton con la fatica oggettiva del territorio nel quale vive. Le gang locali sono ben organizzate, la gente è dedita al malaffare. La giustizia federale sembra potere nulla contro l'interesse privato dei potenti locali, contro le loro smanie e ambizioni. Dutton, con sé, ha una squadra nuova. Non abbastanza, però, per far sì che possa dormire sonni tranquilli.
Marshals: A Yellowstone story riesce a raccontare (anche) il costo psicologico di certi mestieri, di chi voti la propria vita a un'ideale di giustizia che, spesso, non ha alcun contrappunto nella realtà. Dutton è sotto minaccia costante, il passato che ha provato a lasciarsi alle spalle sembra rincorrerlo e il figlio, Tate, è l'unico punto che vorrebbe tenere fermo.
Continua a leggereRiduci