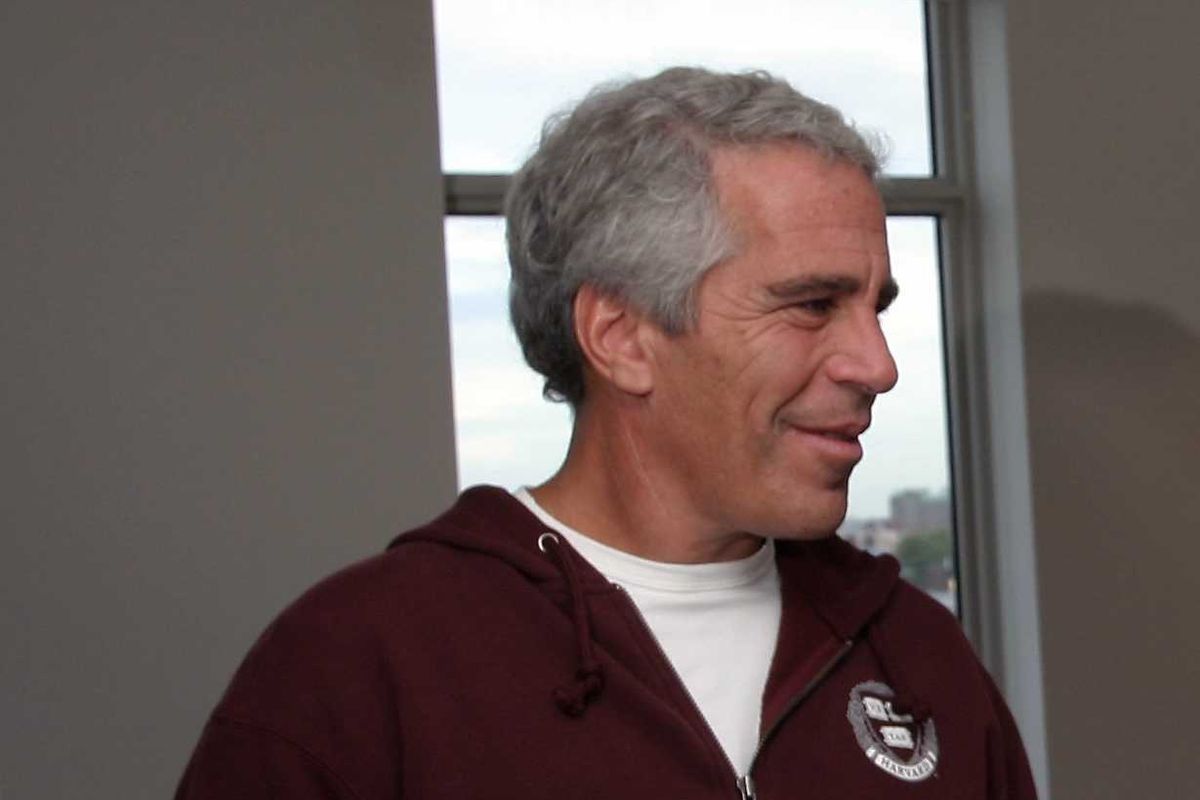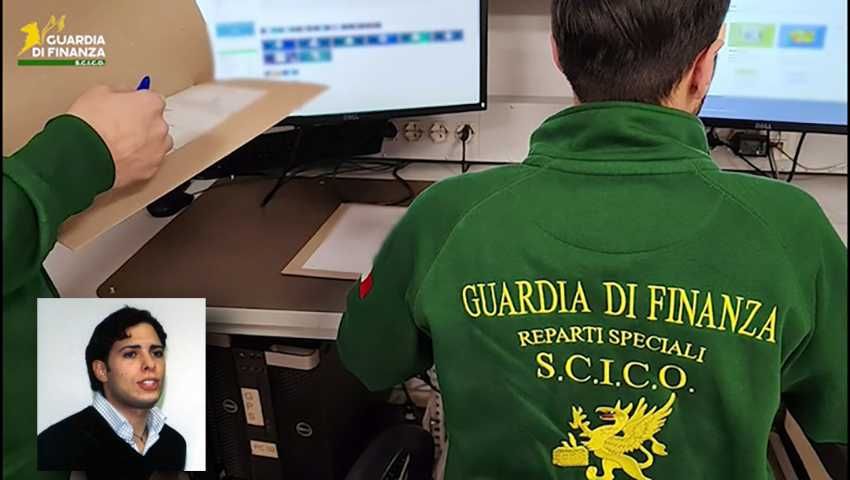2022-07-30
La guerra del luccio tra scaligeri e Gonzaga
È uno dei pesci d’acqua dolce più amati dalla cucina rinascimentale. Ma a Mantova e nel suo territorio c’è una vera idolatria gastronomica per il predatore fluviale dalle carni bianche. Non c’è paese sul Mincio che non proponga la sua salsa abbinata.È uno dei pesci d’acqua dolce più amati dalla cucina rinascimentale. Due ricette nate qualche secolo fa ancora oggi lo apparentano a due illustri signorie padane: nel territorio di Cremona troviamo il luccio alla Farnese, in quello mantovano il luccio alla Gonzaga. In questa stagione non c’è ristorante tra Mantova e il lago di Garda che non abbia nella lista degli antipasti il luccio in salsa. Il piatto piace ai turisti italiani, ma anche ai tedeschi che conoscono bene il luccio, protagonista in molte ricette della loro cucina. C’è un po’ di rivalità tra cuochi scaligeri e gonzagheschi. I primi preparano una salsa più decisa, con olio, capperi, acciughe e un po’ di cannella (anche se non tutti la mettono come vorrebbe la tradizione). I secondi preferiscono l’agrodolce. Ma a Mantova e nel suo territorio c’è una vera idolatria gastronomica per il predatore fluviale dalle carni bianche e sode e dalla bocca a papera, talmente grande che prende quasi tutta la testa. Le ricette a base di luccio si moltiplicano: non c’è paese sul Mincio che non proponga la sua salsa. Che, naturalmente, è migliore di tutte le altre. Seguendo la corrente del fiume che esce dal Garda e va a buttarsi in Po a Governolo, troviamo il luccio in salsa Pozzolo; a Rivalta il luccio in salsa alla rivaltese difeso strenuamente dalla Pro loco; il luccio in salsa di Marmirolo (che vanta la medaglia della Deco, la denominazione comunale). A Grazie, alle porte dei laghi di Mantova, troviamo la regina di tutte le salse di luccio e madre di tutte le altre: la salsa dettata 360 anni fa da Bartolomeo Stefani, cuoco alla corte ducale di Mantova nel 17° secolo. La propone Claudio Somenzi, fedele discepolo del maestro antico, nel ristorante che porta il suo nome. «Io sono di Rivalta», precisa Somenzi, «e ho in menu due salse: quella di Stefani e il luccio alla rivaltese che è col grana padano a scaglie e una grattata di noce moscata abbondante». La ricetta di Stefani, anche dove è stata ritoccata e adattata alla moderna dietetica, è sempre la stessa pubblicata dal capocuoco dei Gonzaga nel libro L’Arte di ben cucinare et instruire i non periti in quella lodevole professione. Nel volume dedicato a Ottavio Gonzaga, principe del «Sacro Romano Imperio», la ricetta è preceduta da un paio di suggerimenti che il cuoco non trascurava mai. «Deve il luccio essere di fiume, overo di lago buono e non paludoso. Fra tutti i pesci questo dà buon nutrimento. Serviti (l’esortativo è rivolto al lettore) con olio, succo di limoni e verdure, nello spiedo lardati con angiove (acciughe), serviti con salsa di capperini, code di gamberi, zuccaro e aceto rosato».Lo «zuccaro» non deve far torcere il naso. Nella cucina rinascimentale non era considerato un dolcificante, ma una spezia che veniva utilizzata su quasi tutti i piatti, soprattutto nelle preparazioni in agrodolce. «Il zucchero non guasta mai menestra», pontificò cent’anni prima dello Stefani un altro Bartolomeo e grandissimo cuoco: lo Scappi, cuciniere di due papi e maestro indiscusso. Ancora oggi lo zucchero entra nella realizzazione del luccio in salsa alla Gonzaga, insieme all’aceto, alle cipolline, al sedano, al peperone e all’acciuga.Stefani non aveva problemi di reperire lucci buoni nel Mincio, nei laghi mantovani e nel Garda dove il luccio, la trota e il carpione sono tra i pochi pesci autoctoni rimasti. Il luccio di queste acque ha carni bianche e sode. A non tutti piace tale consistenza. I vecchi pescatori della sponda veronese del Garda che non hanno mai particolarmente amato il pesce predatore hanno tradotto il loro punto di vista negativo in un ingiustissimo proverbio: Carne de lusso, carne de musso.Secondo Konrad von Gessner, naturalista svizzero del XVI secolo, il luccio è il Matusalemme dei pesci. Racconta lo zoologo in uno dei suoi trattati che alla fine del Quattrocento fu pescato nel lago di Kayserweg un luccio di 267 anni. A stabilirne l’età fu l’anello che portava infilzato in una pinna su cui era scritto in greco «Io sono il pesce che per primo fui messo in questo lago dalle mani del padrone dell’universo, Federico II, il 5 ottobre 1230». La storia è assai suggestiva, ma solleva non pochi interrogativi e dubbi sulla veridicità dell’aneddoto. È vero che non si sa bene quanto può vivere un luccio, ma gli ittiologi moderni fermano il ciclo vitale medio del pescecane d’acqua dolce ad un quarto di secolo. Lucci di 30 anni sono un’eccezione. C’è inoltre da osservare che il lago Kayserweg non esiste, esiste invece un Kaysersee vicino ad Augusta, Germania. Ma è lo stesso lago? Un supplemento della storia di Federico II e del luccio, scritto non si sa da chi, dice che quel «primo pesce» rilasciato dall’imperiale mano del sovrano Stupor Mundi, quando fu preso, pesava 140 chili ed era lungo quasi sei metri. Più che un luccio ricorda il mostro di Loch Ness. La storia raccontata da Gessner viene ripresa da Camillo Pavan, scrittore trevigiano, che la mette in bocca ad un illustre ittiologo, Emilio Ninni, nel libro in cui parla della storia e della vita del Sile, il fiume che attraversa Treviso e le cui acque sono ricche di lucci. O almeno lo erano fino a una cinquantina di anni fa. Pavan informa che la stagione di frega del luccio va da metà febbraio ad aprile e cita un proverbio dei pescatori veneti: Da San Valentin el luzzo move el coin.Quando nel 1758 toccò al luccio essere classificato da Carlo Linneo secondo la classificazione binomiale da lui creata, lo scienziato svedese lo chiamò Esox lucius riprendendo il nome, esox, con cui l’aveva chiamato Plinio che Linneo considerava il suo maestro. Peli sulla lingua, il luccio, non ne ha, ma, in compenso, ha centinaia di denti. Sulla lingua, sulla mascella, sul palato. Il luccio ne ha una bocca piena. Tra grossi, piccoli e microscopici ha più di 700 denti a forma di uncino rivolto verso l’esofago. Non c’è scampo per le prede. Una volta addentate possono dimenarsi fin che vogliono, ma la via è a senso unico: verso lo stomaco del predatore. Attenzione, però. Il luccio vive, sì, cacciando prede, ma distingue, seleziona. Non è un devastatore come il siluro che se ne frega dell’ecosistema e divora tutto quello che trova a portata di baffi. Anche il luccio è di bocca buona, ma è un equilibratore delle acque in cui vive, una sorta di guardia fluviale o lacustre: il suo menu consiste in pesci in difficoltà, malati o anche morti. È un controllore della stabilità dell’ecosistema: quando una specie ittica cresce a dismisura minacciandone l’equilibrio dell’ecosistema, ci pensa lui a ristabilire il controllo delle nascite. Come? Pappandosi l’eccedenza. Da buon predatore ha un menu piuttosto vario: rane, uccelletti acquatici, rettili. Se non trova niente di meglio e ha fame, soddisfa l’appetito con qualche... parente. Cannibale? Sì, ma solo in caso di bisogno. Vive tra i canneti e le piante acquatiche dove resta immobile in agguato. Aspetta paziente la preda. Quando la individua scatta verso di essa come un partecipante ad una presentazione culturale, con rinfresco finale, scatta verso la tartina. Jules Renard, romanziere francese, padre di Pel di carota, lo descrive così nel momento dell’agguato: «Immobile all’ombra di un salice, è il pugnale nascosto sul fianco d’un vecchio bandito».Di «pugnale» parla anche una poesia di Gino Benedetti, poeta e scrittore, posta sul lungolago di Desenzano: «Ringhiere di lago... C’è un luccio incantato/ fra le alghe, /nell’acqua specchiata, immobile/ pietrificato. Argenteo/nobile pugnale, /il luccio sogna». Ma il luccio è un pesce che sa farsi voler bene. Ne La guerra di Piero Fabrizio De Andrè lo prende a simbolo della pace: «Lungo le sponde del mio torrente/ voglio che scendano i lucci argentati/ Non più i cadaveri dei soldati/ portati in braccio dalla corrente».
Jeffrey Epstein (Getty Images)
Nel riquadro, Giancarlo Tulliani in una foto d'archivio
A Fontanellato il gruppo Casalasco inaugura l’Innovation Center, polo dedicato a ricerca e sostenibilità nella filiera del pomodoro. Presenti il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, l’amministratore delegato di FSI Maurizio Tamagnini e il presidente della Tech Europe Foundation Ferruccio Resta. L’hub sarà alimentato da un futuro parco agri-voltaico sviluppato con l’Università Cattolica.
Casalasco, gruppo leader nella filiera integrata del pomodoro, ha inaugurato oggi a Fontanellato il nuovo Innovation Center, un polo dedicato alla ricerca e allo sviluppo nel settore agroalimentare. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la competitività del Made in Italy e promuovere un modello di crescita basato su innovazione, sostenibilità e radicamento nel territorio.
All'evento hanno partecipato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, l’amministratore delegato di FSI Maurizio Tamagnini, il presidente della Tech Europe Foundation Ferruccio Resta e il management del gruppo. Una presenza istituzionale che sottolinea il valore strategico del progetto.
Urso ha definito il nuovo centro «un passaggio fondamentale» e un esempio di collaborazione tra imprese, ricerca e istituzioni. Per Marco Sartori, presidente di Casalasco Spa e del Consorzio Casalasco del Pomodoro, l’hub «non è un punto d’arrivo ma un nuovo inizio», pensato per ospitare idee, sperimentazioni e collaborazioni capaci di rafforzare la filiera.
L’amministratore delegato Costantino Vaia parla di «motore strategico» per il gruppo: uno spazio dove tradizione e ricerca interagiscono per sviluppare nuovi prodotti, migliorare i processi e ridurre l’impatto ambientale. Tamagnini, alla guida di FSI – investitore del gruppo – ricorda che il progetto si inserisce in un percorso di raddoppio dimensionale e punta su prodotti italiani «di qualità valorizzabili all’estero» e su una filiera sostenibile del pomodoro e del basilico.
Progettato dallo studio Gazza Massera Architetti, il nuovo edificio richiama le cascine padane e combina materiali tradizionali e tecnologie moderne. I mille metri quadrati interni ospitano un laboratorio con cucina sperimentale, sala degustazione, auditorium e spazi di lavoro concepiti per favorire collaborazione e benessere. L’architetto Daniela Gazza lo definisce «un’architettura generativa» in linea con i criteri di riuso e Near Zero Energy Building.
Tra gli elementi distintivi anche l’Archivio Sensoriale, uno spazio immersivo dedicato alla storia e ai valori dell’azienda, curato da Studio Vesperini Della Noce Designers e da Moma Comunicazione. L’arte entra nel progetto con il grande murale di Marianna Tomaselli, che racconta visivamente l’identità del gruppo ed è accompagnato da un’esperienza multimediale.
All’esterno, il centro è inserito in un parco ispirato all’hortus conclusus, con orti di piante autoctone, una serra e aree pensate per la socialità e il benessere, a simboleggiare la strategia di sostenibilità del gruppo.
Casalasco guarda già ai prossimi sviluppi: accanto all’edificio sorgerà un parco agri-voltaico realizzato con l’Università Cattolica di Piacenza, che unirà coltivazioni e produzione di energia rinnovabile. L’impianto alimenterà lo stesso Innovation Center, chiudendo un ciclo virtuoso tra agricoltura e innovazione tecnologica.
Continua a leggereRiduci
Da sinistra in alto: Piero Amara, Catiuscia Marini, Sergio Sottani e Luca Palamara (Ansa)