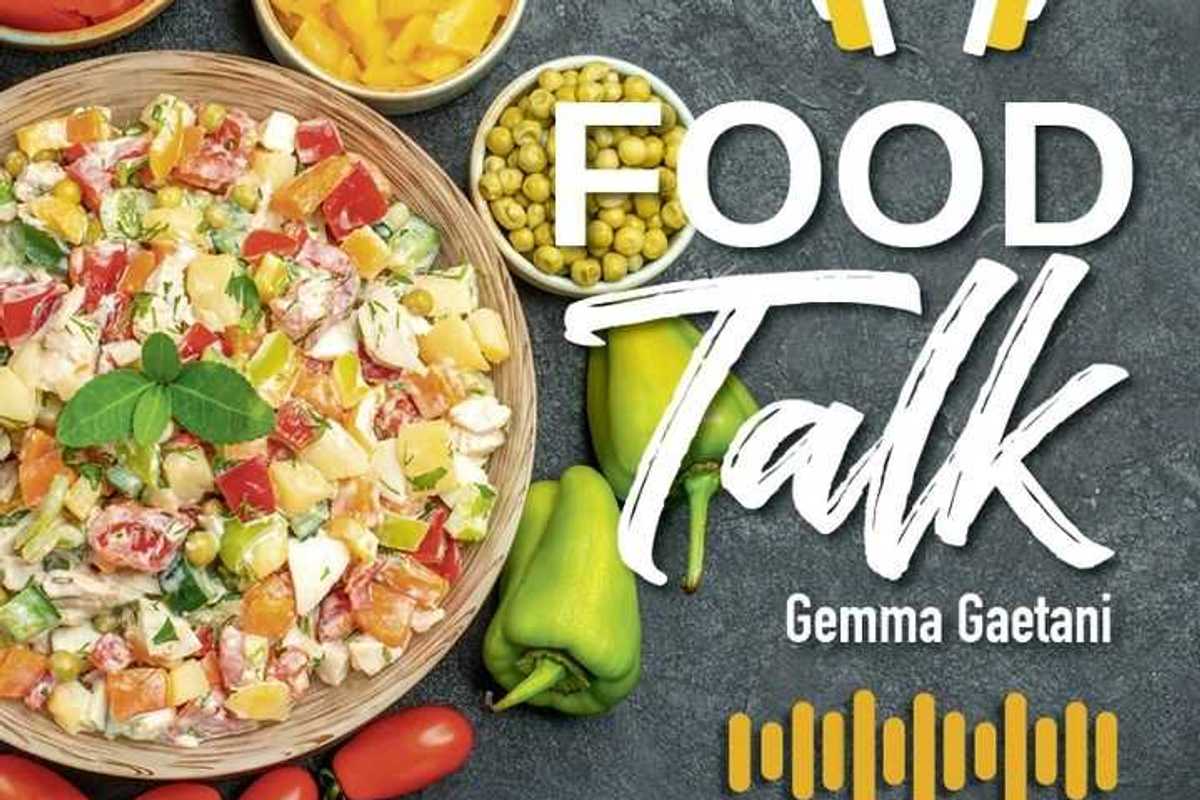È in tour, senza tregua, dal lontano 1975. E per questo nel giro del jazz lo chiamano «road dog». Inutile fare il conto dei chilometri percorsi o delle ore passate negli aeroporti di tutto il mondo. «Se suoni sempre nella stessa città, la gente si annoia», è il credo di John Scofield. Disarmante come la sua discografia: il chitarrista, nato a Dayton (Ohio) 72 anni fa, sforna infatti un album all’anno dal 1977. Genio e regolarità. Due oggetti preziosi che ha sempre tenuto nel bagaglio a mano per non perdere i treni che gli passavano davanti.
Il grande viaggio ha inizio quando la sua famiglia si trasferisce a Wilton, in Connecticut, e il giovane John, aspirante musicista, si ritrova a una fermata dal Paese delle meraviglie: basta un’ora infatti per raggiungere la New York anni Sessanta, dove si può ascoltare il blues di B.B. King e di Muddy Waters, le ballate dell’esordiente Bob Dylan al Gaslight e il jazz di John Coltrane e Bill Evans al Village Vanguard. Scofield assorbe tutto e si trasferisce a inizio anni Settanta al Berklee college di Boston, scalo obbligato per molti dei jazzisti che poi faranno strada. Il sassofonista Gerry Mulligan cerca un chitarrista per la sua band? Lui sale a bordo e dopo una settimana si ritrova sul palco della Carnegie Hall a dialogare con la tromba di Chet Baker. John Abercrombie lascia un posto libero nel gruppo di Billy Cobham? In prima fila c’è sempre Scofield, che poi rimedia un invito a suonare in un disco di Charles Mingus («Quattro o cinque ore in studio e non ci siamo nemmeno rivolti la parola»). Ma è solo la preparazione al decollo. Nel 1980, in un locale di Manhattan chiamato Seventh Avenue South, il nostro sta duettando con Dave Liebman, quando tra il pubblico si materializza Miles Davis. «Quindi è vero che sapete suonare». «Grazie Miles, ci tenevo a dirti che sono un tuo grande fan». «Chiudi quella c… di bocca!». Colloquio superato con il Principe delle tenebre e carriera che spicca definitivamente il volo.
Quarant’anni dopo John Scofield non ha ancora disfatto le valigie. L’ultima creazione per Ecm è un doppio album intitolato Uncle John’s Band. E domani sera sarà ospite dell’edizione numero 45 del Bergamo Jazz Festival (da oggi al 24 marzo), diretto per la prima volta dall’amico di una vita: il sassofonista di Cleveland, dalle radici siciliane, Joe Lovano.
Il nome del disco l’ha preso in prestito da una canzone dei Grateful Dead, che non sembra scritta per improvvisarci sopra. E lo stesso si potrebbe dire di Mr. Tambourine man del menestrello Dylan o di Old man di Neil Young, che si trovano in questo suo nuovo lavoro con i fedelissimi Vicente Archer al contrabbasso e Bill Stewart alla batteria. È un ritorno ai suoi primi giorni a New York e alla passione per il rock, che ha anticipato quella per il jazz?
«Direi di sì, da ragazzo ho mosso i primi passi nella musica che mi circondava. Ed era un grande momento per ascoltare artisti fantastici di ogni genere. Ammiravo il rock di Jimi Hendrix e di Jeff Beck e allo stesso tempo andavo matto per il blues di B.B. King, di cui mi colpiva il suono così vocale. Ma anche il bluegrass era interessante, persino il flamenco... Chissà, forse sono arrivato al jazz perché in fatto di rock e blues Hendrix era micidiale: meglio dedicarsi ad altro» (ride).
Il suo approccio è lo stesso quando improvvisa su un suo brano, su Miles Davis o Leonard Bernstein oppure su una canzone rock, come fa nel disco?
«È sostanzialmente identico, mi diverto a smontare e rimontare qualunque tipo di composizione. L’importante è scegliere le canzoni che si amano. Dopodiché bisogna trovare una strada per dilatarle, farle diventare qualcos’altro in modo da poter improvvisare e spiccare il volo. È ciò che il jazz mi ha insegnato a fare (basti pensare a Miles Davis, Gary Burton e Keith Jarrett), anche se non funziona sempre. Ci sono brani rock che adoro ma che non ti permettono di decollare. Con i Grateful Dead invece è andata bene: abbiamo iniziato a lavorare su Uncle John’s Band e il risultato ci ha convinto. Dopodiché La band dello zio John non poteva che diventare il titolo del disco. Quando mi ricapita?» (ride).
Per molti il suo marchio di fabbrica è proprio questo mix personale di jazz, reminescenze blues e spirito rock. È ciò che la rende unico secondo lei?
«Le confesso che fatico a sentirmi unico, in generale. Ho così tanti amici che hanno percorso la stessa strada - che alcuni chiamano fusion - ognuno con il suo stile. Di sicuro ho messo insieme queste influenze in un modo tutto mio. Forse è il suono della mia chitarra che è rimasto blues. L’evoluzione comunque continua, ci vuole una vita per domare il leone».
Cosa intende dire?
«La prima volta che colleghi la chitarra all’amplificatore senti un ruggito, di cui non hai il controllo. Poi pian piano prendi le redini e capisci che, al di là di tutti gli effetti e le diavolerie che puoi aggiungere, sta tutto nel modo in cui le tue dita trattano la singola corda. A 72 anni studio ancora ogni giorno ed è il momento più bello della giornata».
Se le chiedessi di scegliere i titoli più importanti della sua sconfinata discografia?
«Il più interessante è sempre l’ultimo, a me piace il presente. Se devo guardarmi indietro, cito gli album che hanno catturato alcuni momenti felici della mia vita. Penso a Blue Matter (1986, ndr), realizzato con alcuni musicisti fantastici che arrivavano dal funk come Dennis Chambers e Gary Grainger. E il pensiero corre a Jim Beard, che faceva parte di quella storia ed è scomparso proprio in queste settimane. Poi Time on my hands (1990, ndr), con Joe Lovano, Jack DeJohnette e Charlie Haden. Infine A Go Go (1997, ndr) con il trio Medeski, Martin & Wood. Forse sono questi quelli fondamentali».
Per quale ragione?
«Il primo perché è uno dei miei primi passi dopo la collaborazione con Miles Davis, che per me è stata decisiva. Il secondo per il rapporto speciale che ho con Joe Lovano, nella musica come nella vita. Il terzo per la qualità delle composizioni».
A proposito di Lovano, che l’ha voluta al Bergamo Jazz Festival 2024: in un disco del 2015, Past Present, il momento più intenso è il vostro dialogo su Mr. Puffy, un ritratto di suo figlio Evan, scomparso prematuramente a 26 anni.
«Lovano non è solo mio amico dai tempi del Berklee e uno dei più grandi musicisti che io abbia mai incontrato. Joe è parte della famiglia. Conosceva mio figlio e il suo coinvolgimento in quel disco è totale, anche negli altri brani dedicati a lui. È stato un dolore immenso, ma Evan è ancora con noi, nei nostri cuori. Come diceva William Faulkner: “Il passato non è mai morto, anzi non è neppure passato”».
C’è un suo ricordo anche in quest’ultimo lavoro. L’omaggio stavolta è Nothing is forever.
«Penso al tempo che ho potuto passare con lui. È stata una fortuna. Voglio bene al mio ragazzo».
Il progetto che porta in scena domani sera è in linea con il suo ultimo lavoro, anche se la band è differente. Ci aspetta un viaggio in chiave jazz nel rock e nel country a stelle e strisce. Certo, il titolo sorprende: «Yankee go home».
«È più uno scherzo che un’affermazione politica. Il momento che il mondo sta vivendo è terribile, ma non voglio avventurarmi in un’analisi. “Yankee go home” mi è venuto in mente perché forse in Europa siete stanchi di noi statunitensi. Oppure potreste essere stufi solo di me: ho suonato così tanto nel Vecchio continente, un luogo in cui mi sento a casa. Ad ogni modo rievocheremo il suono dell’America: dal country a quella che chiamo Black church music - che è all’origine di un sacco di generi - alla magia di New Orleans».
Impossibile non chiederle della sua collaborazione con Miles Davis, che ci ha lasciato tre album: Star People (1983), Decoy (1984) e You’re under arrest (1985). Quanto veniva coinvolto nel processo compositivo?
«Miles non amava comporre i pezzi a tavolino. Preferiva lasciare improvvisare il gruppo, registrare tutto e poi pescare le idee migliori, sviluppandole. Guardava sempre in avanti, cercando nuovi modi per essere creativo. Ricordo che It gets better (brano presente in Star People, ndr) nacque a casa di Gil Evans. Gil mi fece sentire una progressione, una sorta di blues, creò una linea di basso e mi chiese di suonarci sopra. Quegli spunti poi vennero utilizzati».
Nella Storia del jazz di Stefano Zenni, l’intero album Decoy viene attribuito a lei e a Gil Evans, più che a Miles Davis, che però poi ci mise la firma. In What it is credo che si senta chiaramente il suo zampino.
«Se si esclude il brano che dà il nome all’album, che è del tastierista Robert Irving III, tutti gli altri sono nati da un’improvvisazione di gruppo. Difficile poi ricostruire…» (ride).
Non che Davis fosse molto attento a dare gloria ai suoi colleghi.
«Certo, era troppo furbo. Sapeva che la musica è un’esperienza collettiva e che poteva prendersi tutti i meriti. Tanto noi lo idealizzavamo».
Girano molte leggende sul suo carattere. Poteva essere molto duro?
«Duro? Era in grado di farti a pezzi con i suoi insulti, sapeva essere molto cattivo. Poi però, quando si accorgeva di avere esagerato, ti diceva: “Hey man, ieri sera mi hai ricordato Bird (Charlie Parker, ndr)”. Tu ti sentivi in Paradiso e perdonavi tutto. Con il tempo comunque uno impara a difendersi».
Cioè?
«Sul palco mi sussurrava continuamente delle cose all’orecchio, ma il volume della band era troppo alto per sentirlo. Gli ho sempre detto di sì, senza capire una parola. Questi comunque sono solo particolari di una personalità complessa. Il bello era suonare con lui, sentire quel suono, il suo senso del ritmo, le note che sceglieva, chiedergli come vedeva la musica del futuro. È quella la parte indimenticabile, che mi ha cambiato la vita».