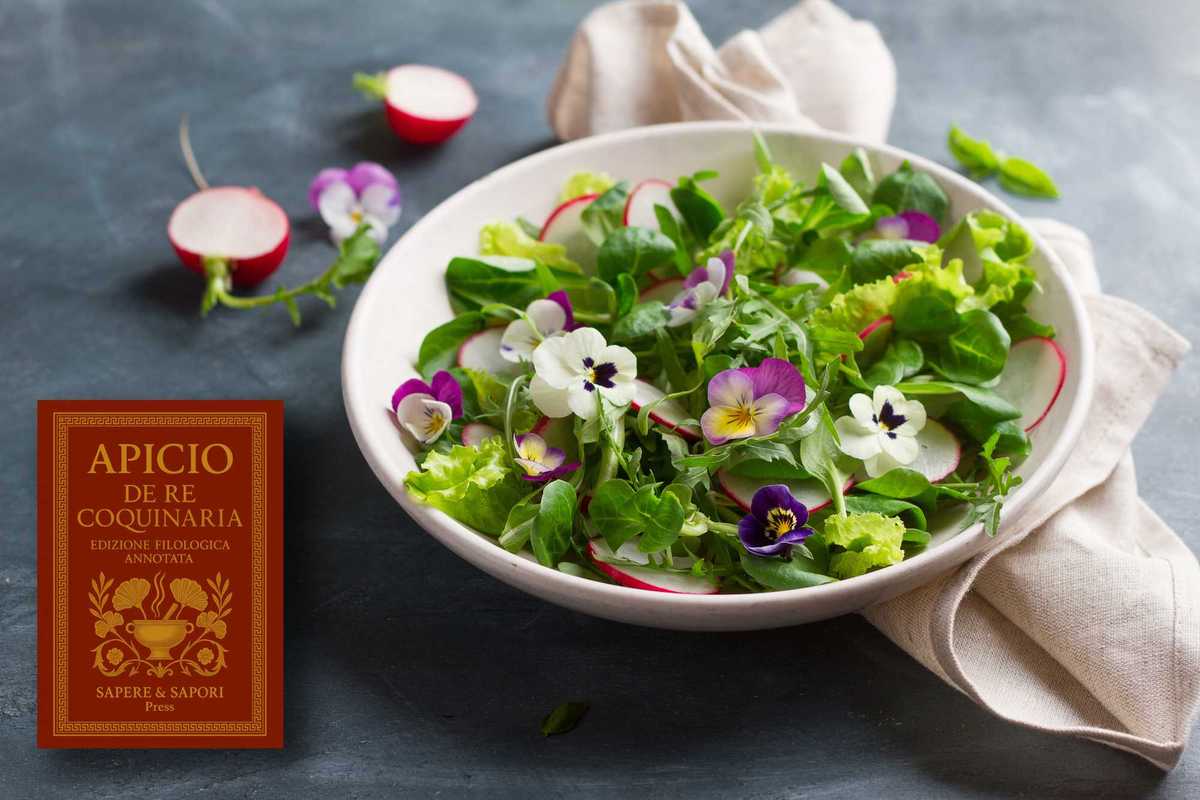Il genio di Péguy «contro» la scienza quando questa si dimentica la realtà

A capire forse più di ogni altro l'essenza della modernità è stato un uomo che la detestava ferocemente. Uno scrittore furente che arrotolava le frasi sulla pagina come se volesse usarle per strozzare qualche miope contemporaneo. Eppure, nonostante tutta la collera, Charles Péguy il «mondo moderno» lo ha compreso fin nel midollo, ne è stato uno dei più efficaci interpreti, e le sue parole ancora oggi risuonano cariche di verità. Questa - come ha scritto Antoine Compagnon in un bel saggio uscito qualche tempo fa per Neri Pozza - è la croce degli «antimoderni»: interpretare meglio di tutti una realtà a cui si oppongono strenuamente.
«Della Società moderna si vuole fare un nuovo Dio», sentenzia Péguy in Pour la rentrée. E in Zangwill, del 1904, dettaglia: «Esaurire l'immensità, l'indefinitezza, l'infinità del dettaglio per raggiungere la conoscenza della totalità del reale […]. Solo un Dio ci riuscirebbe. […] Tale è proprio l'ambizione inaudita del mondo moderno. […] Dio cacciato dalla storia, e per una singolare ironia, e per un nuovo ritorno, Dio che si ritrova nello storico sapiente». Ecco l'arroganza dei moderni: pensano di farsi dèi aumentando a dismisura le proprie conoscenze. Vogliono dominare la realtà, ma la verità e che dal reale riescono solo, irrimediabilmente, a distaccarsi. Come nota Compagnon, per Péguy il vero progresso dell'umanità consisterebbe nel far sbiadire il più possibile le tracce del peccato originale (sarebbe dunque un'evoluzione spirituale). E invece la modernità è divenuta l'ambiente di «chi fa il furbo». Cioè, scrive Compagnon, il luogo in cui trionfano «i presuntuosi e i malvagi, gli ambiziosi e i cattivi». È il mondo del commercio totale, in cui tutto è in vendita, in cui comanda il denaro distruttore: «Il libretto di risparmio fa il moderno», inorridisce Péguy.
Il risultato a cui giunge questa modernità che ha pensato di cacciare Dio (ma che da Dio è, semplicemente e tristemente, più «imbarazzata» che mai) è un generale svilimento: «Il mondo moderno svilisce. Svilisce la città, svilisce l'uomo. Svilisce l'amore, svilisce la donna. Svilisce la razza; svilisce il bambino. Svilisce la nazione; svilisce la famiglia. […] Svilisce la morte». Alzate lo sguardo, osservate ciò che vedete attorno a voi, e provate a sostenere che non sia vero.
È proprio la rovente verità delle parole di Péguy ad averlo reso indigesto ai più. Fu attaccato da Julien Benda - che pure gli era stato vicino - nel celeberrimo saggio Il tradimento dei chierici (1927). Quel nano intellettuale di Bernard-Henry Levy, molti anni dopo, lo accusò di essere il creatore del «nazionalsocialismo alla francese». Anche per via di simili e ingiusti attacchi lo scrittore francese è estremamente sottovalutato, spesso dimenticato. In Italia sono usciti, negli anni, pochi testi, e sparsi. Fortuna che ora uno splendido volume edito da Cantagalli e ben curato da Pigi Colognesi rimedia in parte al disastro. Il fazzoletto di Véronique (questo il titolo) è una robusta «antologia della prosa» dell'igneo Charles. Ne traduce testi sconosciuti al pubblico italico, e in quasi 600 pagine ne fornisce un indispensabile compendio.
I brani che più colpiscono, in ogni caso, sono appunto quelli in cui Péguy svela la propria essenza e quella del moderno. I brani in cui egli ci mostra la incancellabile colpa dei contemporanei: aver dimenticato la realtà. Peggio: pensare di poterla piegare ai pochi scopi. E in effetti il piegarsi è una caratteristica di questo nostro mondo. Si piega, per prima cosa, la materia che ci circonda. «Durante i secoli», scrive Péguy, «l'umanità, tutte le umanità, tutte le particolari umanità, insieme o separatamente, tutta l'intera umanità totale ha lavorato una materia che non solo resisteva, ma che comandava, che esigeva rispetto […]. Ai giorni nostri un'umanità moderna è libera. È libera di lavorare una materia moderna relativamente facile, intercambiabile, prostituzionale, che può servire a tutto e a tutti, una materia puttana». Alain Finkielkraut, commentando questo passaggio (nello splendido saggio L'incontemporaneo. Péguy, lettore del mondo moderno, Lindau), lo riferisce al ferro, «ovvero il trionfo della volontà: laddove l'uomo componeva, ora dispone e impone; dove rispondeva, ordina; dove socializzava, fa soliloqui; dove recepiva, concepisce, calcola, pianifica e programma; dove dipendeva, regna. Il corrispettivo della sua attività non è più la natura, o la realtà così come si concede, ma l'operabilità e la plasticità senza limiti di una materia senza dignità; non è più l'essere in quanto altro, ma l'essere come prolungamento dell'uomo, l'essere come servizio, l'essere liberato da ogni trascendenza e da ogni esteriorità». Di nuovo, fate l'esercizio di realtà che a Péguy sarebbe piaciuto: guardatevi intorno. Noi stessi siamo divenuti materia malleabile, pieghevole. Al cospetto del nuovo totalitarismo, per quel che riguarda il pensiero. Ma siamo anche fisicamente piegati da uno stile di vita mortifero. Chiusi in casa, sepolti nei nostri uffici, lontani dalla terra, teniamo la testa bassa e la schiena china.
La realtà non ci appare più come una «rivelazione», ma come qualcosa che possiamo manipolare. Tutto è calcolabile, tutto è «scientifico». Scrive Finkielkraut: «L'uomo pensa la verità come una sua opera. […] Egli non cerca più di formare una ragione a immagine del mondo, ma di costruire un mondo a immagine della ragione». Quasi come «se il misurabile e il calcolabile coincidessero con la realtà».
Moderno, dice Péguy, significa libero. Ma libero dal reale, non dall'autorità. Dunque, questa libertà è sostanzialmente una finzione. La tecnica moderna è «insolente» nei confronti della realtà. La natura non è più accolta o ascoltata. Come il ferro, essa è costretta a rispondere alle esigenze dell'uomo, a modellarsi. La verità della scienza diventa la sola verità del reale. Nota Pigi Colognesi: «Un esito della modernità è pensare che non esista più nemmeno il dato materiale, ma che tutto sia malleabile, trasformabile a piacimento, riutilizzabile». Manipolabile il corpo, manipolabile la natura, sostituibile Dio. Le forze arimaniche della modernità avanzano, la scienza - tramite intellettuali che si credono sacerdoti - improvvisa una «sua verità» che, quando non riesce a domare la realtà, semplicemente la rifiuta.
Ecco la tracotanza della modernità, l'era in cui l'uomo «ha stabilito che il reale aveva torto perché non si poteva scendere a patti con esso».