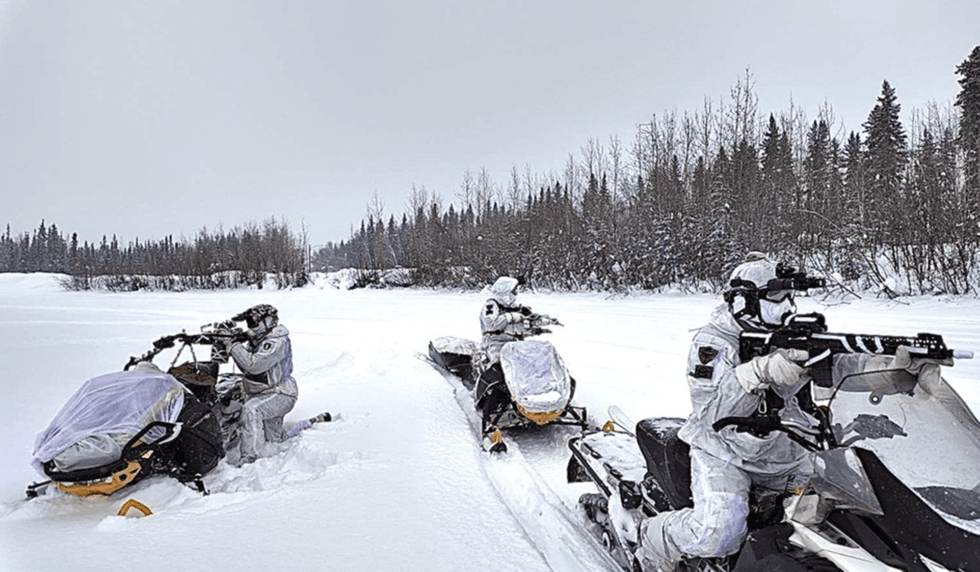- Il filosofo insultato a margine del corteo dei gilet gialli da un islamista aveva parlato nei suoi libri dei pericoli dell'accoglienza. Per capire come siamo arrivati a questo punto, bisogna leggere lui e Pim Fortuyn. Per sapere perché, invece, resta sempre Oriana Fallaci.
- Alain Finkielkraut rifiuta le illazioni sul «clima d'odio sovranista»: «Chi mi ha attaccato rivendicava la sostituzione di popolo».
Lo speciale contiene due articoli.
Il filosofo francese Alain Finkielkraut è stato aggredito a Parigi da alcuni gilet gialli, al grido di «sionista merda» e «Palestina». Alain Finkielkraut è ebreo e l'antisemitismo in Europa, accuratamente camuffato da antisionismo, sta raggiungendo livelli mostruosi. Finkielkraut afferma in tv che uno degli aggressori era verosimilmente un islamico. La frase «Dio ti punirà» è una frase da islamico, mentre gli altri slogan sono propri dell'antisemitismo europeo camuffato da antisionismo.
Se vogliamo capire cosa sta succedendo è utile leggere il libro di Alain Finkielkraut L'identità infelice, che descrive una Francia invasa, sempre più antisemita e anticristiana, sempre più violenta e invivibile. L'integrazione non ha funzionato. Le terze generazioni sono sempre più insofferenti a un sistema che non amano, che fondamentalmente disprezzano e al quale, quindi non desiderano uniformarsi. Certo, non tutte le persone di origine islamica sono assolutamente contrarie a qualsiasi tipo di integrazione con la popolazione autoctona. È sufficiente che il 20% sia assolutamente contrario a qualsiasi integrazione e a qualsiasi equilibrio, perché la vita dei cosiddetti autoctoni diventi un inferno.
È sufficiente avere un unico ragazzo su una classe che afferma che lui non prende ordini dai bianchi e dagli infedeli, e ovviamente dalle donne, perché la vita di un professore e di una professoressa diventino un incubo. È sufficiente che tre coinquilini su venti siano aggressivi e violenti perché la vita dell'unico anziano rimasto in un caseggiato ormai interamente arabo diventi un incubo. Il libro L'identità infelice è quindi un libro di cui raccomando la lettura, per avere un'idea di cosa succede in Francia, di come l'integrazione non sia una questione di generazioni e di buona volontà. L'Islam non può integrarsi. Inoltre, nessuno desidera fare lo sforzo enorme che è l'integrazione se deve integrarsi con una società che disprezza, che ammira da un punto di vista tecnologico, di cui invidia la ricchezza, ma che fondamentalmente disprezza. Quello su cui il libro è terribilmente deficitario, invece, è la causa: spiegare perché, come siamo arrivati a tutto questo.
Da questo punto di vista il libro del filosofo francese somiglia molto ai libri di Pim Fortuyn, il politico olandese assassinato 16 anni fa. I suoi titoli La società orfana e Contro l'islamizzazione della nostra cultura sono distribuiti dall'associazione Carlo Cattaneo di Pordenone, e sono libri imperdibili per chi vuole cercare di capire come è avvenuto il nostro suicidio, sono molto lucidi sul cosa sta succedendo, e questo è meritevole perché non sono molti i testi altrettanto lucidi. Entrambi i libri però non spiegano perché è successo, esattamente come non lo spiega L'identità infelice. Sia il filosofo francese che l'uomo politico olandese sono due ex sessantottini: entrambi ricordano con dolce nostalgia quel meraviglioso periodo in cui sembrava che le libertà sbocciassero l'una dopo l'altra e fiorire sul patriarcalismo cristiano, un sistema rigido e granitico che finalmente si riempiva di margherite. Entrambi gli autori si chiedono come sia stato possibile partire da una spumeggiante meraviglia e approdare alle periferie in fiamme. La risposta è che è stato proprio il '68 la causa di tutto. Il disastro è stato proprio quello stesso '68 per cui sia il filosofo francese sia il bravo politico olandese hanno gioito. La società patriarcale cristiana aveva suoi indubbi difetti e aveva enormi possibilità di essere migliorata, ma era una società viva e vitale e, soprattutto, affascinante. Era in grado di interagire con l'islam, era in grado di affascinarne i figli al punto tale che loro desideravano integrarsi esattamente come è successo negli anni Cinquanta e Sessanta.
Il 1968 è stato la distruzione del padre. Il 1968 è stata distruzione del rito condiviso, civile e religioso, quindi del senso di affiliazione al gruppo. Ogni ruolo maschile, inclusa la difesa del territorio da parte del soldato e la difesa del quartiere da parte del poliziotto, è visto con disprezzo e stigmatizzato con l'eterno appellativo «fascista». La società diventa carina, multiculturale, postcristiana, vegetariana e gay friendly. Palate di diritti umani dall'aborto alla contraccezione passando dal divorzio frantumano il senso della famiglia e abbattono la natalità. Postcristiani, liberi e osceni siamo diventati una società non vitale e soprattutto non affascinante. I giovani islamici ci disprezzano: ogni integrazione è impossibile. Il 1968 è stato distruzione di ogni gerarchia, anche delle più ovvie e irrinunciabili. Una volta attaccata la famiglia, il divorzio e la contraccezione hanno ridotto la nostra sessualità a puro e sterile erotismo, sempre più spinto e sguaiato, ci hanno reso un'umanità di gente sola, disperata, inacidita, senza radici. L'unico valore non negoziabile della nuova Chiesa 2.0 è l'ingresso di una popolazione estranea che non ci ama, e il mito che con la buona volontà tutto si risolverà.
Perché? La risposta l'ha intuita Oriana Fallaci. L'islam si ferma solo per via religiosa, non per via laica. L'occidente cristiano ha fermato l'islam per secoli, l'occidente postcristiano e quindi laico non ha nessuna possibilità. La via laica è stupida. Pensare di fermare un sistema forte con un sistema debole è stupido. Pensare di convertire gli islamici alla laicità è stupido, mentre convertirli al cristianesimo è estremamente facile oltre che logico. La via laica ci porta al disastro: se ancora avete dei dubbi leggete i libri del filosofo francese e dell'uomo politico olandese.
Dallo scontro con l'islam possiamo uscirne vittoriosi solo per via religiosa. Prima convertiamo noi stessi e poi convertiamo loro. E non sarà certo la nuova Chiesa 2.0 a poterlo fare, quindi dobbiamo essere noi laici ad andare avanti, in attesa di una chiesa migliore.
«Il fascismo non c’entra». Così lo scrittore spiazza i commentatori
«Non siamo di fronte al grande ritorno degli anni Trenta». A smontare l'allarme per il fascismo montante, dopo l'aggressione verbale al filosofo Alain Finkielkraut, ci ha pensato… Alain Finkielkraut, che a una perplessa giornalista di Bfm Tv ha spiegato come gli insulti piovuti su di lui a margine della manifestazione dei gilet gialli derivino direttamente dal «discorso dell'islamismo più estremista». E infatti, da quel che si è appreso, il più esagitato del gruppetto era conosciuto dalle forze dell'ordine proprio per la sua adesione all'islam radicale. Ferma restando la necessità, per i gilet gialli, di un servizio d'ordine che li tuteli da tali infiltrazioni, resta comunque un bel cortocircuito, almeno per il commentatore unico dalle spiegazioni facili. Ma non è tutto, perché Finkielkraut ha continuato: «Il barbuto mi ha detto: “La Francia è nostra". Questa frase terribile significa: noi siamo la grande sostituzione e tu sarai il primo a pagare». Per poi aggiungere: «Chi mi ha difeso dagli attacchi? Marine Le Pen».
Insomma, mentre gli editorialisti di mezza Europa corrono per accollare l'aggressione al clima sovranista, la vittima ne dà invece un'interpretazione eminentemente sovranista. Finkielkraut è del resto un pensatore complesso, difficilmente riciclabile in termini di anti populismo militante. Lo scorso novembre, per esempio, in una trasmissione tv definiva i gilet gialli come «i lasciati indietro dalla nuova economia, i dimenticati dalla sociologia e anche gli indesiderati di ogni progressismo, il progressismo di sinistra, ma anche il progressismo macroniano». E ai primi di dicembre, pur prendendo le distanze dalle violenze del movimento, spiegava a Le Figaro che si trattava di una rivolta delle classi medie vittime «di un doppio stato di insicurezza economica e di insicurezza culturale». Ovvero di «persone ordinarie cacciate dalle metropoli dagli affitti proibiti e dalle banlieue perché hanno perduto quella che Christophe Guilluy chiama “la guerra degli sguardi"», ovvero coloro che abbassano lo sguardo per strada nei quartieri a forte presenza immigrata.
Maoista in gioventù, poi allontanatosi dall'estrema sinistra per il suo sostegno a Israele, Finkielkraut non è nuovo a posizioni controverse. Si tratta, per esempio, di un iscritto alla Licra, potente organizzazione antirazzista francese almeno dal 1985, che tuttavia ha definito l'antirazzismo «il comunismo del XXI secolo», e non certo in senso elogiativo.
Qualche tempo fa, allo sbigottito intervistatore del Corriere della Sera, confessava: «Quando l'ideologia dominante nel mondo intellettuale era il comunismo, potevi dirti anticomunista. La pagavi cara, certo, come l'ha pagata cara Albert Camus, ma era possibile. [...] Ma di fronte all'antirazzismo, io sono disarmato». Nel 2005, in un'intervista al quotidiano israeliano Haaretz, stigmatizzò le violenze nelle banlieue, spiegando che «in Francia ci sono altri immigrati la cui situazione è difficile - cinesi, vietnamiti, portoghesi - ma loro non prendono parte ai tafferugli. E questo perché è chiaro che tali rivolte hanno un carattere etnico e religioso». Il Mrap, un'altra Ong antirazzista, fu a un passo dal denunciarlo, mentre il giornale comunista L'Humanité scrisse: «Finkielkraut s'inabissa in una diatriba razzista». Non a caso, nel 2002 Daniel Lindenberg lo aveva inserito in un suo libro sui «nuovi reazionari».
Jacques Bolo, nel suo saggio critico intitolato La pensée Finkielkraut, così giudicava le tesi dello scrittore: «È l'etnocentrismo ipocrita dei razzisti istruiti che accusano neri e arabi di razzismo anti bianco per giustificare il proprio razzismo invece di condannare il razzismo in generale».
In uno dei suoi ultimi libri, L'identità infelice, Finkielkraut scrive che se esistono i demoni dell'identità, oggi «esistono anche i demoni dell'universale», cioè l'oicofobia, secondo il neologismo di Roger Scruton ripreso da Finkielkraut, ovvero l'odio del Paese natio. E, riassumendo le tesi degli immigrazionisti, scrive: «La Francia, l'Europa, l'Occidente hanno molto peccato nel voler piegare l'Altro alla ragione: ci viene offerta l'occasione di essere purificati da noi stessi (e dalle nostre colpe passate) a opera dell'Altro». Se è il «clima sovranista» ad aver generato l'attacco contro di lui, allora tanto vale dire che Finkielkraut si è attaccato da solo.