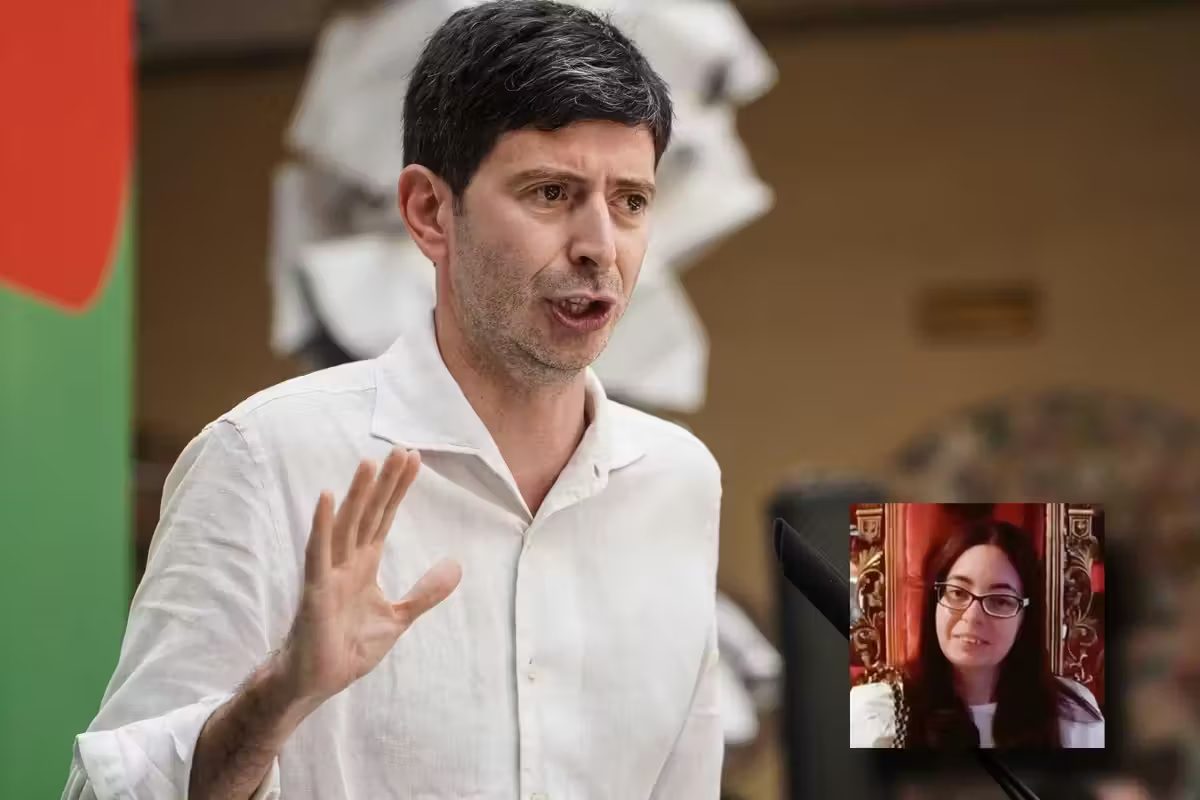Una legge «italiana» su tre non è davvero italiana. Lo dice un recente report del dipartimento Affari comunitari per Il Sole 24Ore, relativo alla produzione normativa del Parlamento e del governo nel quinquennio 2014-2018, che ci consente di fare il punto della situazione su un aspetto cruciale per le stesse sorti della democrazia. Nell'ultimo lustro i nostri politici hanno legiferato parecchio. Per la precisione, sono state emanate 319 leggi e 299 decreti legislativi. Tra legge e decreto legislativo non c'è alcuna differenza sul piano della gerarchia delle fonti. Hanno entrambi la stessa forza cogente e pari livello di «importanza». Solo che le leggi scaturiscono direttamente dal Parlamento mentre i decreti legislativi sono di competenza del potere esecutivo, cioè del governo, su delega del Parlamento stesso. Quindi, possiamo a buon diritto mettere tutto nello stesso calderone e otteniamo un totale di 618 provvedimenti normativi appartenenti al rango della legislazione «ordinaria». Di questi, ben 187 sono di matrice europea. Per la precisione, 10 leggi e 177 decreti legislativi. A questo punto, fare la proporzione è un gioco da ragazzi. Oltre il 30 per cento delle leggi introdotte in Italia dal 2014 in poi, e a cui noi dobbiamo civile obbedienza, è stato deciso altrove. «E 'l modo ancor m'offende», aggiungerebbe Dante Alighieri.
Infatti, ciò che dovrebbe indignare il nostro amor patrio è proprio la «procedura» attraverso la quale la Camera e il Senato della Repubblica sono tenuti ad adeguarsi ai diktat delle centrali di comando della Ue. La legge numero 234 del 2012 ha, infatti, introdotto due strumenti: la «legge europea» e la «legge di delegazione europea». La prima serve a mettere in riga il Paese rispetto ai desiderata dell'Unione: modifica o abroga le leggi italiane bocciate o stigmatizzate da sentenze della Corte di giustizia dell'Ue o messe nel mirino dalla Commissione attraverso le procedure di infrazione. Con la seconda, invece, Montecitorio e Palazzo Madama - ridotti a zelanti esecutori di voleri altrui - conferiscono le dovute deleghe al governo per recepire, tramite decreti legislativi, le nuove direttive Ue.
Ecco spiegato perché, nel periodo 2014-18, tra i provvedimenti normativi di origine europea solo dieci sono leggi vere e proprie (e cioè - il calcolo è presto fatto - ogni anno una legge di delegazione europea e una legge europea) mentre ben 177 sono decreti legislativi. Ma ciò che sorprende ancor più sono la tempistica e le sanzioni. Innanzitutto, ci dobbiamo assoggettare a cadenze prestabilite e senza possibilità di sgarro. Il disegno di legge di delegazione europea deve essere presentato in Parlamento dal governo, cascasse il mondo, entro il 28 febbraio di ogni anno. Salva la possibilità di fare il bis entro il 31 luglio laddove ce ne fosse bisogno. Non solo: tale legge deve attribuire al Consiglio dei ministri il compito di adottare severe sanzioni penali e amministrative per chi viola i sacri precetti comunitari. E così l'Italia, notoriamente lenta nel partorire riforme (figurarsi nel farle rispettare), ingrana la quinta quando di mezzo c'è l'Europa.
Se ora state pensando che per fortuna c'è il Parlamento europeo dove manderemo, a breve, i nostri eletti, avete sbagliato i conti. Infatti, tale organo è probabilmente l'unico parlamento al mondo privo del diritto di iniziativa legislativa. In altre parole, non può proporre progetti di legge. Questo compito fondamentale, la «democraticissima» Unione lo riserva gelosamente (in base all'articolo 17 comma 2 del Trattato di Maastricht) a un ente, la Commissione, composto da ventisette soggetti, ovviamente non eletti e scelti in base a un criterio (articolo 17 comma 3) da far impallidire la supercazzola del conte Mascetti: «in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza». C'è poi l'aspetto, tutt'altro che secondario e sovente dimenticato, delle materie su cui abbiamo ceduto in tutto o in parte lo scettro del comando a Bruxelles: ai sensi degli articoli 3 e 4 del Trattato di Lisbona, si spazia dalla politica monetaria a quella commerciale, da quella doganale a quella delle gestione delle risorse marine, di agricoltura e pesca, passando per ambiente, politica sociale, protezione dei consumatori, trasporti, reti transeuropee, energia, spazio di libertà, sicurezza e giustizia, problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica. Infine, un colpo quasi mortale alla nostra sovranità lo ha assestato nel 2001 la sciagurata riforma dell'articolo 117 della Costituzione secondo cui la potestà legislativa va esercitata dall'Italia «nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Ecco come, nel 1992, Salvatore Giachetti, allora presidente di sezione del Consiglio di Stato, ci aveva messi in guardia con profetiche parole sulla pericolosità dei trattati: «Hanno costruito delle gallerie in durissimo cemento attraverso le quali le norme comunitarie, come un esercito di termiti, sono penetrate nell'ordinamento nazionale e lo stanno progressivamente svuotando».
Proseguendo lungo questa china, perderemo la sovranità legislativa che è poi la quintessenza dell'indipendenza nazionale. Abbiamo solo due armi a disposizione, per fortuna dotate di ottime munizioni. La prima è l'orientamento ormai consolidato del nostro Giudice delle leggi, secondo cui nemmeno le norme Ue di applicazione diretta nel nostro ordinamento (e cioè i regolamenti) possono averla vinta sui principii inviolabili e sui diritti fondamentali sanciti negli articoli da 1 a 54 della nostra Carta fondamentale. La seconda è la nostra volontà: dobbiamo posizionarci sulla linea di intransigenza assoluta rispetto alla proposta di firma di qualsiasi nuovo trattato alle viste (soprattutto quelli in materia fiscale). Se poi riusciremo anche a riportare alla loro stesura originaria gli articoli 81, 117 e 119 della Costituzione, di cui è stato fatto scempio dal 2001 in poi, allora il progetto di spolpamento della sovranità statuale non potrà mai essere condotto a termine.
www.francescocarraro.com