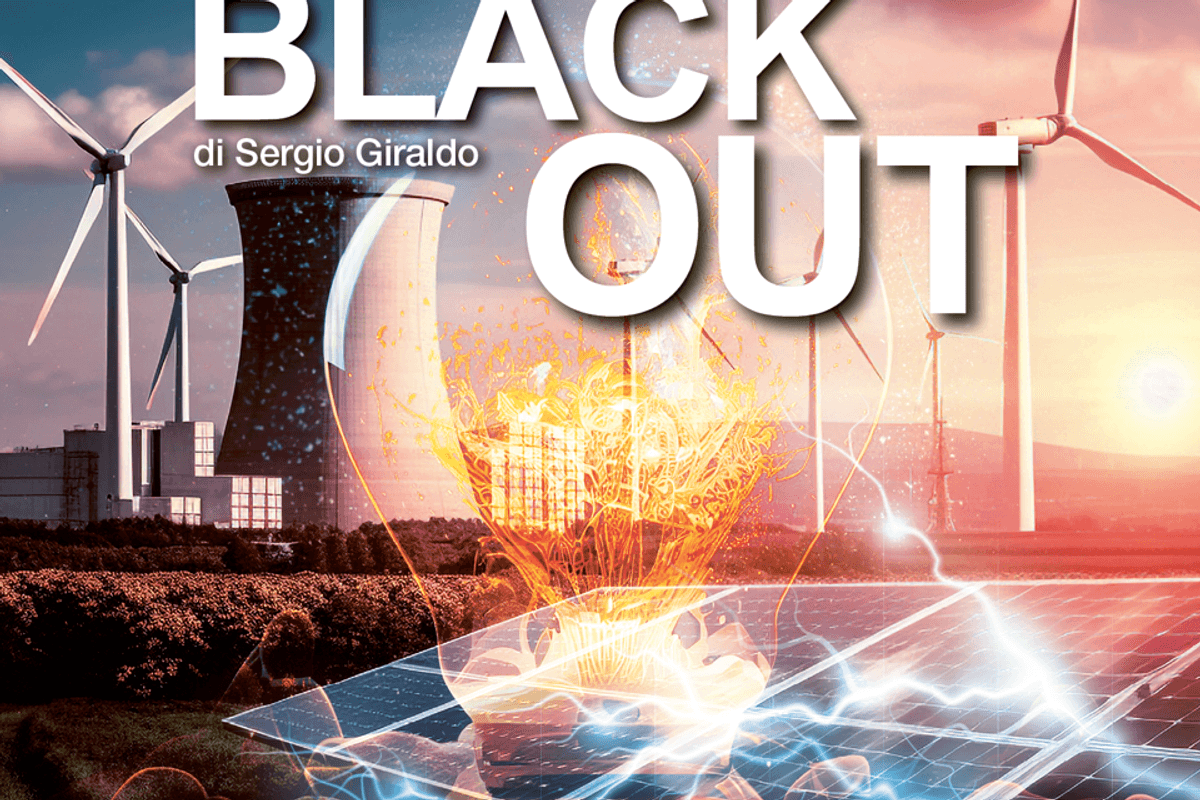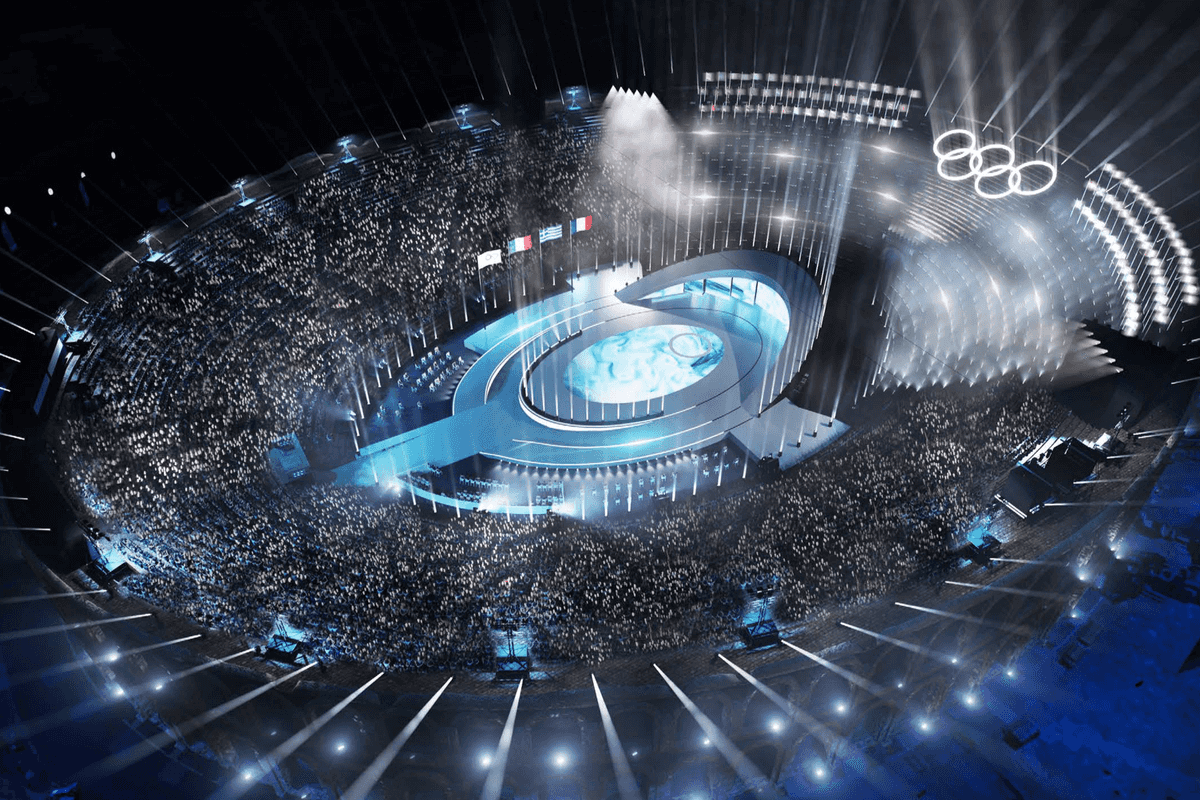- Durante il lockdown in Italia sono circolati 44 stupefacenti mai visti prima, e 128 in tutta Europa. Lo smercio favorito dall'acquisto online. E dalla lentezza del sistema giudiziario
- La criminologa Mary Petrillo: «Le dipendenze sono legate a relazioni difficili Un boom per la canapa coltivata in casa mescolata con l'alcol»
Lo speciale contiene due articoli
L'alert era arrivato dall'Incb, acronimo di International narcotics control board, organismo internazionale per il controllo degli stupefacenti: bisognava monitorare il potenziale impatto della pandemia da Covid 19 sul mercato delle sostanze da abuso. E dopo le prime verifiche è saltato fuori che i tossici del lockdown hanno scoperto ben 128 nuove droghe, in buona parte sintetiche. La pandemia, stando a un rapporto stilato dagli esperti del Dipartimento per le politiche antidroga, una struttura in capo alla presidenza del Consiglio dei ministri, ha avuto un «profondo impatto sui mercati delle sostanze, sulle modalità e sulle tendenze del consumo».
Produzione e traffico di stupefacenti sembrano essersi adattati con facilità alle restrizioni anti Covid. Il capo del Dipartimento, Flavio Siniscalchi, tira le somme: nel 2020 è «aumentato il quantitativo di droghe sequestrate sul territorio nazionale malgrado un numero inferiore di operazioni antidroga». Ma il dato inquietante è questo: «Sono aumentati i sequestri delle nuove sostanze psicoattive e ne sono state individuate ben 44 mai viste prima in Italia». Nel periodo delle chiusure imposte dal governo guidato da Giuseppe Conte, insomma, i trafficanti di sostanze stupefacenti sono riusciti a introdurre 44 nuove droghe. I cui effetti collaterali a lungo termine sono ancora semi sconosciuti. E come per il cibo, anche il mercato della droga si è spostato sugli ecommerce. «Le misure di lockdown», spiega ancora Siniscalchi, «probabilmente hanno inciso sul commercio al dettaglio di stupefacenti e potrebbero infatti aver favorito il potenziamento di modalità di distribuzione online delle sostanze, accelerando una tendenza registrata negli ultimi anni, di un mercato sempre più digitalizzato».
Le operazioni antidroga hanno confermato il mercato olandese come principale area di approvvigionamento delle droghe sintetiche, seguito da Siria, Brasile, Perù e Cina. Nella maggioranza dei casi i sequestri di queste sostanze hanno riguardato pacchi o lettere postali, suggerendo una proliferazione della rete di vendita online. Ed ecco la valutazione choc di Siniscalchi: «Tutti gli indicatori descrivono modelli di consumo sempre più complessi incentivati probabilmente dal fatto che gli utilizzatori accedono a un mercato illegale in cui si reperiscono più tipologie di sostanze». E questo ha messo subito in luce le falle del sistema giudiziario. Perché l'impatto della pandemia sembra aver prodotto anche un rallentamento delle procedure che, in correlazione con una plausibile riduzione dei reati da imputare alle restrizioni della mobilità, ha fatto registrare un minor numero di segnalazioni per possesso, di denunce, di procedimenti, di condanne e di affidamenti in esecuzione penale esterna.
A conti fatti, i nuovi metodi di distribuzione della droga sono più efficaci e meno pericolosi per i trafficanti. E se in Trentino Alto Adige, Liguria ed Emilia Romagna le percentuali più alte di chi ha commesso crimini correlati alla droga, intorno al 70%, è di origine straniera, in Calabria, Puglia, Campania e Basilicata, con percentuali che superano il 90%, pusher, produttori e trafficanti sono italiani.
Nel 2020, però, è aumentato il quantitativo di sostanze sequestrate sul territorio nazionale (+7,4%), a fronte di un numero inferiore di operazioni antidroga svolte dalle forze di polizia (-13%). E risultano incrementati i sequestri di sostanze psicoattive storicamente meno diffuse nel nostro Paese, come il khat, i bulbi di papavero, le compresse di ossicodone e quelle di droghe sintetiche. I sequestri di nuove sostanze psicoattive è schizzato alla quota record del 200%. E ci sono le 44 sostanze mai viste prima.
Si tratta, nella maggioranza dei casi, di nuove molecole che, al momento dell'uscita sul mercato, non erano inserite nelle tabelle delle convenzioni internazionali e delle leggi nazionali: sostanze chimiche di nuova ideazione che imitano l'effetto di droghe illegali e di sostanze già note, utilizzate in maniera nuova, come ketamina e farmaci psicoattivi. Due sostanze sono state individuate per la prima volta sul territorio europeo proprio in Italia, appartenenti alla classe degli oppioidi sintetici analoghi del fentanil e una nuova sostanza appartenente alla classe dei cannabinoidi sintetici. Il ministero della Salute ha dovuto quindi emanare decreti per inserire le nuove sostanze tra quelle da controllare.
«Individuare nuove sostanze psicoattive non presenti nell'elenco delle sostanze stupefacenti», valuta Simona Pichini, responsabile dell'Unità di farmatossicologia dell'Istituto superiore di sanità, «significa prendere misure di sicurezza per prevenire intossicazioni e decessi, causati direttamente dalle stesse o da prodotti che le contengono». I decessi, infatti, sono la nota dolente: nel corso del 2020, i morti riconducibili all'abuso di sostanze stupefacenti hanno raggiunto i 308 casi. Il 3,6% dei quali era nella fascia d'età tra i 15 e i 19 anni. L'Umbria è la regione con tasso di mortalità per overdose più elevato: 36 decessi ogni milione di residenti tra 15 e 64 anni, seguono Valle d'Aosta, con 26 decessi, Friuli Venezia Giulia, Marche e Abruzzo, con valori superiori a 15 decessi ogni milione di abitanti. La diffusione della cannabis e dei suoi derivati, invece, nonostante sia ancora la sostanza più utilizzata, ha registrato una contrazione. I quantitativi sequestrati sono diminuiti del 54% per quanto riguarda l'hashish e del 16% relativamente alla marijuana. Ma sono aumentati dell'85% i sequestri di piante. Segno che ora i consumatori si fanno l'orticello di canapa a casa.
Il mercato delle sostanze stupefacenti è stimato in 16,2 miliardi di euro, di cui circa il 39% attribuibile al consumo dei derivati della cannabis e quasi il 32% all'utilizzo di cocaina. Negli ultimi tre anni per il mercato della cocaina si è osservato un incremento medio del commercio di circa 2,5 punti percentuali. Ma Siniscalchi ha ancora in serbo qualche brutta sorpresa. E segnala una «propensione sempre più accentuata, specialmente nelle nuove generazioni, verso consumi non legati a una sola sostanza, o alla compresenza in molti casi di dipendenze da sostanze insieme a quelle comportamentali». L'uso di droghe non nasce, come avveniva un tempo, solo in presenza di condizioni di emarginazione o fragilità sociale. E non risparmia i giovanissimi: stando al rapporto, il 7,6% degli studenti ha riferito di aver fatto uso di almeno una sostanza psicoattiva illecita nel periodo delle restrizioni per il contenimento della pandemia. Si va dalla cannabis alla cocaina, agli allucinogeni. Non mancano eroina, cannabis sintetica, salvia divinorum (una pianta psicoattiva allucinogena della famiglia delle lamiacee), inalanti o anabolizzanti. In particolare, esclusa la cannabis, il 2,5% ha utilizzato almeno una delle altre sostanze. E le percentuali maggiori si riscontrano fra i ragazzi (maschi 3,3%; femmine 1,7) con un rapporto di genere quasi doppio.
La frequenza di consumo? Oltre un terzo degli studenti consumatori (il 37%) afferma di non aver utilizzato sostanze più di due volte nel mese. Un quarto le ha utilizzate dalle tre alle nove volte e il restante 38% almeno dieci volte. «Si osserva quindi», sottolineano gli esperti, «che una percentuale consistente di consumatori ha fatto un uso frequente di sostanze psicoattive durante il lockdown». Questo potrebbe quindi indicare che coloro che sono riusciti a procurarsi sostanze stupefacenti, nonostante le restrizioni, siano anche coloro che ne fanno solitamente un uso più assiduo. Gli altri si sono dati al consumo di sostanze psicoattive legali: in molti hanno affermato di essersi ubriacati durante il lockdown e di aver fatto cinque o più bevute di fila. Il 27% degli studenti italiani ha dichiarato di essersi ubriacato almeno una volta fino al punto di barcollare, non riuscire a parlare correttamente, vomitare o addirittura dimenticare l'accaduto.
«I bersagli? I giovani. Qualcuno ha iniziato altri rafforzato l’uso»
«Gli effetti del lockdown legati alla diffusione della droga viaggiano su varie direttrici: una psicologica, una criminalistica e una sociologica». Mary Petrillo, psicologa e criminologa, docente di master universitari e molto impegnata nel mondo associativo, analizza con La Verità il peso che hanno avuto sulle tossicodipendenze le restrizioni per contrastare la pandemia.
Recenti studi dimostrano che con la pandemia è aumentato l'uso di droghe. Chi è caduto con più facilità nella rete della dipendenza?
«Gli individui più fragili sono stati messi a dura prova e molti di loro hanno cominciato a fare uso di sostanze psicoattive ma anche di alcolici; altri che già ne facevano uso, invece, hanno aumentato drasticamente il loro consumo. Il periodo del lockdown ha apportato uno stravolgimento nelle interazioni e anche nei legami sociali, in particolare nei giovani che si sono visti privati della loro libertà e con la didattica a distanza hanno dovuto modificare non solo la capacità di apprendimento, ma hanno dovuto accettare un diverso modo di relazionarsi con gli altri».
Quindi la pandemia ha una responsabilità diretta nella diffusione delle nuove droghe?
«Tutti questi aspetti hanno influito negativamente sui soggetti più deboli e su quelli disagiati, dove per disagio si intende anche sofferenza psicologica ed emotiva. L'uso smodato di droghe, quindi, per questi individui è dovuto alle difficoltà di tipo comunicativo e relazionale (per alcuni si tratta anche di disagi di tipo fisico) causate delle restrizioni che hanno costretto tutti a una sorta di reclusione forzata. Chi viveva sentimenti di sofferenza e inadeguatezza è evidente che ha cercato di placarli facendo uso di queste sostanze».
Per questo sono state testate droghe sconosciute?
«Sono state assunte sia per uso ricreativo durante le lunghe giornate che non permettevano momenti di socialità, sia per sballarsi e mettere da parte, così, un vissuto difficile al quale non si riusciva a far fronte. E molto probabilmente è per questo motivo che sono state scelte droghe che provocano conseguenze sulle funzioni nervose e intaccano la capacità di adattamento dell'individuo, agendo quindi su problematiche di tipo intrapsichico, ambientale e interpersonale».
Ovviamente c'è chi ha saputo intercettare le nuove richieste.
«A livello criminologico mi preme sottolineare che questa tipologia di sostanze stupefacenti, secondo l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, è appannaggio di tutte le mafie europee. Ma anche di quelle extra europee. In Cina, per esempio, pare ci sia una produzione di benzodiazepine a basso costo. Il materiale grezzo viene poi spedito in Europa, Italia compresa, e qui lavorato nei laboratori delle mafie e venduto online.
Ora viaggia tutto sul Web?
«Le inchieste giudiziarie hanno svelato che nel periodo del lockdown era facile reperire queste sostanze attraverso internet, con pagamenti effettuati anche utilizzando criptovalute. In altri casi, invece, è stato possibile creare le sostanze in casa, mescolando medicinali psicoattivi legali con alcol. Gli effetti sono gravi e spesso letali».
Le mafie italiane si sono subito attrezzate o sono rimaste fuori dalla partita?
«Si sono attrezzate e non solo per la distribuzione al dettaglio. Così, i guadagni della criminalità organizzata durante il lockdown sono aumentati. I cartelli della droga hanno sfruttato il disagio psicofisico e sociale creatosi a causa della pandemia da Covid 19 per sviluppare questo nuovo mercato di droghe che in alcuni casi ha persino superato quello delle droghe classiche: eroina, cocaina e cannabis. I narcotrafficanti, insomma, hanno saputo sfruttare a loro vantaggio le difficoltà delle persone, facendo leva sui loro bisogni, per poter meglio soggiogarli e controllare il territorio».
A livello sociale tutto questo che impatto ha avuto?
«La droga sintetica ha effetti più devastanti delle droghe classiche e ciò si ripercuote sull'intera società in quanto chi ne fa uso sviluppa pericolose condotte, anche delinquenziali. E sotto l'effetto di queste sostanze si può macchiare di gravi delitti».
Fenomeni già noti?
«In passato, durante i periodi di crisi della società, si è riscontrato, come oggi, l'aumento nell'uso di sostanze che creano dipendenza per cercare di mitigare il più possibile le difficoltà che alcuni individui non riescono a gestire. Ma i danni provocati anche a livello psicofisico da queste sostanze hanno chiaramente anche un peso e un costo a livello sociale e sulla sanità. Si prenda, per esempio, il dato sull'aumento dei ricoveri in ospedale oppure in strutture di assistenza».
E molti sono giovani.
«L'uso e l'abuso di queste nuove droghe mette in evidenza quanto questi abbiano bisogno di punti di riferimento per acquisire senso critico e non cedere alla pressione del gruppo. Molte volte si tende a fare uso di sostanze per non sentirsi esclusi dai coetanei e quindi, in un certo senso, per conformarsi. Il lockdown ha agito indubbiamente sul senso di appartenenza, che è diventato ancora più forte perché le privazioni e le difficoltà relazionali in famiglia hanno fatto crescere nei ragazzi il bisogno di sentirsi uniti e solidali con i coetanei. Dall'altro lato, poi, ha influito anche una comunicazione errata della pandemia. Ora, però, bisogna far capire ai ragazzi che il Covid si può combattere e che quindi possono ancora progettare il loro futuro e non gettare via la propria vita con la droga».