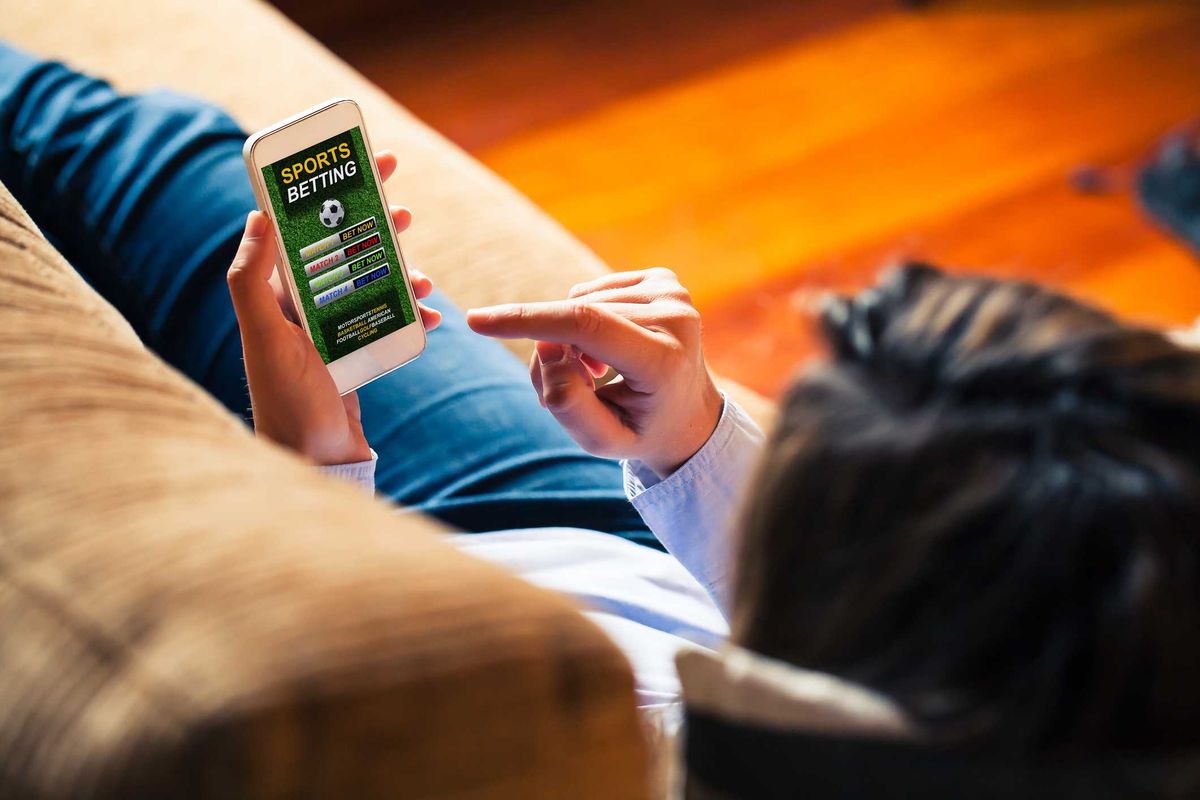Mario Morelli, eletto ieri presidente della Corte costituzionale, interviene sul referendum e detta l'agenda politica: quella del Pd.Partecipò all'istruttoria del processo sullo scandalo Lockheed, quello sulla fornitura di aerei C130 all'Aeronautica militare, che travolse politica e vertici militari negli anni Settanta. E, soprattutto, fu l'estensore della sentenza sull'interruzione di alimentazione e idratazione a Eluana Englaro, nel 2008. La prima pietra di un percorso culminato lo scorso anno, con la parziale abrogazione del reato di aiuto al suicidio. Adesso, il giudice Mario Rosario Morelli, 79 anni, il più anziano tra i colleghi, succede a Marta Cartabia alla presidenza della Corte costituzionale. È stato eletto ieri a maggioranza, con nove voti: quattro in più di Giancarlo Coraggio, mentre Giuliano Amato ne ha ricevuto uno. Saranno i suoi vice. Dall'8 marzo 2018, Morelli era il numero due della Consulta.Di sicuro, non è l'inizio di una nuova era. Il magistrato rimarrà al suo posto soltanto fino al 12 dicembre prossimo, quando scadrà il suo novennio. Una sorta di Celestino V in toga, destinato a rimanere al «soglio» soltanto per circa 100 giorni. Ma, a differenza dell'asceta molisano, il giurista romano, appena nominato, ha deciso di entrare subito a gamba tesa nella partita politica in corso.Durante la conferenza stampa successiva all'investitura, infatti, Morelli ha dichiarato: «Il taglio degli eletti è una riforma che incide sulla Costituzione in maniera relativa e va completata con provvedimenti che, con sequenza diacronica, devono seguire». Al netto dei bizantinismi, il messaggio è cristallino: dopo il referendum, occorre una riforma costituzionale organica. E, guarda caso, chi è che ce l'ha già quasi pronta? Il Partito democratico. Era assodato che il sì dei dem, da sempre contrari al giro di vite populista sponsorizzato dai grillini, dovesse essere barattato con un successivo intervento legislativo più radicale. Qualche giorno fa, l'Agi riportava anche i dettagli dell'operazione che hanno in mente al Nazareno: introdurre l'istituto della sfiducia costruttiva; conferire al presidente del Consiglio la facoltà di proporre al capo dello Stato non solo la nomina, ma anche la revoca dei ministri; differenziare le funzioni delle due Camere, integrando al Senato rappresentanti delle Regioni e specializzandolo; valorizzare le sedute comuni, ma attribuendo a Montecitorio il voto finale su tutte le leggi. Dunque, un presidente della Consulta, fresco di elezione, a quattro giorni dal voto, segna immediatamente l'agenda da seguire da martedì prossimo in poi. In più, singolare coincidenza, ad aver tracciato un percorso di riforma è appunto il partito di Nicola Zingaretti (quello uscito sconfitto dalle ultime politiche, ma ormai in Italia certe circostanze sono un dettaglio trascurabile). Possibile che tutto ciò sia considerato normale? Nessuno che sollevi una questione d'opportunità? Nessuno che, non diciamo si stracci le vesti, ma almeno si strappi simbolicamente un capello? Cosa sarebbe successo se, al posto di Morelli, si fosse trovato un magistrato (veramente) cattolico, che si fosse pronunciato sulla necessità di tutelare la libertà d'espressione di chi dissente dal pensiero Lgbt, mentre in Parlamento si sta battagliando sul ddl Zan? Un precedente storico c'è: basta andare a riguardarsi cosa scrissero le associazioni arcobaleno, quando, nel 2011, Giorgio Napolitano portò alla Corte la ciellina Cartabia, al tempo nota per la sua contrarietà alle nozze gay e alla retorica dei «nuovi diritti».Bisogna tuttavia riconoscere che Morelli non ha inventato nulla di nuovo. Durante la presidenza di Giorgio Lattanzi, la Consulta, chiamata a pronunciarsi sul caso Cappato, inviò il famoso ultimatum all'Aula: o approvate una legge sul fine vita, o decideremo autonomamente. Era evidente quali fossero le coordinate della normativa richiesta dai giudici: nella sostanza, una legittimazione dell'eutanasia. Non è stato il neopresidente a introdurre per primo la pratica per cui i magistrati costituzionali spiegano agli onorevoli su cosa debbano lavorare. Negli ultimi tempi, con la Cartabia, la Corte ha invero insistito molto su quella che ha presentato come un'articolazione del principio di «leale collaborazione» tra istituzioni. A questo punto, non ci si può nemmeno più stupire se si sentono certe frasi da una toga della Consulta: «C'è una classe di diritti che dobbiamo far rispettare, che non nascono dall'alto, ma sono richiesti dalla coscienza sociale». Insomma, per Morelli, che non a caso s'intestò la sentenza sulla povera Eluana, i diritti non sono quelli scolpiti nella Carta costituzionale, ma sono quelli che di volta in volta emergono dalla società. Peccato che, mentre la Costituzione è lì da 70 anni, semplice, inequivoca, le istanze promosse dalla società necessitano di una procedura trasparente e il più possibile condivisa, prima di essere trasformate in «diritti». Per farla breve: chi stabilisce cosa emerge e cosa non emerge dalla «coscienza sociale» e cosa, dunque, è meritevole di tutela? La Corte. Ovvero, Morelli. È l'assaggio di quello che ci aspetta di qui ai prossimi anni.
Nadia e Aimo Moroni
Prima puntata sulla vita di un gigante della cucina italiana, morto un mese fa a 91 anni. È da mamma Nunzia che apprende l’arte di riconoscere a occhio una gallina di qualità. Poi il lavoro a Milano, all’inizio come ambulante e successivamente come lavapiatti.
È mancato serenamente a 91 anni il mese scorso. Aimo Moroni si era ritirato oramai da un po’ di tempo dalla prima linea dei fornelli del locale da lui fondato nel 1962 con la sua Nadia, ovvero «Il luogo di Aimo e Nadia», ora affidato nelle salde mani della figlia Stefania e dei due bravi eredi Fabio Pisani e Alessandro Negrini, ma l’eredità che ha lasciato e la storia, per certi versi unica, del suo impegno e della passione dedicata a valorizzare la cucina italiana, i suoi prodotti e quel mondo di artigiani che, silenziosi, hanno sempre operato dietro le quinte, merita adeguato onore.
Franz Botrè (nel riquadro) e Francesco Florio
Il direttore di «Arbiter» Franz Botrè: «Il trofeo “Su misura” celebra la maestria artigiana e la bellezza del “fatto bene”. Il tema di quest’anno, Winter elegance, grazie alla partnership di Loro Piana porterà lo stile alle Olimpiadi».
C’è un’Italia che continua a credere nella bellezza del tempo speso bene, nel valore dei gesti sapienti e nella perfezione di un punto cucito a mano. È l’Italia della sartoria, un’eccellenza che Arbiter celebra da sempre come forma d’arte, cultura e stile di vita. In questo spirito nasce il «Su misura - Trofeo Arbiter», il premio ideato da Franz Botrè, direttore della storica rivista, giunto alla quinta edizione, vinta quest’anno da Francesco Florio della Sartoria Florio di Parigi mentre Hanna Bond, dell’atelier Norton & Sons di Londra, si è aggiudicata lo Spillo d’Oro, assegnato dagli studenti del Master in fashion & luxury management dell’università Bocconi. Un appuntamento, quello del trofeo, che riunisce i migliori maestri sarti italiani e internazionali, protagonisti di una competizione che è prima di tutto un omaggio al mestiere, alla passione e alla capacità di trasformare il tessuto in emozione. Il tema scelto per questa edizione, «Winter elegance», richiama l’eleganza invernale e rende tributo ai prossimi Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, unendo sport, stile e territorio in un’unica narrazione di eccellenza. A firmare la partnership, un nome che è sinonimo di qualità assoluta: Loro Piana, simbolo di lusso discreto e artigianalità senza tempo. Con Franz Botrè abbiamo parlato delle origini del premio, del significato profondo della sartoria su misura e di come, in un mondo dominato dalla velocità, l’abito del sarto resti l’emblema di un’eleganza autentica e duratura.
iStock
A rischiare di cadere nella trappola dei «nuovi» vizi anche i bambini di dieci anni.
Dopo quattro anni dalla precedente edizione, che si era tenuta in forma ridotta a causa della pandemia Covid, si è svolta a Roma la VII Conferenza nazionale sulle dipendenze, che ha visto la numerosa partecipazione dei soggetti, pubblici e privati del terzo settore, che operano nel campo non solo delle tossicodipendenze da stupefacenti, ma anche nel campo di quelle che potremmo definire le «nuove dipendenze»: da condotte e comportamenti, legate all’abuso di internet, con giochi online (gaming), gioco d’azzardo patologico (gambling), che richiedono un’attenzione speciale per i comportamenti a rischio dei giovani e giovanissimi (10/13 anni!). In ordine alla tossicodipendenza, il messaggio unanime degli operatori sul campo è stato molto chiaro e forte: non esistono droghe leggere!
Messi in campo dell’esecutivo 165 milioni nella lotta agli stupefacenti. Meloni: «È una sfida prioritaria e un lavoro di squadra». Tra le misure varate, pure la possibilità di destinare l’8 per mille alle attività di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti.
Il governo raddoppia sforzi e risorse nella lotta contro le dipendenze. «Dal 2024 al 2025 l’investimento economico è raddoppiato, toccando quota 165 milioni di euro» ha spiegato il premier Giorgia Meloni in occasione dell’apertura dei lavori del VII Conferenza nazionale sulle dipendenze organizzata dal Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze. Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui Meloni ha rivolto i suoi sentiti ringraziamenti, il premier ha spiegato che quella contro le dipendenze è una sfida che lo Stato italiano considera prioritaria». Lo dimostra il fatto che «in questi tre anni non ci siamo limitati a stanziare più risorse, ci siamo preoccupati di costruire un nuovo metodo di lavoro fondato sul confronto e sulla condivisione delle responsabilità. Lo abbiamo fatto perché siamo consapevoli che il lavoro riesce solo se è di squadra».