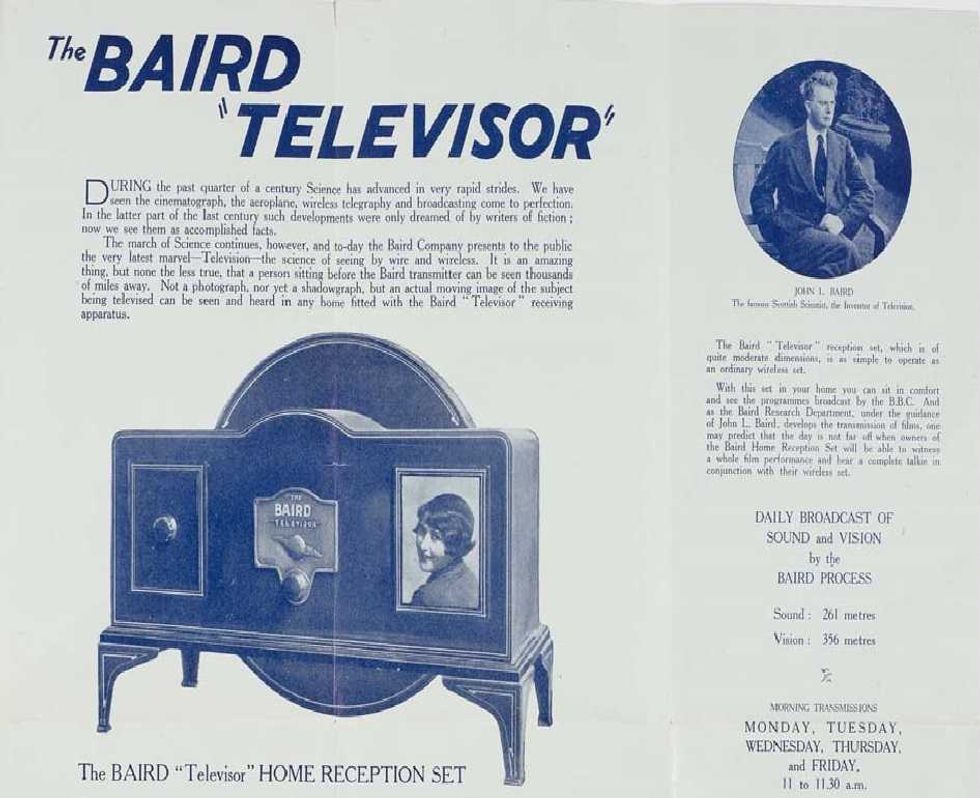«Questa giustizia malata di ideologia mette a rischio la vita democratica»

La gestione dei migranti ripropone il problema dei rapporti politica-giustizia, evidenziato dal caso Apostolico e dal congresso di Area. La Verità ne discute con Giuseppe Bianco, sostituto procuratore di Roma.
Dottore, quanto interferisce l’appartenenza ideologica dei giudici in certe decisioni?
«L’immigrazione è un tema centrale perché è in gioco ormai il controllo dei confini. In campi così sensibili, l’uniformità della giurisdizione, che sarebbe vitale, non c’è. Faccio un esempio: nel 2018 il procuratore di Torino decise che avrebbe dato priorità solo ai casi di odio razziale e che non era possibile limitare gli arrivi. Tutto legittimo. Altrettanto legittimo che altre Procure si dessero priorità diverse. Per evitare una Babele, la Cartabia ora stabilisce che ogni Procura scelga le sue priorità solo dentro dei parametri nazionali. Ma così la palla torna sempre ai vertici locali. E qui contano tanti fattori, anche soggettività ideologiche o numeri fascicolari. Peraltro anche se la legge nazionale desse delle priorità chiare, chi dovrebbe farle rispettare? Il Csm, che è un organo che deve sempre difendersi dalle correnti, alcune apertamente collateraliste? O il ministro? Ma allora il pm entra nell’orbita dell’esecutivo, come dicono alcuni apparatchik associativi, che forse hanno meno amore per l’indipendenza del pm di quanto ne abbiano per le rendite di posizione che perderebbero. La verità è che una certa gestione dell’azione penale può addirittura vanificare i responsi elettorali e quindi serve una soluzione ragionevole. La separazione delle carriere, cui Area si oppone, è solo un corollario. Il punto vero è il governo equilibrato dell’azione penale. Ma ogni discussione è condizionata da un correntismo degenere. Liberare i magistrati comuni dalle pastoie interne è la vera priorità».
Basterebbe a fare cessare la crisi fra politica e giustizia?
«La crisi non è solo italiana. L’espansione del protagonismo giudiziario è solo un aspetto settoriale del gigantismo tecnocratico, che è il vero dramma dell’Europa. La magistratura non ha investitura elettiva. È un soggetto funzionariale molto importante, ma che ha un campo ristretto di azione. È per questo che alla Costituente Palmiro Togliatti ottenne che i giudici fossero definiti “ordine“ e non “potere“. Ma oggi gli ordini tecnici vogliono imporsi sui poteri legittimati democraticamente. È uno scontro mortale fra tecnocrazia e democrazia».
Tra la gente c’è la sensazione diffusa che in questi anni di politica emergenziale i magistrati siano stati assenti, abdicando al ruolo di «sentinelle» dei diritti del popolo per allinearsi con tutti i poteri reali del Paese. È finita l’indipendenza della magistratura?
«L’indipendenza del magistrato comune è condizionata da un correntismo deforme, che si sente padrone esclusivo dell’indipendenza del giudice, al quale ne concede un pezzo per volta, in cambio del voto di obbedienza. È una gabbia elettrificata invisibile che può anche arrivare a condizionare la giurisdizione. Ci sono correnti che ormai fanno chiaramente politica attraverso la leva giudiziaria e pretendono una fidelizzazione assoluta. Durante la pandemia a tutto questo si è aggiunta anche un’eccezionale pressione mediatica. D’altro canto, non bisogna illudersi sul potere della giurisdizione: contano anche i tempi procedurali. I dpcm del lockdown cambiavano ogni 15 giorni. I processi finivano per estinzione dell’oggetto della contesa, perché appunto ogni 15 giorni l’oggetto moriva e ne nasceva un altro, e il gioco dell’oca ricominciava. Anche la Consulta si è pronunciata dopo due anni, perché l’iter è altrettanto lungo. La domanda è: certe procedure ordinarie sono adeguate rispetto a un modello emergenziale?».
In ogni ambito vediamo la tendenza a ignorare il principio di realtà e quello di precauzione: accade anche ai giudici?
«In tutti i casi in cui prevale una lettura ideologicamente prevenuta siamo fuori dalla realtà. Il giudice deve valutare il singolo caso reale e non fare il maestro di estremistica dogmatica. Si è fuori dalla realtà quando una corrente di magistrati annuncia pubblicamente che “bisogna fare prevalere i diritti sociali rispetto al diritto di proprietà“, contestando a priori gli sgomberi legittimamente disposti dall’autorità amministrativa, come accaduto nel 2017. Si è fuori dalla realtà quando un giudice scrive in una sentenza di condanna che - secondo lui - è in corso una “pericolosa deriva sovranista”, censurando all’imputato perfino un’opzione politica legittima, come avvenuto nel 2020, a Milano. Siamo in presenza di una lettura ideologica della realtà. E dunque deformante, irreale».
La recente sentenza della Consulta sulla legittimità dell’obbligo vaccinale sembra avere sancito il principio che la collettività prevale sul singolo. Come è possibile che in nome di un bene presunto collettivo si sacrifichino diritti inviolabili della persona, pur previsti dalla Costituzione?
«I diritti tradizionali di libertà che per Costituzione erano riconosciuti, cioè connaturati alla stessa vita umana, oggi cominciano a essere delle concessioni, esistono in quanto autorizzati. A livello di certe élite c’è stato un cambio di paradigma. Mentre un tempo si riconosceva il ruolo centrale della persona umana, oggi sta riemergendo il “primato della comunità”. Un concetto abbastanza elastico da soddisfare ogni contingenza politica, ma soprattutto alla base delle concezioni totalitarie del Novecento. La centralità della persona era invece il limite sacro imposto dal cristianesimo sociale: per Giorgio La Pira, Aldo Moro, Amintore Fanfani e Giuseppe Dossetti nessuno poteva esigere il sacrificio umano del singolo. Lo diceva la stessa Consulta, in una sentenza del 1996: “Non si può mai sacrificare un singolo per salvare gli altri, fossero anche tutti gli altri”. E se conta solo un generico concetto di “comunità” e non il singolo in carne e ossa, non serve più nemmeno il principio di precauzione, che è appunto a tutela del singolo. Poi ci sono anche le debolezze strutturali della Consulta, denunciate già in Costituente da Orlando e da Nitti».
C’è un problema di fondo che trascende le singole sentenze: nella cultura tecnocratica dominante, come cambiano i nostri diritti posto che quelli che davamo per scontati - come il diritto alla mobilità personale o alla riservatezza dei dati - vengono messi in discussione?
«I nuovi poteri finanziari, ipertecnici, non avendo la legittimazione del voto popolare, ne trovano una surrettizia nelle “crisi”. Se finisce l’emergenza, finisce il bisogno degli “esperti”. Viceversa, più si svilisce la politica, più aumenta lo strapotere di questi “sacerdoti”. Perfino la stessa presidente della Consulta ha teorizzato che il diritto europeo deve prevalere su quello statale e se pensiamo che quasi tutto il diritto europeo è fatto da burocrazie non elette, è chiaro che siamo in uno stadio avanzato di cancellazione degli Stati sovrani, cioè degli unici luoghi dove è ancora possibile la partecipazione popolare e quindi la politica. Ma se sparisce il primato della politica, torniamo a una condizione feudale: il potere in mano a una classe di maghi e di banchieri non eletti, i popoli legati all’aratro, con i sondaggi al posto delle elezioni. Per impedire fenomeni di rigetto, questa oligarchia autonominata aumenta il controllo sociale: toglie il diritto alla privacy in nome della sicurezza, alla libertà di spostamento in nome del pianeta, alla libertà di parola in nome della vera Verità. Ma se le crisi continuano in eterno allora forse non sono più crisi, bensì i limiti strutturali di un modello costruito male o fallito, che non certo i banchieri e gli alchimisti possono sistemare, mancando di quella visione ideale, sociale, spirituale che può venirci solo dalla politica. Con i maghi al potere, i cortocircuiti sono destinati ad aumentare. È un avvitamento drammatico. Democrazia e tecnocrazia non possono convivere. Quanto può durare?».