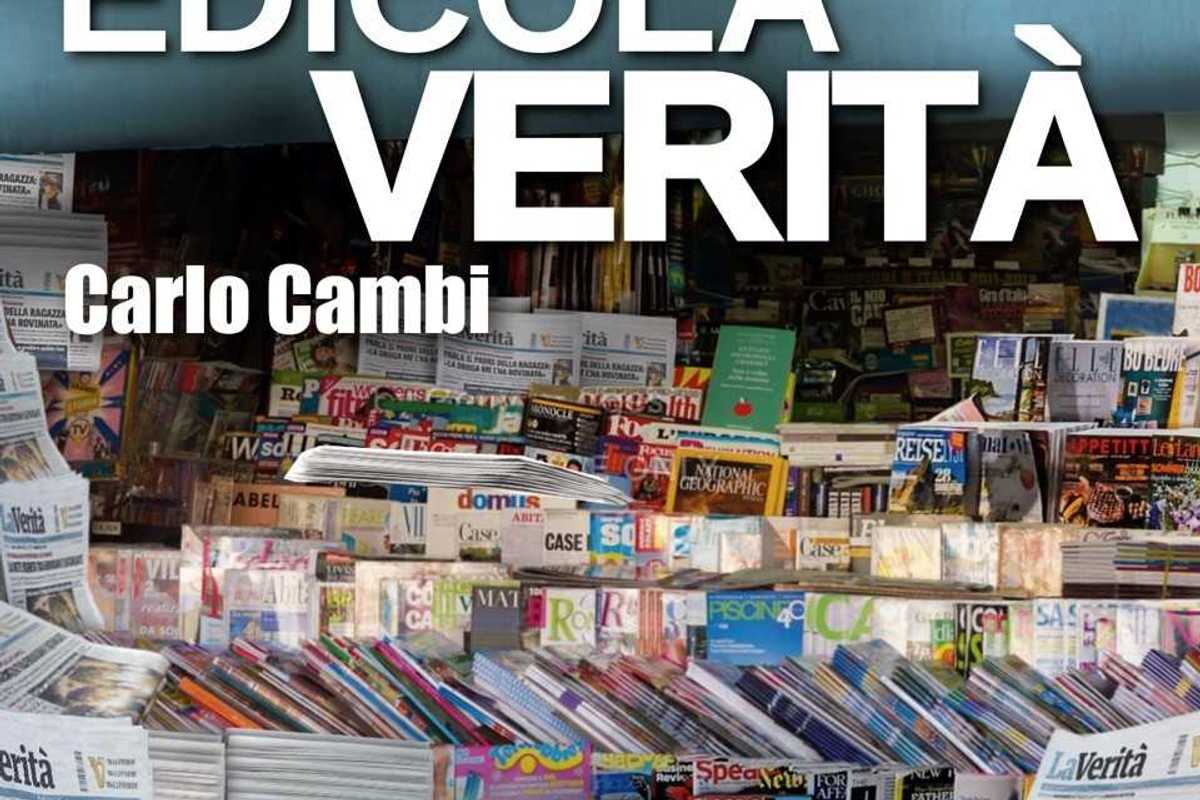Gian Luca Artizzu: «Il nucleare non è più un tabù e si sposa con le rinnovabili»

Gian Luca Artizzu sta per compiere il primo anno da amministratore delegato di Sogin, la società pubblica responsabile della dismissione degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi. Il manager è al timone dall’agosto del 2023 nominato dal governo Meloni dopo il commissariamento della società deciso dal governo Draghi a luglio 2022.
Ha visto la petizione per un «100% Rinnovabili network» promossa da ambientalisti e scienziati contro il ritorno al nucleare? Che ne pensa?
«Francamente mi sembra una battaglia di retroguardia, non ci ho trovato niente di nuovo, a parte un riferimento a una presunta “lobby del nucleare”, che oggettivamente non esiste. Il nucleare, da oltre 35 anni, vive al confino, ha ritrovato il diritto di parola da appena un anno grazie ad alcune iniziative politiche pubbliche coraggiose».
Perché la considera una battaglia di retroguardia?
«Rinnovabili e nucleare non sono affatto in competizione fra loro, ma devono essere viste come fonti che si integrano all’interno di un mix energetico che nel suo complesso offra certezza della fornitura, sicurezza ambientale, decarbonizzazione e, per quanto possibile in un contesto come quello italiano, una sostanziale autonomia da scelte di politica estera svantaggiose per noi. Il nucleare ha tutte le caratteristiche per dare il suo contributo in questo senso. Tenga conto, inoltre, che i consumi energetici nei prossimi 35 anni raddoppieranno, secondo alcuni scenari, o triplicheranno secondo altri, che enfatizzano la necessità sempre crescente di data center, e per conservare i dati serve energia, e l’impiego dell’Intelligenza artificiale e delle blockchain, settori energivori irrinunciabili se vogliamo continuare a essere un Paese industrializzato. In un contesto simile ciascuno deve dare il proprio apporto ed è evidente a tutti, a meno di non voler violentare il territorio, che le sole fonti rinnovabili non bastano».
Ursula von der Leyen è da poco stata riconfermata presidente della Commissione Ue. Il Green deal va avanti senza cambi di rotta. Cosa si aspetta in termini di strategia dell’Ue?
«Sono ottimista di mio, Von der Leyen ha fatto un accordo con i Verdi ma non c’è più Frans Timmermans. Spero che le autorità europee capiscano che serve un cambio di fonti energetiche che a sua volta implica un cambio di filiere tecnologiche profonde. Molti non ci pensano, ma per produrre energia serve energia, come per accendere il caminetto serve la mia energia muscolare per prendere la legna. E tutto questo ha un costo. Bisogna agire simultaneamente su tutte le fonti. Se il piano coinvolgerà tutte le fonti esistenti, con attenzione alla decarbonizzazione, allora sarà credibile. La scienza e le tecnologie sono e devono essere indipendenti dalle ideologie».
Crede nel «nuovo» nucleare?
«Se intende per nuovo quello di terza generazione avanzata e quello di quarta, sì: ci credo e credo che sia anche la dimostrazione di come il nucleare stia riuscendo a rendere circolare il proprio modello di business, con grande beneficio per l’ambiente. Ma devo anche aggiungere che credo molto anche in quello di terza generazione, che non ha mai dato particolari problemi ed è, stando a tutte le evidenze statistiche internazionali, più che sicuro. Le ricordo che il nucleare è l’unico settore che accantona soldi per depurare sé stesso. E che un terzo dei sistemi che si trovano dentro una centrale nucleare sono ridondanze di sicurezza che probabilmente non verranno mai usate ma che vanno previste. Come se un terzo del costo di un’auto fosse rappresentato dal prezzo degli airbag e degli altri sistemi di sicurezza».
Che ruolo vede per Sogin, che è nata invece per smantellare gli impianti nucleari?
«Sogin è nata in ambito Enel per gestire gli impianti nucleari e per valorizzare i propri siti e ha le competenze per farlo. La gestione, in un’epoca di chiusura degli impianti, successiva al referendum post Chernobyl, non può che coincidere con la messa in sicurezza, il decommissioning, la gestione del ciclo del combustibile e di quello dei rifiuti nucleari, fino al confinamento in deposito. Se devo immaginare un ruolo futuro sempre nel nucleare, che ovviamente auspico, lo vedo nella conduzione di impianti in fase di produzione, non tanto nella progettazione e costruzione di nuovi modelli di reattore, su cui si stanno impegnando altre aziende italiane, ma proprio nella fase di produzione di energia elettrica, sulla quale, seppur con importanti aggiornamenti, possiamo da subito dire la nostra».
Per quanto riguarda un’altra responsabilità di Sogin, il Deposito nazionale dei rifiuti nucleari, a che punto siamo?
«Siamo nella fase in cui il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica sta avviando la Vas, ovvero la Valutazione ambientale strategica, sulle 51 aree individuate dalla Carta nazionale delle aree idonee. Al termine di questo percorso complesso si dovrà prendere una decisione definitiva, a meno di variazioni sul tema o nuove impostazioni anche di legge».
Se Sogin dovesse fallire su questo punto, non sarebbe un segnale di impossibilità per l’Italia di rientrare nel nucleare?
«Sogin è un soggetto attuatore, non scrive le regole. Se si giunge all’individuazione dell’area adatta, con tutte le complessità del caso, che non sono di natura tecnica ma socio-politica, si rimbocca le maniche, progetta, costruisce e le assicuro che non fallisce».
Significa che senza il Deposito in pratica non si può fare il nuovo nucleare?
«Si può fare lo stesso e può funzionare lo stesso, ma il tema è un altro, è di tipo sistemico. Se non funziona il sistema decisionale, il tessuto normativo, quello regolamentare, per il Deposito, si può immaginare che non funzionerà nemmeno per aprire nuove centrali, questo è ovvio e intuitivo. Bisogna partire dai territori. Anche se alla fine il Comune di Trino si è ritirato, io ho creduto molto a un processo “dal basso”, con l’autocandidatura dei Comuni e dei territori, lo trovo più democratico e anche più consono a una società matura e tecnologicamente avanzata come dovremmo essere. Certo, poi si dovrebbe verificare territorio per territorio la possibilità tecnica di fare concretamente e questo è un lavoro che si fa assieme a Isin (l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare), che ha la responsabilità di definire e valutare i parametri tecnici di riferimento e la loro applicazione».
Si candiderà qualche altro Comune secondo lei? E sono ancora possibili le autocandidature?
«Al momento no, servirebbe una nuova norma, ma anche su questo, nonostante le difficoltà, l’opposizione di molti, sono comunque ottimista perché vedo un nuovo entusiasmo e una maggiore assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni. È tutto il contesto che deve crescere e che sta imparando dai propri errori. Noi, l’Ispettorato per la sicurezza nucleare, lo stesso Mase e le autonomie locali. Abbiamo bisogno che tutti si rafforzino e che l’intero sistema faccia un vero balzo in avanti».
Proprio l’identificazione del Deposito nazionale per le scorie atomiche e tossiche è stato al centro delle perquisizioni che la Guardia di finanza ha condotto, su mandato di Arera (l’Autorità per l’energia e le reti) nella sede dell’azienda prima del suo arrivo. Ha pesato questa inchiesta sulla gestione di Sogin?
«Fermo restando che Arera ha il diritto e anche il dovere fare tutte le verifiche che ritiene, le ricordo alcuni dati: queste inchieste hanno portato a 11 colleghi denunciati e indagati, cui si è aggiunta una consigliera di amministrazione. Tutti archiviati e la consigliera assolta perché il fatto non sussiste, il cosiddetto whistleblowing alla base di tutto è stato ritenuto, dal giudice penale, “autoproclamato”, quindi nullo. Arera dopo dieci anni ha deciso di agire: i controlli hanno generato una perdita di 12 milioni di euro a questa società. Sogin all’epoca non fece ricorso al Tar, il giudice naturale su questi casi, e questo meriterebbe un approfondimento serio. Io invece l’ho fatto, contro Arera. Quando mi sono insediato sono partito facendo una due diligence. Dalle verifiche che abbiamo fatto insieme a Deloitte, emerge un utilizzo molto soggettivo di Arera di questi controlli e un atteggiamento passivo e accondiscendente da parte dell’azienda. Per altro, sin qui sono state trovate solo irregolarità, non illiceità o illegalità. Credo che questa storia debba essere riscritta da capo e credo proprio che lo sarà. Mi sono opposto alla richiesta di altri 4,2 milioni. Decapitalizzare questa società, come è stato fatto, significa rubare il futuro ai dipendenti, ridurre la possibilità di investimenti, condannare l’azienda a un’esistenza marginale. Ciò detto auspico comunque per il futuro un confronto più sereno, come d’obbligo tra enti pubblici».
In Italia non c’è più da anni una Autorità nucleare dedicata. Serve?
«Sarebbe auspicabile, anche magari attraverso un’evoluzione della stessa Isin, come peraltro suggerito da tanti. Serve un arbitro forte. Sogin è uno dei player e, come mi capita spesso di dire con una battuta, qualunque giocatore preferirebbe essere arbitrato da Pierluigi Collina piuttosto che da arbitri di livello inferiore. Ma anche su questo sono ottimista e credo si stia decisamente andando nella direzione giusta».
A gennaio Forza Italia ha proposto due emendamenti al dl energia proprio per riproporre un’Agenzia per il nucleare. Ma sono saltati, perché?
«È stato proposto un subemendamento che non ha tenuto conto dello spirito del trattato e delle direttive Euratom confondendo il ruolo dell’ispettorato con quello di chi deve controllare. E quindi è stato fatto cadere. Il trattato Euratom, e le direttive successive, prescrivono di separare il controllo delle aziende del nucleare dall’ispettorato che si occupa di sicurezza e radioprotezione. Si è tentato anche il controllo diretto, economico, di Sogin, e questo entra in conflitto con troppi principi generali. Un’eventuale autorità unica deve comunque tener conto di questi principi e non tentare di possedere Sogin che, è bene ricordare, è una società per azioni, non un ente, e questo lo ha voluto il legislatore. Non credo proprio che sia un caso».