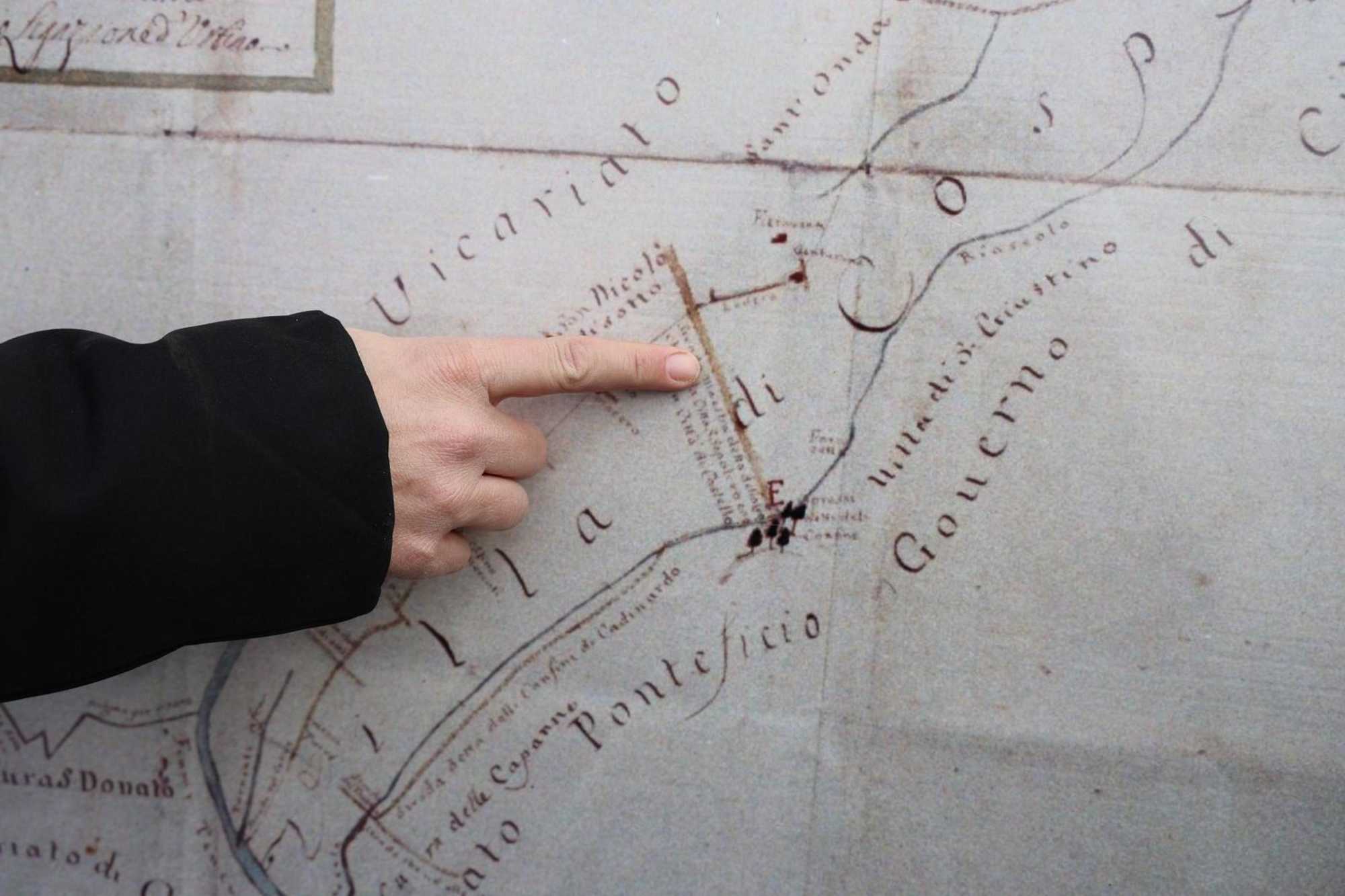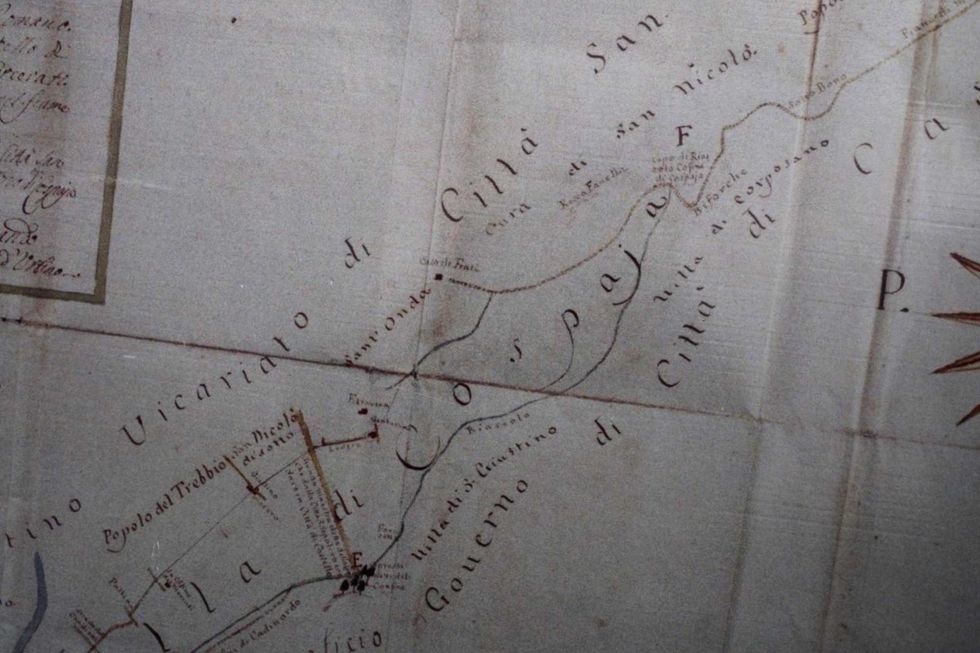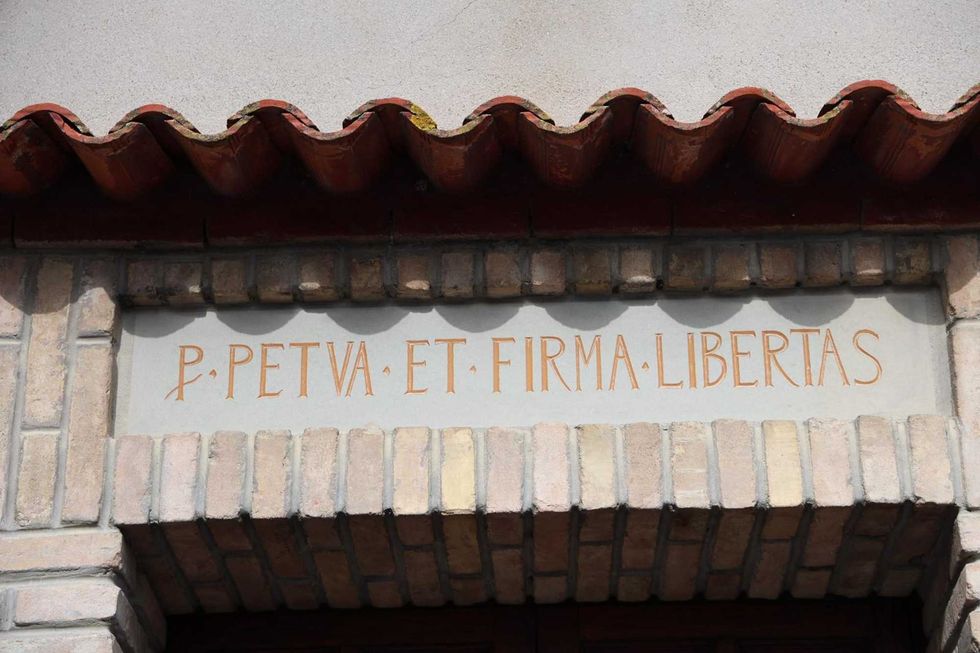Sintetico glossario cultural-gastronomico ad uso dei milioni di foresti (turisti, melomani, rockettari, appassionati di storia, arte e bellezza) che stanno invadendo Verona, il Garda, i Lessini e il territorio scaligero in generale.
Raterio, prelato e scrittore belga del X secolo, vescovo di Verona, s’innamorò talmente della città che quando fu costretto a lasciarla le indirizzò questo appassionato saluto: «Magna Verona vale, valeas per secula semper, et celebrent gentes nomen in orbem tuum»: addio grande Verona, vivi nei secoli per sempre e i popoli celebrino il tuo nome nel mondo.
Quando si parla di bocca a Verona si parla di magnàr. Che non è il mangiare di tutti gli altri italiani. E nemmeno degli altri veneti. Il magnàr veronese genera un sacco di derivati. C’è la magnàda, pasto in allegra brigata; il magnarìn, manicaretto; il magnàr coi oci, tipico del ghiottone davanti alle vetrine di gastronomia di via Stella, Portoni Borsari, Portoni della Bra. C’è il magnàr dai bàsi lasciato da Giulietta e Romeo in eredità agli innamorati. C’è chi, alto di statura, magna i gnochi en testa ai bassi.
Quel «magna» di Raterio si presta ad una duplice interpretazione: latina e dialettale. Quest’ultima è un invito a turisti & co. a mangiare Verona nutrendosi del bello e del buono. Dei piatti che la identificano: pastissada de caval, gnochi, pasta e fasoi con le codeghe, bigoli con le sarde del Garda, risoto col tastasàl, agnolini de Vales (Valeggio), pandoro, sfojadine di Villafranca, e, sublime concentrato di veronesità, bollito con la pearà, la salsa a base di pepe, pan grattato e midollo di bue che rianimò Rosmunda, regina dei Longobardi, dalla prostrazione in cui era caduta dopo essere stata costretta dal marito Alboino a bere nel cranio trasformato in coppa di papà Cunimondo, ammazzato dallo stesso re longobardo.
Questo racconta la leggenda. Vera o no, non c’è dubbio che fiumi di pearà scorrono nel sangue dei veronesi mescolati ai globuli rossi, innalzando il colesterolo e il matésso, lo stato d’animo che sta tra l’allegria e la pazzia. Veronesi tuti mati, dice il proverbio. La pearà mette il brio nelle vene. «Te sì pearìna», si dice di una donna vivace e di lingua sciolta. Non è un difetto. Anzi, è una lode alla pearà e alla donna indipendente: alla femmina-pearìna e a Rosmunda che dopo aver gustato la salsa ritrovò l’appetito e la fame di vendetta istigando l’amante Elmichi ad accelerare la dipartita di Alboino.
Pearà, vini e piatti tipici hanno il potere di trasformare chi soggiorna a Verona in un veronese tuto mato. Accadde ad Hans Barth, scrittore e giornalista tedesco agli inizi del ’900. Scortato per le osterie veronesi dal poeta Berto Barbarani e dal pittore Angelo Dall’Oca Bianca, tra un Valpolicella, un Soave, un Custoza e un Bardolino, perse la rigidità teutonica trasformandosi in un verseggiatore visionario.
Oltre che all’osteria, a Verona, i poeti nascono in cucina. Imparano la metrica orecchiando il ronfare quieto d’una pasta e fagioli che borboglia nella pignatta. Ispirati dal grana che fiocca su gnocchi con sugo di pastissada e risotti al tastasàl improvvisano versi a rima alternata. Il lento pipare d’un baccalà cucinato come si deve - e cioè, suggeriva il giornalista scrittore Cesare Marchi, alla fiamma d’uno zolfanello -, suggerisce quartine, sonetti, poemetti. . Barbarani dedica una cabala al gnoco; Gino Tartaglia esalta il Recioto «che ogni rudela mete en moto» Tolo Da Re si rianima davanti a una scodella di trippe: «Se spande intorno carga de poesia/ l’anima de le tripe, onesta e bona./ Riva el vin rosso co la so alegria/ che consola sta vita busaròna (imbrogliona)». Giorgio Gioco, cuoco e poeta (definiva il suo ristorante «un luogo di cultura con angolo cottura»), diventa un educatore davanti a una pasta e fagioli: «La pasta coi fasoi/ la fa cressar i fioi».
Fu sua l’idea del Premio letterario 12 Apostoli durante una passeggiata a Cortina con gli amici Indro Montanelli, Cesare Marchi, Enzo Biagi. All’indomani della prima edizione (1968), vincitore Nantas Salvalaggio, Paolo Monelli scrisse sul Corriere della Sera che «il premio 12 Apostoli era l’antipremio italiano, privo di dinamiche legate al denaro e ai giochi editoriali, ma ricco di quel fattore umano che lo rendeva speciale».
Di Gioco in Gioco. Da Giorgio a Giancarlo, suo parente e cuoco del ristorante Arche, incastrato nel medioevale porticato dei Montecchi che s’apriva sull’adiacente casa di Romeo. Aperto al pubblico nel 1420, è il locale più longevo d’Italia. È stato taverna, osteria, stazione di posta delle carrozze con stallaggio e alloggio per i viaggiatori, trattoria e ristorante. Giancarlo lo trasformò in ristorante di classe, laboratorio di gastronomia e cultura. Sull’albo d’oro del locale spiccano le firme di Gabriele D’Annunzio, dello scenografo Beni Montresor, degli scrittori gastronomi Giuseppe Maffioli, Vincenzo Buonassisi, Giovanni Vicentini; di Indro Montanelli, Ennio Morricone.
Il Ciopèta, in vicolo Filarmonico, vicino a Castelvecchio, esiste dal 1700. Prende il nome da un antico forno del pane dal quale uscivano le migliori ciopète de pan, coppiette di pane, di Verona. Ai suoi tavoli sedettero i tenori Franco Corelli e Carlo Bergonzi; i direttori d’orchestra Anton Guadagno, Nello Santi; il soprano Maria Chiara, il generale Carlo Alberto Della Chiesa. Luciano Cristofoli, il patron, apparecchiò anche la mensa con piatti rigorosamente veronesi per due papi in visita a Verona: Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Arte, musica, storia e magnarini tipici al Bersagliere di Leo Ramponi, ritrovo di personaggi dello spettacolo a due passi dall’Arena.
In provincia, per la posizione, le atmosfere artistiche e, ovviamente, la cucina tipica, troviamo a Custoza Villa Vento, voluto dal tenore Giuseppe Lugo, meta e santuario dei melomani (ogni anno si ricorda il cantante con un concerto). Sul colle che si affaccia sulla piana villafranchese ecco la Vecchia Custoza amata da Miguel Berrocal, Jean Mirò, Novello Finotti, Gino Bogoni, Luciano Minguzzi, che realizzavano i loro capolavori nelle vicine fonderie artistiche, per i piatti di tortelli, tortellini, lasagne, gnocchi, minestroni e carne ai ferri. Al ristorante Gardesana di Torri del Benaco, oltre alla cucina del lago e alla suggestiva vista sul porticciolo, si respirano ancora le magiche atmosfere che hanno alimentato l’amore tra Vivien Leigh e Laurence Olivier, i soggiorni del nobel per la letteratura Andrè Gide e di Maria Callas. «La grande cantante», racconta Giuseppe Lorenzini, il proprietario, «pretese un ritocco ai nostri bigoli con le sarde: ci volle l’uva sultanina di Corinto». Alla Posta Vecia di Colognola ai Colli sostarono Napoleone e Radetzky e vi aleggiano i sospiri di Silvio Pellico che vi passò una notte durante il trasferimento allo Spielberg. Rosanna Givanni, cuoca e proprietaria, è famosa per i piatti con le erbe della Lessinia, la selvaggina e le tipicità dell’est veronese: le lasagnette con i piselli nani di Colognola abbinate al Soave sono da premio Oscar.