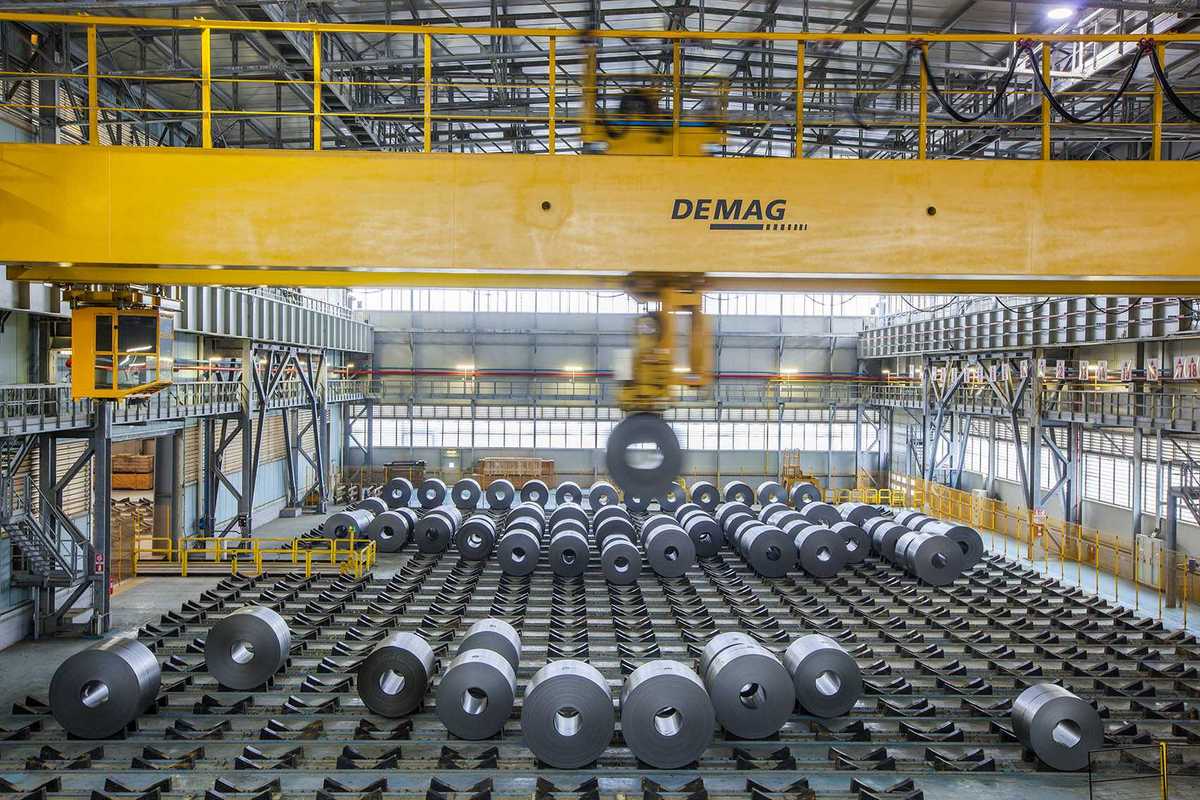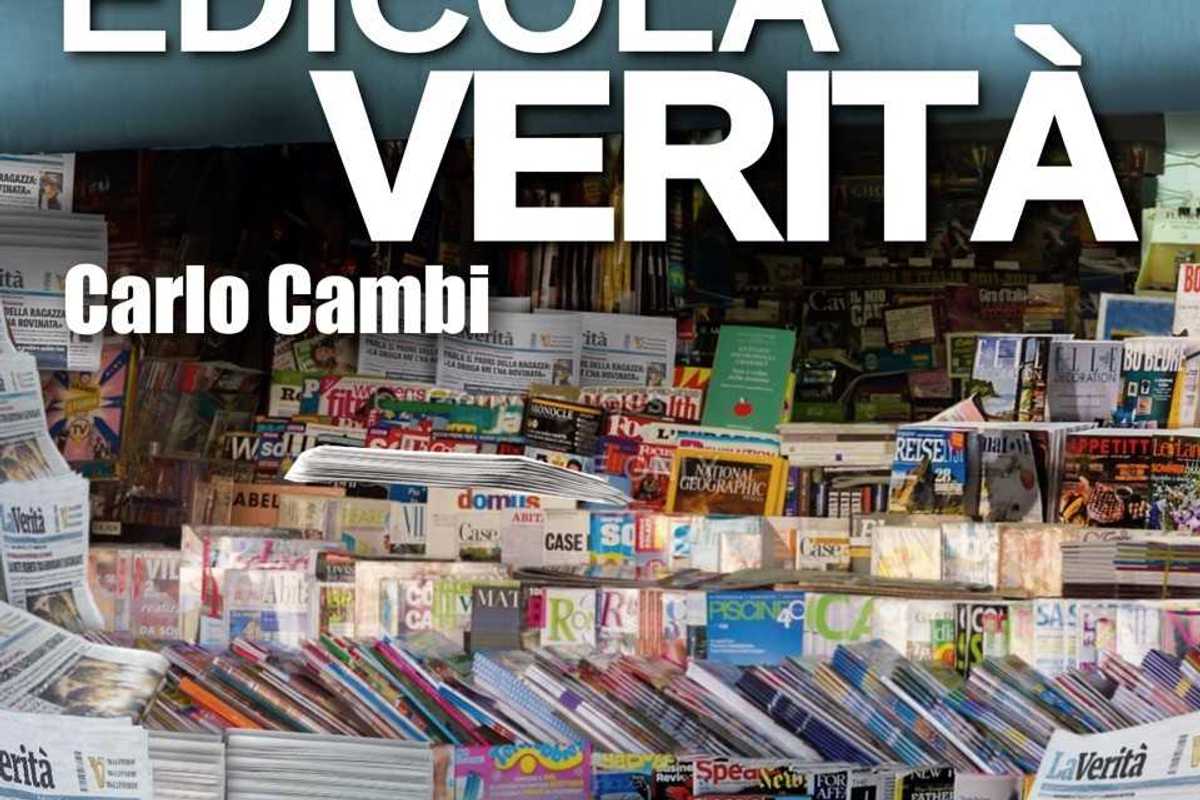«Seguendo le orme di Cristo, dopo qualsiasi inferno si possono rivedere le stelle»

Se la fede non diventa cultura, diceva Giovanni Paolo II, «è una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta». Questa sera, a Bassano del Grappa, si certifica che c’è ancora qualcuno che prende sul serio questa indicazione del papa polacco. Arrivati alla quarantesima edizione del Premio internazionale cultura cattolica, a ritirare il riconoscimento questa volta è Franco Nembrini, insegnante, divulgatore, vero educatore. Alle 20.30, al teatro Remondini di Bassano, questo bergamasco capace di trascinare nelle pieghe della Divina commedia anche il più distratto degli ascoltatori, si aggiunge a una lista che, per citarne alcuni, tra il 1992 e il 1995 vedeva premiati il cardinale Joseph Ratzinger, il cardinale Giacomo Biffi, Vittorio Messori e don Luigi Giussani.
Professor Nembrini, lei vince il Premio per la cultura cattolica 2022, ma esiste ancora una cultura cattolica oggi?
«Certo che esiste: la cultura cattolica esisterà finché esisterà un cattolico. Perché, finché esisterà una persona che vive nel presente l’incontro con Cristo, questo incontro non può non determinarne il modo di guardare la realtà: nella sua radice, la cultura cattolica è questo. Io ho imparato da don Giussani che la cultura cattolica è la consapevolezza del rapporto fra il particolare e l’universale, secondo l’esempio che mille volte ha fatto della contadina che trova nel suo campo una carota e la brandisce ringraziando Dio».
È un’immagine efficace, certamente. Però, uscendo dal campo e entrando nelle aule, nei salotti e nelle piazze, questa cultura sembra ai margini.
«Se vogliamo parlare della cultura degli intellettuali - della letteratura, della filosofia eccetera - io credo che dobbiamo uscire da una situazione in cui molta parte dell’intellighenzia cattolica si è trovata incastrata per decenni o forse per secoli: considerare la “cultura cattolica” come un sistema intellettuale compatto da contrapporre alla cultura moderna - che poi ha portato alla deriva simmetrica di intellettuali cattolici che al contrario hanno considerato loro dovere accodarsi alla cultura dominante. Ma questa non è cultura: è un’ideologia che si contrappone - o si accoda - a un’altra ideologia. Oggi attraversiamo un momento preziosissimo per la Chiesa perché è sfidata sulla fede. E, di conseguenza, sulla cultura: la situazione durissima che viviamo, la drammatica mancanza di senso in cui ci troviamo immersi, è un’occasione per noi per riscoprire il nocciolo fondamentale dell’esperienza cristiana».
Recentemente alcuni politici e uomini pubblici che si dicono cattolici sono stati definiti «ultracattolici». Non è ben chiaro cosa si intenda al proposito, ma lei si sente un po’ «ultracattolico»?
«Se devo definire me stesso, non trovo espressione migliore di quella che adoperò papa Francesco nell’intervista concessa alla Civiltà Cattolica all’inizio del pontificato, quando padre Spadaro gli domandò: “Chi è papa Francesco?”. E lui rispose: “Sono un peccatore graziato”. Certo, se la cultura è ideologia, possono esistere anche gli ultracattolici, se invece è quello che abbiamo detto prima, allora semplicemente il termine ultracattolico è privo di senso. Sarebbe come chiedere a qualcuno: “Ma tu sei innamorato o ultrainnamorato?”».
Torniamo al premio che riceverà stasera: le viene conferito per la sua appassionata attività di educatore. Come le è nata questa passione e perché?
«Come ho cercato di dire nelle tre dediche che ho messo in apertura al libro Di padre in figlio (Ares editore, venti edizioni, ndr), devo la mia passione per l’educazione in primo luogo ai miei genitori, Dario e Clementina, che mi hanno dato il sentimento della grandezza e positività della vita, che mi hanno educato proprio perché non avevano il problema di educarmi, ma di vivere la loro santità; in secondo luogo, alla mia professoressa di lettere delle medie, Clementina Mazzoleni, cui devo la passione per la letteratura e per l’insegnamento; infine, a don Luigi Giussani, che a quel sentimento e a quella passione ha dato la stabilità e la certezza della fede».
Molti la conoscono per la sua lettura e commento alla Commedia del Sommo poeta, Dante Alighieri. In questi tempi un po’ infernali le chiedo se e come riusciremo ancora a riveder le stelle.
«Certamente sì, come ho scritto nell’introduzione al racconto della Divina commedia per i ragazzi che è appena uscito per le edizioni Ares. Anzi, proprio il lavoro di questi ultimi anni sulla Commedia mi ha rinsaldato nella convinzione che il grande messaggio della Chiesa, del cristianesimo, è proprio questo: non c’è inferno da cui non si possa uscire a rivedere le stelle. Pensiamo a che cos’è stata nel secolo scorso la fede vissuta nei gulag, nei lager, oggi nei laogai cinesi: non c’è situazione, per quanto drammatica sia, che possa impedire di vivere il rapporto con Cristo, la letizia e la pace che si trovano nel rapporto con Cristo. Certo, non si tratta di un problema ideologico/politico, di domandarsi se la cultura cristiana o la dottrina sociale della Chiesa possano tornare a dare forma alla società; si tratta semplicemente di vivere la fede per sé. Come scriveva il padre di san Bernardo alla moglie (vado a memoria, non ho la citazione sottomano): “Se vogliamo riformare il mondo, dobbiamo riformare noi stessi”. Il mondo è già salvato da Cristo; seguendo Cristo, occupandoci della nostra santità, contribuiamo alla salvezza del mondo».
Leggendo l’elenco dei premiati si vede che lei è in una compagnia piuttosto importante: nel 1985 toccava ad Augusto Del Noce, nel 1995 a don Luigi Giussani, nel 1992 a Joseph Ratzinger, nel 2002 a Krzystof Zanussi… È questa la compagnia che manca oggi al mondo cattolico o c’è ancora?
«Quel che Cristo ha portato nel mondo è proprio la novità di una compagnia così, e questa compagnia non verrà mai meno anche se, in qualche momento, può essere più incerta o più osteggiata o anche perseguitata. Credo che il passo che ci è chiesto oggi sia il coraggio di essere amici, pubblicamente amici. Il male di oggi, infatti, è la solitudine, come spiega benissimo il libro di Mattia Ferraresi; ed è un male che affligge anche i cristiani, i preti, tutti. Mai come oggi è urgente riscoprire l’invocazione di Gesù al Padre, «che siano una cosa sola» (Gv 17, 21). In questo senso, credo che la scelta di don Giussani di chiamare il movimento nato da lui Comunione e Liberazione sia stata profetica: l’inizio della liberazione, l’inizio di un mondo nuovo, l’inizio dell’uscita dall’inferno “a riveder le stelle” è la comunione vissuta di coloro che sono stati afferrati da Cristo».
In che modo, oggi, i cattolici e la cultura che nasce dalla fede, come diceva Giovanni Paolo II, possono contribuire a riumanizzare il mondo?
«Beh, mi pare che quel che abbiamo detto finora risponda abbastanza anche a questa domanda. Aggiungo solo che non si tratta di voler cambiare il mondo o di combattere la menzogna brandendo la verità come un’arma con cui affrontare il nemico quasi imponendo forme di vita, leggi e pratiche “cristiane”. Si scadrebbe di nuovo nell’ideologia e nella tentazione del potere. Si tratta, piuttosto, di rendere umilmente testimonianza alla Verità, mettendo nel conto la possibilità di non essere accolti, anzi magari perseguitati. Dalla letizia anche dentro le contraddizioni e dal sacrificio vissuto per amore di Cristo la verità si farà strada e, a Dio piacendo riconquisterà i cuori di molti».