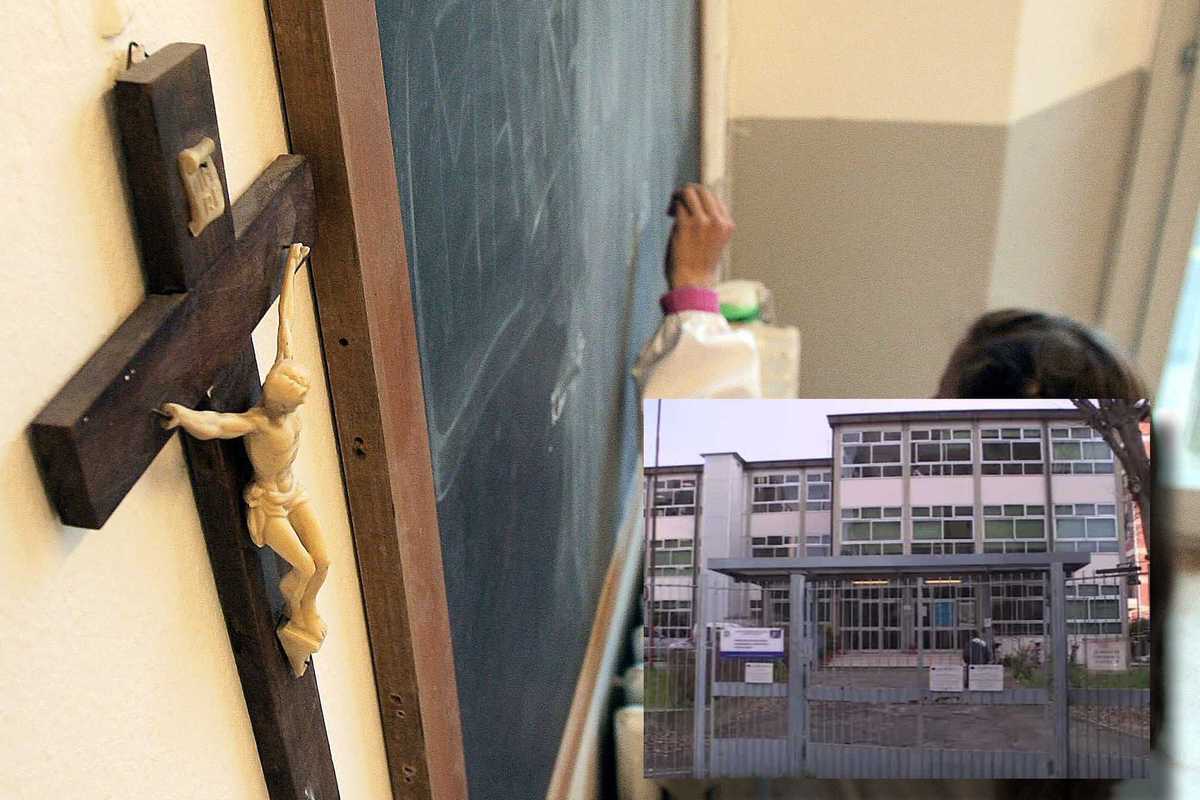Ecco una ricetta che vale come 10 ore passate in palestra a sollevare pesi: «Due fagioli, olio e limone e ti sentirai come un leone». Il proverbio che garantisce l’energia del re della savana è, con tutta probabilità, di origine toscana per i due ingredienti di quella cucina sommamente apprezzati, i fagioli e il buon olio d’oliva: «Fiorentin mangia fagioli, lecca piatti e romaioli». Il limone, terzo ingrediente, ci sta bene nella ricetta perché ci conduce a Ercole, il Rambo dell’antichità, che sottrasse dal giardino delle Esperidi i pomi d’oro identificati da molti mitologi, per il loro colore, con i limoni, figli del sole: «Il colore del limone è a due isolati dal sole», dice felicemente Fabrizio Caramagna, scrittore e collezionista di aforismi.
«El limon», recita un altro adagio, questa volta nella lingua di Luca Zaia, «va ben dapartuto». Il limone è utile in ogni situazione. In estate, mescolato all’acqua, toglie la sete; è un potente battericida, quindi disinfetta; è astringente, utile perciò in caso di diarrea; facilita il dimagrimento nelle diete; rende lucidi i capelli dopo lo shampoo. Trasformato in limonata guarisce dallo scorbuto, malattia che imperversa ancora tra coloro che hanno una dieta priva di vitamina C. Una limonata calda sbarazza lo stomaco dal peso di una difficile digestione. L’antica saggezza popolare assicura che il succo di un limone bevuto a digiuno scioglie i calcoli e le nonne avevano sempre sul comodino accanto al letto una bottiglietta di limoncello o di cedrata, stretta parente della limonata, che sorseggiava quando il cuore faceva un po’ il matto.
Da sottolineare, poi, il servizio che il limone fa in cucina. Il succo è formidabile per marinare carni e pesci. Cosa sarebbe una tartare di chianina o di scottona tagliata a coltello senza una bella spruzzata di limone e con l’aggiunta, magari, di capperi, cipolla e di un filino di aceto balsamico tradizionale di Modena? Sarebbe una polpetta di carne buona, ma qualsiasi. E un carpaccio di tonno o di pesce spada? Sarebbero buoni filetti di pesce, ma un po’ insipidi. E le zucchine alla scapece con profumo di limoni? Inodori dischetti di Cucurbita pepo. Non parliamo, poi, degli spaghetti con colatura di alici di Cetara marinate con limone. Togliete dalla marinatura il succo dell’agrume sorrentino e gli spaghetti perderebbero il sapore della Costiera Amalfitana.
Dalla cucina al bar. La ricetta perfetta di gin tonic prevede una rinfrescante fetta di limone. Magari due. Ernest Hemingway nel Bloody Mary mescolava nella vodka il succo di pomodoro con quello di limone. Provate a togliere la lunga e attorcigliata buccia di limone al Vesper Martini di James Bond e vedrete cosa vi tocca. Minimo minimo l’agente 007 vi spara. Tra un risotto allo scoglio e un secondo di carne ci sta bene un sorbetto - ma quello vero, al cucchiaio - di limone: sgrassa bocca e palato e li aiuta a cambiare marcia.
Il limone è originario dell’Oriente. Ma quale? L’Estremo o il Medio? La discussione tra studiosi è ancora aperta. Licia Granello, giornalista e brava scrittrice di cibo, sostiene la seconda ipotesi indicando anche chi fu il primo importatore: «Il frutto giallo era di casa nell’antica Persia. Quando Alessandro Magno lo vide, se ne invaghì e lo portò in Europa. Da quel momento la storia del Mediterraneo si tinge di giallo». Verrebbe invece da Milano l’espressione «limonare», verbo che appartiene al vocabolario dei morosi i quali cincischiano sempre volentieri tra loro. Pare che la voce sia stata mutuata dal grido dei vecchi venditori milanesi di limoni che quando vedevano una coppia di innamorati in un tête-à-tête tentavano il compra-due-e-paga-uno: «Cinq ghei dü limonitt», cinque centesimi per due limoni. In attesa di certezze sull’origine del giallo agrume costatiamo che il limone occidentale più vecchio è stato rinvenuto a Roma e ha 2008 anni. È riemerso nel luglio del 2016, con tanto di polpa e semi, negli scavi per la sistemazione del Carcere Mamertino. Le analisi al radiocarbonio lo hanno datato al 14 dopo Cristo, l’anno in cui morì l’imperatore Augusto. Gli studiosi spiegano che faceva parte di un’offerta votiva. E di limoni parlano Plinio e Virgilio.
Dalla storia alla geografia. Da Roma a Limone sul Garda, delizioso paesino nell’alto lago bresciano, sull’estrema costa lombarda del lago che subito dopo prende l’accento trentino. Limone, nomen omen. Nel nome il destino. C’è un magico colore giallo che illumina Limone. E non è solo il colore del sole che anche in molte giornate d’inverno fa splendere il paese, ma pure il riverbero dell’astro sulle scorze degli agrumi coltivati nelle serre che la Serenissima Repubblica di Venezia incentivò 400 anni fa con ardita lungimiranza terrazzando la montagna, sfruttando le sorgenti per l’irrigazione, portando barconi e barconi di terra fertile dal basso lago veronese e costruendo i pilastri di pietra delle limonaie che sostenevano coperture di assi e vetri per proteggere d’inverno le piante dai freddi venti del nord. Limone sul Garda è il luogo più a nord di tutto il mondo in cui si possono coltivare i limoni. Ancora adesso, nonostante un lungo periodo di abbandono dopo la Grande Guerra, si possono ammirare le limonaie (www.visitbrescia.it) che incantarono Johann Wolfgang Goethe quando il 13 settembre 1796 attraversò il Garda in un’imbarcazione a vela trasferendosi da Torbole a Malcesine. Il vento spinse la barca verso la sponda occidentale. «La mattina era stupenda benché nuvolosa, ma all’alba tranquilla. Passammo davanti a Limone i cui giardini disposti a terrazze e piantati di limoni, hanno un aspetto ricco e pulito. Il giardino è costituito da file di bianchi pilastri quadrati, che stanno ad una certa distanza l’uno dall’altro e si spingono su per la montagna ad uso di gradinata. Sopra tali pilastri sono poste delle forti travi per coprire le piante durante l’inverno. L’osservazione e la contemplazione di tali piacevoli oggetti fu favorita dalla lenta navigazione». Il ricordo tornò alla mente del poeta tedesco quando scrisse il nostalgico Canto di Mignon: «Conosci tu il paese dove fioriscono i limoni?... Lo conosci tu?/ Laggiù! Laggiù! O amato mio, con te vorrei andare!».
Naturalmente il giallo dei limoni si riverbera anche nei piatti d’alta cucina. Isidoro Consolini, cuoco gardesano della sponda veronese (al mitico Cavàl di Torri del Benàco aveva avuto la stella Michelin), ha lavorato per anni a Limone creando piatti d’alta cucina ispirati al limone e al pesce di lago. Ne aveva una quindicina che si alternavano nel menu, dall’antipasto al dolce: trota alla Gonzaga con limone e grana; spaghetti con ragù di lago profumato al limone; filetto di persico del Garda marinato al limone e finocchio; gelato alle foglie di limone...
I limoni piacciono ai cuochi e ai poeti non laureati. Come Eugenio Montale che ne I limoni snobba le piante amate dai poeti coronati d’alloro - bossi ligustri e acanti - dichiarando tutto il suo amore per i limoni e il loro profumo: «...quest’odore/ che non sa staccarsi da terra e piove in petto una dolcezza inquieta». Quando fu laureato anche lui con il Nobel nel 1975 non smise di amare i limoni: «Quando un giorno da un malchiuso portone/ tra gli alberi di una corte/ ci si mostrano i gialli dei limoni;/ e il gelo dei cuore si sfa,/ e in petto ci scrosciano/ le loro canzoni/ le trombe d’oro della solarità». Lo stesso profumo, ma più carnale, lo sente Pablo Neruda. Il poeta cileno dedica al frutto l’Ode al limone nella quale lo definisce «capezzolo profumato del petto della terra». Lo spagnolo Pedro Salinas va di notte a cercare il compiuto frutto del giorno: «Io non ti avevo visto/ giallo limone nascosto/ nell’agrumeto tra le scure foglie». I limoni dettano ricette, ma anche versi emozionanti.