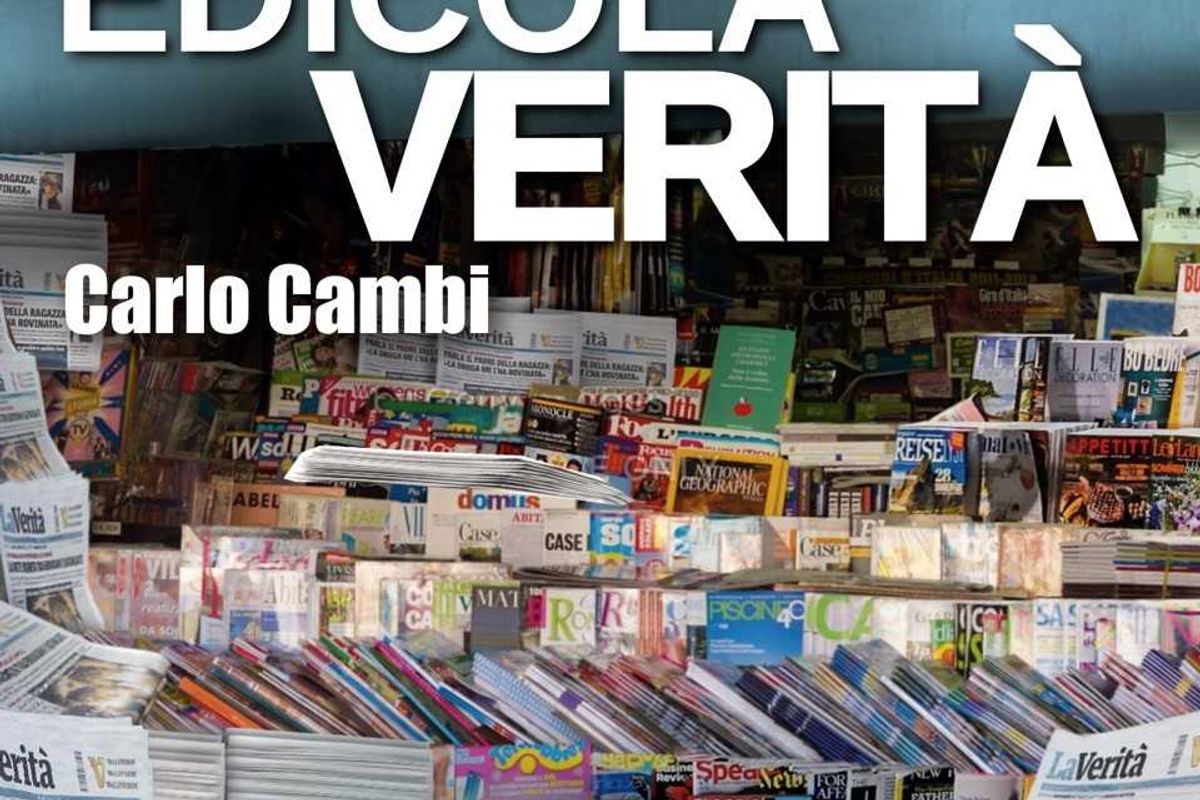2022-05-09
«Emergenza già a fine anno. Diversificare le fonti è un principio di buonsenso»
Il presidente di Nomisma energia Davide Tabarelli: «Troppo peso assegnato a sindaci ed enti locali sempre pronti a esercitare un potere di veto. La politica dei divieti è un fallimento».Il sito carbonifero del Sulcis (unica miniera attiva in Italia) è chiuso per manutenzione. I sindacati: pronti a riprendere l’attività.Lo speciale contiene due articoli.«Intensificare la produzione di elettricità da carbone è possibile anche se temo che non si possa andare oltre il 10% dell’elettricità totale dal 6% attuale. Ma ciò che mi preoccupa è il peso che finora è stato dato alle autorizzazioni ambientali locali, agli organi locali che sono sempre pronti a esercitare un potere di veto. Questo non è un Paese in cui i sindaci ragionano in un’ottica nazionale». Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, lancia il sasso: «Bisogna dare più potere all’autorità centrale e procedere alla riapertura e all’aumento della produzione delle centrali a carbone. L’emergenza era già chiara a fine anno quando i prezzi sono cominciati a esplodere. Non si può aspettare ancora».Quale è la produzione massima a cui si può arrivare mettendo a pieno regime gli impianti?«Secondo le mie stime si può arrivare a 2 miliardi di metri cubi su base annua. Dalla Russia importiamo 29 miliardi di metri cubi. Non è moltissimo, ma è la soluzione più veloce».Non salta l’obiettivo della decarbonizzazione entro il 2025?«Certo. Magari, però, di qui a breve il conflitto termina e possiamo chiudere subito le centrali a carbone. Ricordiamoci tuttavia che se ora è la Russia a metterci sotto scacco energetico, in un prossimo futuro la stessa situazione potrebbe ripresentarsi con altri Paesi, in particolare quelli del Nord Africa. Possiamo dimenticarci di Gheddafi, nel 2009 accolto in pompa magna e trucidato nel 2011?» Va fatto un accordo europeo sul riutilizzo del carbone, rivedendo le tappe della transizione ecologica o l’Italia dovrebbe muoversi in autonomia?«Il principio di diversificazione delle fonti di approvvigionamento è un principio del buonsenso, non possiamo essere dipendenti da una sola fonte. L’Europa lo ha sempre fatto. La Germania ha il 30% dell’energia elettrica che viene dal carbone, la Francia ha il nucleare, la Gran Bretagna sta riaprendo le centrali a carbone che aveva chiuso per passare al gas e nella speranza di accelerare l’utilizzo completo dell’eolico. La prima fonte di produzione elettrica al mondo è il carbone con circa il 37%. Perciò noi non facciamo nient’altro che applicare il buonsenso in attesa che arrivi qualcosa di migliore e più piacevole che possono essere le rinnovabili. Chi non vorrebbe più capacità eolica o solare? Ovvio che dobbiamo spingere anche su queste, ma possono fare poco. Dopo 40 anni di incentivi e politiche a loro favore, dopo un abbattimento dei loro costi a 50 euro per megawattora, oggi contano per 47 miliardi di chilowattora, pari a 9 miliardi di metri cubi da confrontare con i 29 importati dalla Russia l’anno scorso. Se aumentiamo, qualcosa si può fare, ma nei prossimi mesi non si arriverà a 1 miliardo di metri cubi equivalenti».E i problemi del cambiamento climatico?«L’Italia conta nel totale delle emissioni mondiali poco meno dell’1%. Se ritardiamo di qualche anno la chiusura delle centrali, non cade il mondo, l’impatto sul clima globale non è drammatico. Anzi dobbiamo stare attenti a non essere troppo distratti dal clima». L’Italia è un grande importatore di carbone.«È il nostro punto debole. Importiamo 6 milioni di tonnellate di carbone per produrre 13 miliardi di chilowattora di elettricità; di questi, 5 milioni vengono dal Russia. Sarà un problema sostituire i rifornimenti di Mosca dal momento che siamo sotto embargo. Dobbiamo andarlo a prendere altrove ma non c’è tutto questo carbone in giro e chi ce l’ha, alza il prezzo. Ecco il risultato della politica dei veti su tutto».<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/emergenza-gia-a-fine-anno-diversificare-le-fonti-e-un-principio-di-buonsenso-2657284841.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="lunica-miniera-si-trova-in-sardegna-si-potrebbero-fare-300-assunzioni" data-post-id="2657284841" data-published-at="1652079422" data-use-pagination="False"> L’unica miniera si trova in Sardegna. Si potrebbero fare 300 assunzioni «Riattivare la miniera tecnicamente è possibile, ma bisognerebbe aggirare l’opposizione degli ambientalisti e le strategie aziendali di una possibile riconversione della struttura in chiave green. Inoltre, il nostro è un prodotto che non è mai piaciuto per l’alta percentuale di zolfo contenuta. Si potrebbe mantenere una riserva fredda, cioè conservare il presidio carbonifero da utilizzare qualora si dovesse presentare l’occasione, fuori da ogni logica di mercato». Francesco Lippi è l’amministratore unico della Carbosulcis, la spa della Regione che gestisce la miniera di Monte Sinni a Gonnesa, l’ultima miniera di carbone attiva in Italia. Ora l’impianto è in uso per consentire le attività previste dal piano di chiusura, quali il ripristino dei luoghi, il recupero dei materiali dal sottosuolo e alcune bonifiche. Spiega Lippi che per riattivare l’estrazione di carbone oltre a prevedere ingenti investimenti servirebbero almeno 36 mesi tra gare d’appalto, assunzione di personale e formazione, e manutenzione della struttura. «La miniera è stata valutata con un potenziale estrattivo fino a 100 milioni di tonnellate di carbone», dice. «Allo stato le gallerie esistenti consentirebbero l’estrazione di circa 20 milioni di tonnellate, ma occorre ricordare che nel recente passato l’Enel, unico cliente possibile con la vicina centrale di Portovesme e unico autorizzato dal governo ad acquistarlo sul territorio sardo, non ha ritirato più di 200.000 tonnellate di prodotto annuo, in quanto lo considera non all’altezza delle necessità produttive». E il sindacato cosa dice? «Riattivare la miniera del Sulcis significherebbe una risorsa in più per il Paese e più posti di lavoro per la Sardegna. Potrebbero essere assunte da 200 a 300 persone»: Emanuele Madeddu, segretario territoriale della Filctem Cgil, è convinto che la miniera sarda debba essere riaperta. L’attività estrattiva è terminata il 31 dicembre 2018 dopo che per due secoli ha segnato la storia della Sardegna tra picchi di lavoro e gravi crisi. Nella prima metà del Novecento il carbone del Sulcis ha rappresentato il tentativo di indipendenza energetica, con il comune di Carbonia fondato nel 1937 dal regime fascista per accogliere i minatori. Ma già negli anni Sessanta si chiuseno le prime cave e cominciarono le grandi proteste sindacali. L’Enel nel 1965 divenne titolare della miniera di Seruci, la più importante del bacino del Sulcis, ma di lì a breve frenò la produzione perché considerata poco redditizia. A questo si aggiunsero le leggi sull’inquinamento che misero il carbone sul banco dei nemici dell’ambiente. Nel 2012, dopo anni di conflitti sindacali, le perdite ammontavano a 48,5 milioni di euro e due anni dopo si decise un piano di chiusura approvato dalla Ue. Entro il 2027 si deve concludere il processo di messa in sicurezza. Nel frattempo sono partiti piani per la riconversione della miniera, come il progetto Aria per la distillazione dell’argon 40, elemento chimico utilizzato nella diagnostica medica avanzata. «Questo progetto ad alto contenuto tecnologico potrebbe convivere con la miniera a carbone», afferma Madeddu. «Il processo di chiusura andrebbe ridiscusso con la Ue e bisognerebbe riorganizzare l’attività. Ora i lavoratori, un centinaio, gestiscono l’operatività propedeutica alla chiusura. Servirebbero nuove assunzioni e formazione. Questo giacimento rimane risorsa strategica da salvaguardare». E i no degli ambientalisti? «Siamo il Paese delle contraddizioni. Si bloccano le trivellazioni nell’Adriatico per acquistare gas dalla Russia».
Uomini del battaglione Azov (Ansa)
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 12 novembre con Carlo Cambi