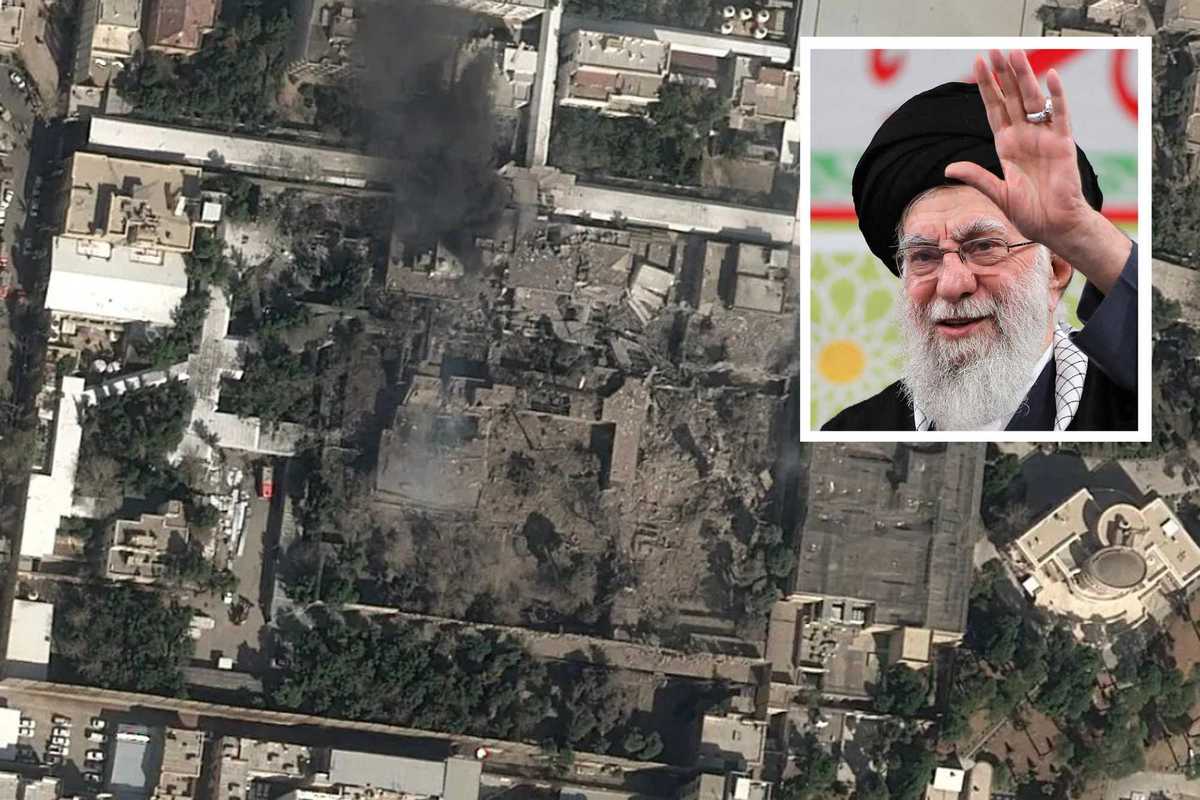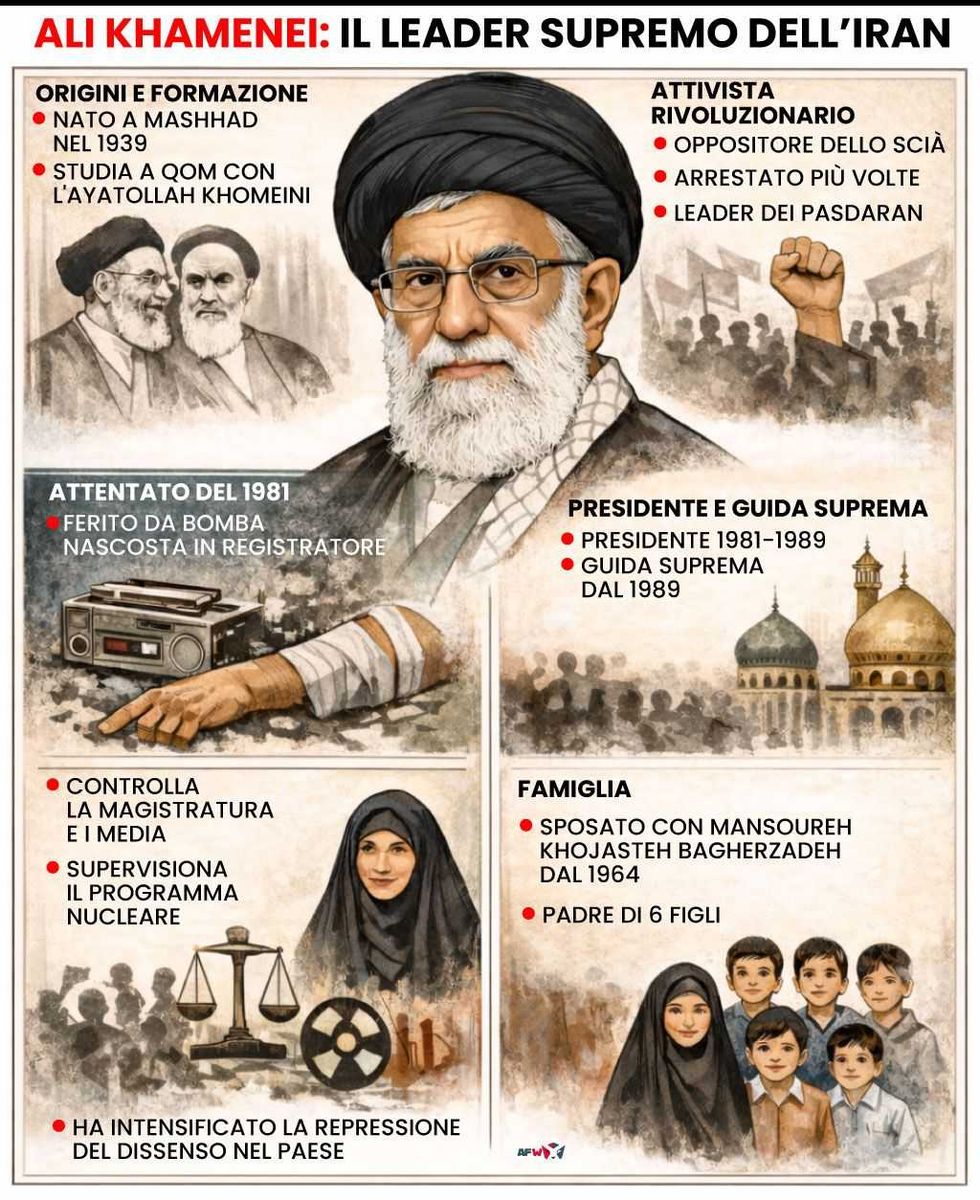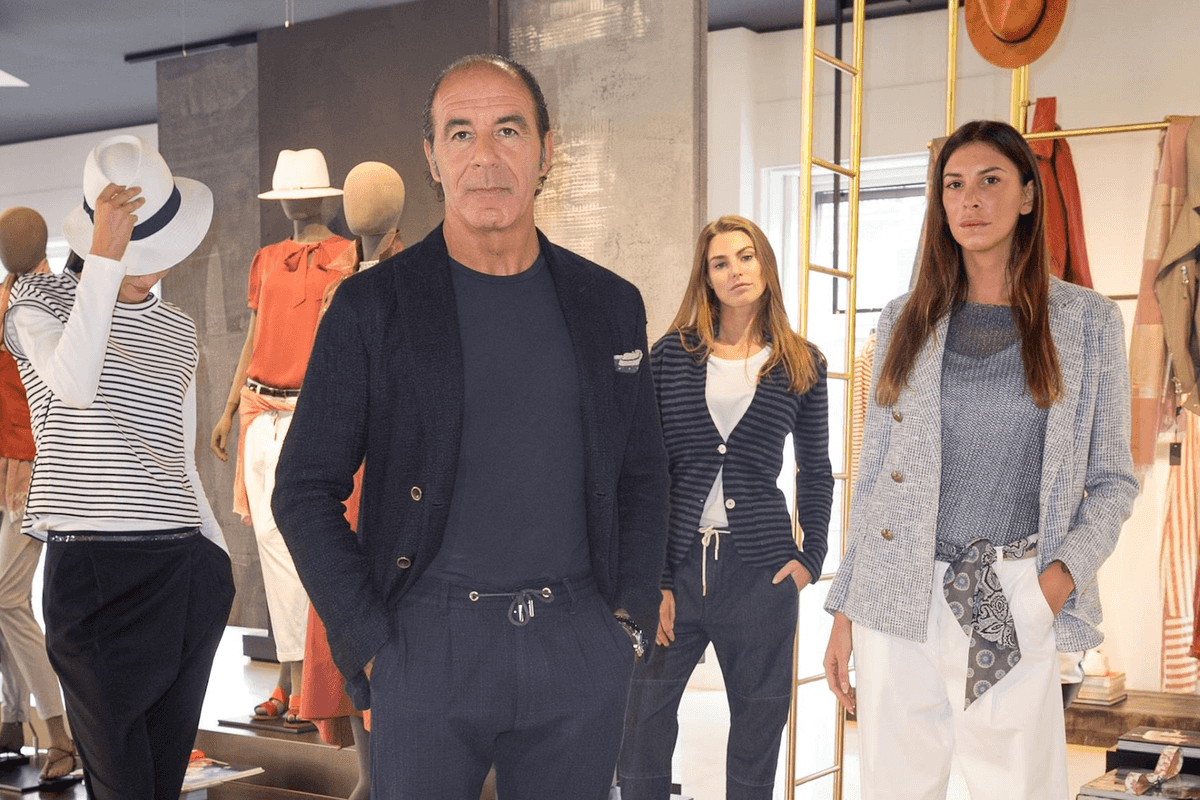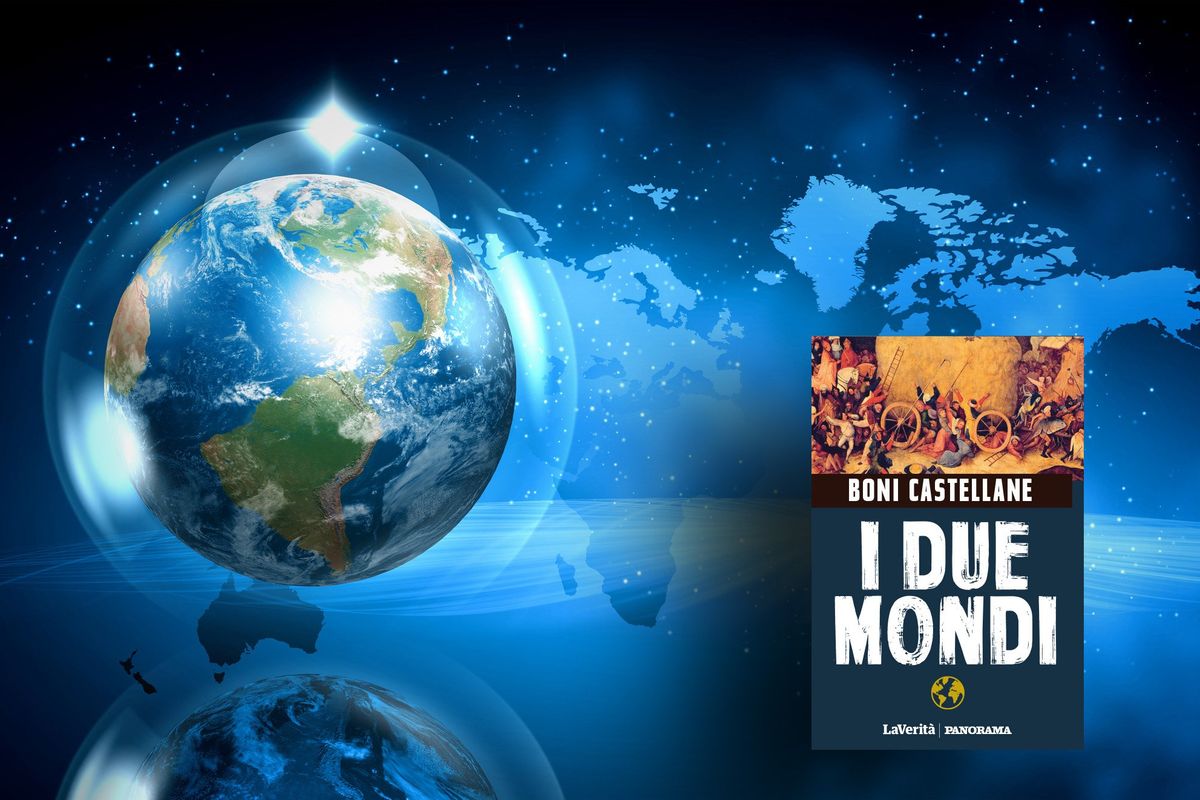
Chiamati a vivere un cruciale momento di passaggio, la fine del Novecento, ci troviamo come a percorrere la lettura dei fatti che ci troviamo di fronte, a riflettere sulla rivoluzione antropologica che sta investendo il mondo. Uscire dalle forme stabilite, soprattutto da quei canoni che governano la saggistica, diventa un atto di necessità, di ribellione contro la narrazione che ha smesso da tempo di parlare del mondo, preferendo invece indugiare su soggetti che si rivelano insignificanti, forse per decadenza, forse per preciso calcolo, forse per inconfessabile pudore. La narrativa, che un tempo era un faro della conoscenza e dell’introspezione umana, oggi non ha più possibilità di liberarsi; è già prigioniera di un discorso che non tace mai, un flusso incessante di immagini e testi che si sovrappongono, creando un mosaico di trasparenze che, paradossalmente, rende opaco ciò che è stato detto solo poche ore o minuti prima. Questo posarsi di fogli trasparenti, uno sull’altro, somma trasparenza a trasparenza, generando un’oscurità che nasconde più di quanto non riveli. È come se ci trovassimo in un patto di lucidità tra il male e la sua intelligenza, dove la comunicazione digitale, sempre online e in continuo aggiornamento, diventa l’unica voce che si sente, seppellendo le occasioni di disvelamento sotto un incessante flusso di informazioni. La parola scritta, che un tempo attingeva significato da fonti profonde, ora si nutre dei social, diventando essa stessa parte di quel flusso che si arricchisce delle reminiscenze di linguaggi morti al nascere e che rispondevano a codici esclusivi, da setta, da club, da salottino letterario. Lì gli operatori della parola scritta indossano la maschera dello scrittore, dell’intellettuale, del funzionario culturale, in un gioco di specchi che saluta per sempre Teeteto e che rende la maschera l’unico accessorio di verità. Eppure, in questo scenario, Friedrich Nietzsche sembra aver anticipato tutto con la sua forma aforistico-discorsiva, forma che trova oggi eco nei social, contraddizioni incluse. A lui si guarda ancora per cercare di dire le cose, soprattutto in questo momento di estrema gravità, dove il pericolo è più vicino, e così anche ciò che può salvarci. Ma ciò che salva è nascosto, richiede occhi capaci di vedere oltre l’apparenza, di tenere alte le fiaccole della conoscenza, senza meriti se non quello di adempiere al proprio destino, senza colpe se non quella di ripetere ciò che molti dicono a bassa voce. Dopo la terra ostile, che non cessa di esserlo, esistono due mondi e ciò che qui si cerca di articolare è che tra le tante cose invisibili e poco chiare, ve ne sono alcune che fungono da chiavi per comprendere il resto. Una di queste chiavi è la terra ostile stessa, l’altra la coscienza dell’ineluttabilità dei due mondi; altre chiavi verranno e di altre sarà necessario parlare. Questo è un tentativo di preparare il terreno per comprendere che i due mondi non sono altro che l’esito della terra ostile, la sua ricaduta allorché i disegni del nemico non si siano realizzati. Se la loro vittoria fosse stata completa, se avessero raggiunto ciò che si erano prefissi venticinque anni fa o più, allora la terra ostile si sarebbe ristretta, rimpicciolita sino a soffocare gli ultimi sopravvissuti. Ma così non è stato, qualcosa non è tornato nei conti da garzoni che si erano fatti: una parte di umanità si è mostrata irriducibile al progetto di trasformazione radicale e sono nati così i due mondi, quello del gregge degli entusiasti e quello di coloro che non hanno potuto distogliere gli occhi dalla lama mentre veniva brandita. Per capire tutto questo, bisogna immergersi nel flusso di quella che è la nostra esistenza contemporanea, dove ogni parola, ogni immagine, ogni tweet, ogni post diventa parte di una narrazione più grande, una sinfonia caotica che cerca di dare un senso all’insensato. Se ci fermiamo a osservare, vediamo come la nostra vita quotidiana sia ormai intrecciata con questa rete digitale, dove ogni connessione, ogni like, ogni commento aggiunge una nota a questa sinfonia, una modulazione allo strano incedere di un’armonia che mai avevamo sentito prima. E in questo contesto, il nostro compito come custodi della parola e del pensiero, è di non perdere la capacità di discernere, di distinguere tra l’effimero e l’eterno, tra ciò che è vero e ciò che è solo un riflesso distorto della verità. Ma non per moralità o «senso del dovere», ancor meno per sentirsi buoni cittadini o membri integrati di un sistema che ci mastica per digerirci; semplicemente perché noi non abbiamo potuto fare a meno di riconoscere come il dato di realtà sia tale, che il sole sorge, che l’erba è verde e che una mela è una mela. Non avevano previsto che portandoci qui avrebbero risvegliato le ultime facoltà dormienti che ci trascendono, quelle che ci tengono in accordo con il mondo, quell’istinto a risvegliarsi nella parte più insopportabile dell’incubo. Se una sola riga di I due mondi riuscirà a piacere, allora il compito sarà stato compiuto, come un seme gettato nel vasto campo, un seme che, con cura e attenzione, potrebbe germogliare in una comprensione più profonda del nostro tempo e dei due mondi che abitiamo. Basta anche solo un attimo di esitazione.