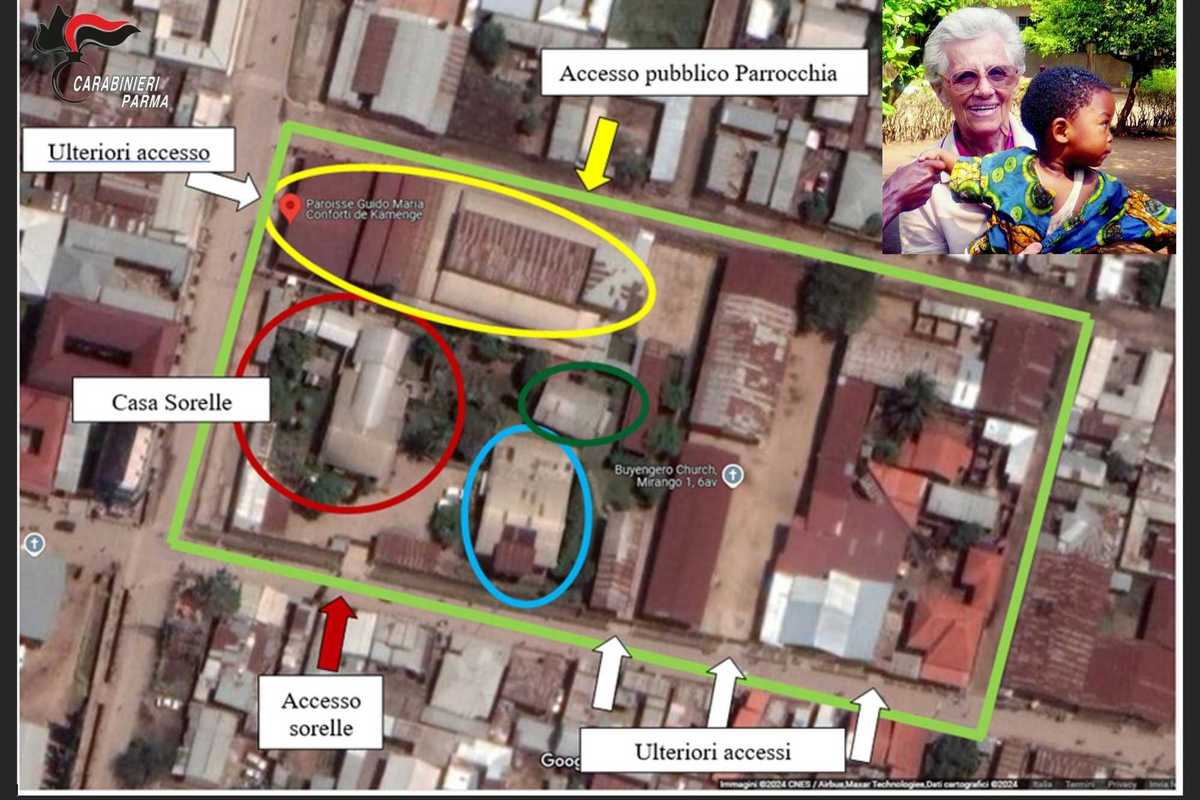Vi sono dei protagonisti del Novecento che hanno lasciato testimonianze della loro genialità inventiva divenute pietre miliari della nostra storia. Opere giunte a noi che diamo per scontate da quanto sono entrate nella nostra quotidianità. Citare Miss Italia, icona di bellezze longilinee che appaiono lontane da pacciade (scorpacciate) golose sembra apparentemente non centrare nulla con il mondo culinario, ma scopriremo che un legame c’è, assieme a prodotti iconici delle festività natalizie, il panettone, o pasquali, la colomba. Il Dna è comune e recita Dino Villani, nome che dirà poco o nulla ai più, ma che andiamo a scoprire, con pieno merito.
Mantovano verace, nasce in terra veronese, a Nogara, un giorno dopo il Ferragosto 1898. Papà capostazione delle regie ferrovie. Dopo qualche anno, la famiglia tornerà alle origini in quel di Suzzara, sulle rive del grande fiume, il Po. Il giovane Dino, riformato dal servizio militare per una malattia giovanile, si avvia alla carriera ferroviaria, sostituto dei coetanei spediti al fronte della Grande guerra. Per successione dinastica già lo vedono capostazione, ma qualche anno dopo, per non aver aderito alle regole del nuovo ventennio, verrà licenziato in tronco. In uno dei suoi scritti, divenuto famoso come meritava il suo talento, ebbe a commentare «dovrei ringraziare chi mi ha fatto licenziare dalle ferrovie poiché fuori ho potuto fare quello che, come ferroviere, non mi sarebbe mai riuscito».
Giunto a Milano per occuparsi di pubblicità e comunicazione, un crescendo rossiniano. Nel 1934 viene ingaggiato da un piccolo fornaio che vuole scalare le vendite, Angelo Motta. Con una felice intuizione tradotta graficamente da tale Sepo, al secolo Severino Pozzati, Dino Villani crea le premesse perché il panettone meneghino diventi il simbolo del Natale a tutto stivale. I numeri premiano lo sforzo suo e del Motta diventato imprenditore, da piccolo artigiano qual era. Ma ad ogni investimento, di macchinari e maestranze, deve seguire un ritorno conseguente. Nasce così la colomba pasquale, che vola nelle vendite affiancando il tradizionale uovo al cioccolato. La ricetta promozionale è del Dino mancato ferroviere, la realizzazione grafica di un francese di origini ucraine, Adolphe Jean Marie Muron, più sbrigativamente Cassandre per tutti. Niente male per chi vuol promuovere sogni che poi diventino realtà.
Angelo Motta è felice, il suo nome conosciuto dalle Alpi agli Appennini e dintorni, ma Villani è un torrente in piena «un curriculum di invenzioni ed iniziative pari al medagliere di un condottiero vincitore di mille battaglie», come dirà di lui un compagno di molte avventure, il veronese Giorgio Gioco, patron del leggendario Dodici Apostoli. Era consuetudine che, al termine di ogni tappa del Giro d’Italia, lo sponsor Motta regalasse un panettone per ritemprare le forze del Bartali o Coppi di turno. Ma troppe volte la gazzetta rosa e colleghi di cronaca ritagliavano le foto e il panetùn scompariva. Che fare? Elementare Villani. Si regala un panettone peso massimo, cioè dodici chili. Era come avere Ave Ninchi al posto della miss di turno. Impossibile sbianchettarla. A proposito di miss. Dino Villani inizia a collaborare con la nota casa farmaceutica Carlo Erba, che avvia una linea di produzione di dentifrici in un’Italia che dell’igiene orale aveva un’idea molto vaga. Come stimolare l’aspirazione ad avere bei denti a prova di sorriso splendente? Nasce «5000 lire per un sorriso». Giovani donne di belle speranze, quelle realmente della porta accanto non pescate dai camerini di Cinecittà, inviano foto dei loro sorrisi. Rispondono in migliaia. Solo la guerra porrà fine, nel 1942, alla terza edizione che a conflitto terminato riprenderà a passo di carica, ribattezzata Miss Italia. È sotto la presidenza di Dino Villani (che la passerà a Enzo Mirigliani nel 1958) che indossano le fasce di bellezza tricolore le fino ad allora sconosciute Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Lucia Bosè. Basterebbe questa trilogia di citazioni, mottensi e dolciarie, come di bellezza femminile, per riassumere l’impronta lasciata al futuro di Dino Villani.
Ma questa è solo la vetrina, dietro c’è molto altro. Una valorizzazione di storie e tradizioni a matrice gastronomica, quella che viene anche definita cultura materiale, base della nostra identità nazionale e locale.
Innumerevoli gli scritti, le iniziative a testimonianza di questa autentica missione a trazione golosa per cui Dino Villani si è speso per una vita. Il pane, per noi, è dato per scontata presenza sulla tavola, ma non era sempre stato così. «Il pane, un tempo, era fatto con farina di crusca, sostituto più sostanzioso della polenta. Il pane bianco è arrivato dopo e in campagna lo portavano in tavola una volta alla settimana», ossia la domenica. Con l’arrivo del benessere il pane, da prodotto di manualità e forno domestico, sull’orlo di diventare anonimo dai grandi numeri industriali, con la conseguenza «che stiamo arrivando a non sentire più il gusto della farina di grano autentico, in gran parte perduto perché i veloci mulini a cilindro, che avevano sostituito le mole di granito, bruciavano gli olii essenziali che davano profumo e sapore alla farina, una farina svuotata della sua fragranza». Premonitore di un ritorno alle origini che arriverà qualche decennio dopo.
Nelle terre della pianura padana la polenta era dominante, il vero pane quotidiano. Colazione del mattino, abbrustolita in abbinamento con quanto passava la stagione. Dal pesce sottosale, salacca, rosolato al fuoco, così come nelle rigide albe invernali assieme ad un battuto di lardo e, nei giorni seguenti alla mattanza suina, qualche costicina cotta alla brace. Nella pausa del lavoro nei campi o nella stalla il pranzo del mezzogiorno, dopo la rituale minestra, trovava rinforzo nella rassicurante polenta ammorbidita da un po’ di intingolo trasudato dalla poca carne a disposizione.
Grande festa con la polenta pasticciata. Un autentico rito con la cabina di regia materna «che la condiva dopo averla versata un po’ molle nella zuppiera ed aver sparso su ogni strato qualche cucchiaiata di sugo preparato e stufato con un po’ di carne». Riemerge lo spleen dell’infanzia in quel di Suzzara «Se ne avanzava un po’ - e ogni mamma era abilissima nel farlo, la sera - la mattina la trovavamo arrostita in padella, e noi ragazzini battevamo i piedi contenti cercando di accaparrarci dove c’era il condimento con i pezzettini di carne o il lardo ben rosolati». Polenta preparata mescolandola lentamente nel paiolo appeso al focolare. Il giorno dopo qualche crosticina di polenta la si trovava sempre residua sul fondo di rame, ed era leccornia croccante, altro che le caramelle della modernità. Polenta ecumenica, in famiglia, per bambini dalla dentatura tutta da sviluppare come nonni tornati bambini, con il problema inverso. Ma anche come segno di generosa sussidiarietà. «Molti chiedevano l’elemosina per le case e ricevevano quasi sempre una fetta di polenta. Spesso tornavano a casa con la scorta per due tre giorni». Era un tempo in cui la farina gialla, quella per la polenta, costava meno di quella bianca, ovvero per il pane. Nelle campagne di allora «le donne andavano a coltivare il granoturco al terzo», cioè due terzi del raccolto per il proprietario, e il resto per chi lo lavorava. Donne e mamme generose «che per non togliere nulla alla famiglia, andavano nei campi all’alba o sotto il sole cocente».
Era anche questa l’Italia che Dino Villani, adoperandosi per una vita, in settori diversi, ha saputo portare a godere delle varie bellezze del boom economico, da Miss Italia al panettone, passando per la colomba.