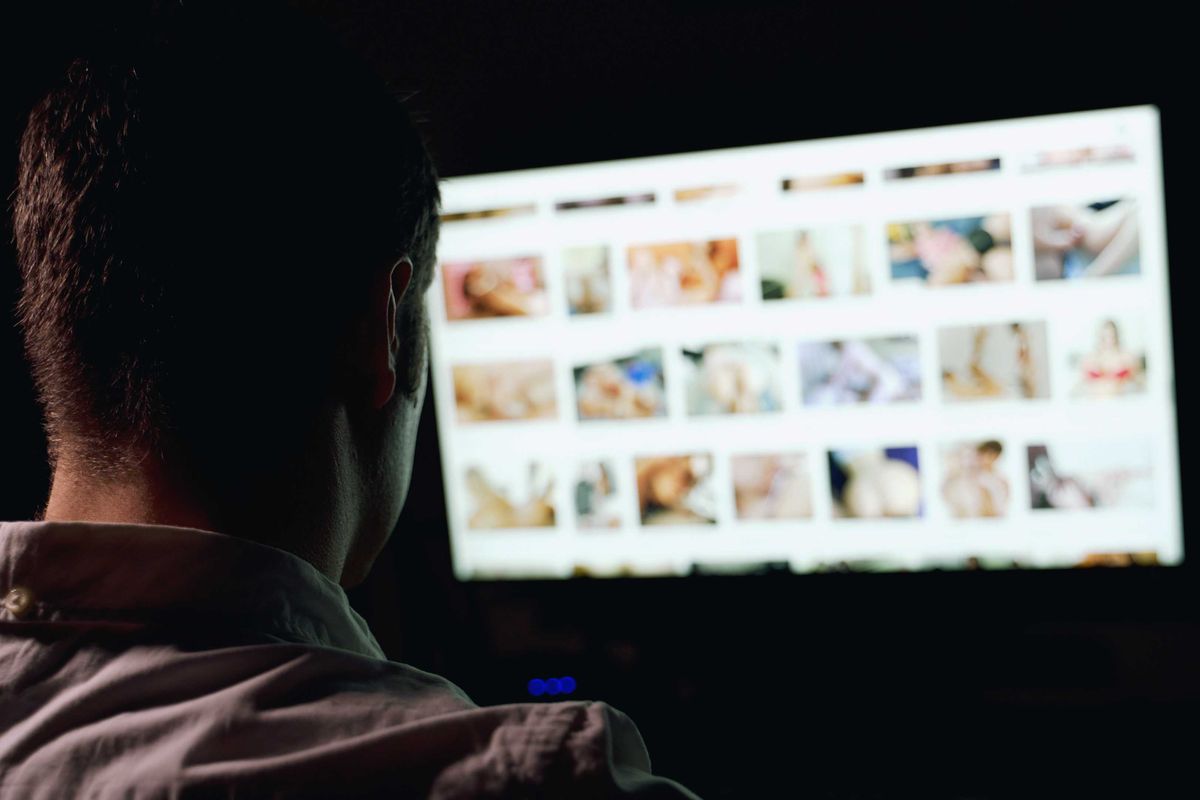2024-04-25
Quando De Felice ruppe il tabù: «La Resistenza non fu movimento di massa»
True
In uno dei suoi ultimi libri, Rosso e Nero, lo storico reatino demoliva la vulgata sulla seconda guerra mondiale, ma avvertiva: «Occhio al nuovo kitsch politico di destra e di sinistra».Morto il 25 maggio del 1996, lo storico Renzo De Felice visse, negli ultimissimi anni della sua vita, un momento di improvvisa notorietà, coincidente con l’arrivo al governo della destra post-fascista, nel 1994. Furono due anni di fuoco per lo studioso reatino, che già da anni era al centro delle polemiche accademiche per la sua biografia, via via sempre più «revisionista», di Benito Mussolini, ma che alla metà degli anni Novanta divenne un vero e proprio vip, quasi fosse il nume tutelare di Alleanza nazionale. De Felice si ribellò a quel cliché, ma allo stesso tempo cavalcò quell’improvvisa notorietà con una certa maestria, dispensando interviste e interventi sui grandi media di massa senza lesinare provocazioni. Frutto di quella breve stagione è un libretto che costituisce una delle ultime pubblicazioni di Renzo De Felice. Parliamo di Rosso e Nero, libretto intervista con Pasquale Chessa in cui lo studioso faceva il punto su varie questioni scottanti del dibattito politico e storiografico: la Resistenza, la Rsi, il consenso al fascismo, quello all’antifascismo, etc.Nell’introduzione, De Felice faceva il punto sullo stato dell’arte in fatto di storiografia. Scriveva: «Una “vulgata” sta morendo, con buona pace dei suoi superstiti sostenitori ed epigoni, ma se ne sta sostituendo giorno dopo giorno un’altra, in parte diversa, ma altrettanto refrattaria alla verità storica e probabilmente altrettanto perniciosa. Ché se la vecchia tendeva a squalificare e invalidare alcune verità a tutto vantaggio dell’esaltazione e della legittimazione di una “vulgata” politica di comodo, la nuova par di capire tenda a legittimare le une e le altre in funzione di un immobilismo politico e culturale che - come in passato - ignori le esigenze di una società veramente moderna ed escluda un’effettiva partecipazione di larghissimi settori della popolazione, non mediata dal “vecchio” solo formalmente messo a nuovo».Da queste parole traspare non solo la volontà di De Felice di mandare in soffitta la vecchia vulgata antifascista, ma anche l’insoddisfazione per le banalizzazioni caratteristiche della nuova epoca. Aggiungeva infatti lo storico: «Eloquenti sono al proposito i recenti cambiamenti di atteggiamento di Alleanza nazionale rispetto all’antifascismo e del Partito democratico della sinistra rispetto all’anticomunismo. Due “svolte” che hanno in comune l’assenza di qualsiasi giustificazione storica e razionale e il desiderio di far leva strumentalmente su una sorta di emotività politica, determinate dalle vicende post-caduta del muro che, mancando di qualsiasi giustificazione critica, non vanno oltre il “kitsch politico”».Per quanto sia quindi sbrigativo attribuire a De Felice un’organicità agli assetti nati con la seconda repubblica, resta comunque il fatto che le bordate lanciate nel testo al mito della Resistenza sono micidiali. Tanto per cominciare, lo storico ha chiarito che durante la liberazione d’Italia, «l’aggettivo “decisivo” può essere attribuito esclusivamente al ruolo dell’esercito di Sua Maestà Britannica e degli Stati Uniti d’America». Il che portava lo studioso a conclusioni lapidarie: «Contrariamente a quanto ha sempre sostenuto la vulgata filoresistenziale, soprattutto comunista, non è possibile considerare la Resistenza un movimento popolare di massa: il movimento partigiano si fece moltitudine pochi giorni prima della capitolazione tedesca, quando bastava un fazzoletto rosso al collo per sentirsi combattenti e sfilare con i vincitori»Questo rapporto di subordinazione dei partigiani agli Alleati aveva un ben preciso riscontro economico. Ricorda De Felice: «Rompere con gli Alleati, per la Resistenza, era impossibile: sarebbe stata la catastrofe economica (lo stesso Parri, in un suo Memoriale sull’unità della Resistenza, scritto nel 1972, ricorda che la prospettiva era quella di “chiudere bottega”) […]. Gli Accordi di Roma portarono alla Resistenza 160 milioni. Fu la salvezza. E Harold MacMillan, responsabile in loco della politica inglese nel Mediterraneo, poté scrivere nelle sue memorie il feroce e soddisfatto commento: “Chi paga il suonatore decide la musica”». Un concetto che aveva applicazioni molto concrete: «Gli Alleati sapevano di avere in mano le carte migliori: la forza militare e gli aiuti economici. Si poteva, per esempio, prendere la Resistenza per la gola e ridurla a più miti consigli minacciando di tagliare aiuti e sovvenzioni. Se per mantenere un partigiano, alla fine del 1943, servivano mille lire, agli inizi del 1945 ne costava 3 mila e anche 8 mila, nelle zone più dispendiose […]. Bisognava razionalizzare il sistema dei finanziamenti al di là delle sovvenzioni degli industriali, che però man mano che il tempo passava avevano sempre più paura dei tedeschi, e degli aiuti dei servizi segreti inglesi e americani. Fu questo il capolavoro di [Alfredo] Pizzoni. I soldi degli Alleati arrivavano a Milano dal Sud passando per la Svizzera».Passata, grazie ai bombardamenti alleati, l’urgenza militare, l’antifascismo si rivelò per quello che era e che sarebbe stato fino a oggi: un grande affare: «Arrivata la vittoria», ha scritto De Felice, «il cemento dell’unità fu la spartizione dei nuovi poteri (“il sindaco a te, il prefetto a me, il questore a loro”) man mano che liberavano Bologna, Genova e poi Torino, Milano…».Parole che riescono a spiegare bene la ferocia degli attacchi che accompagnarono gli ultimi anni di vita dello storico.
Renato Mazzoncini, ad di A2a (Imagoeconomica)
Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara (Ansa)