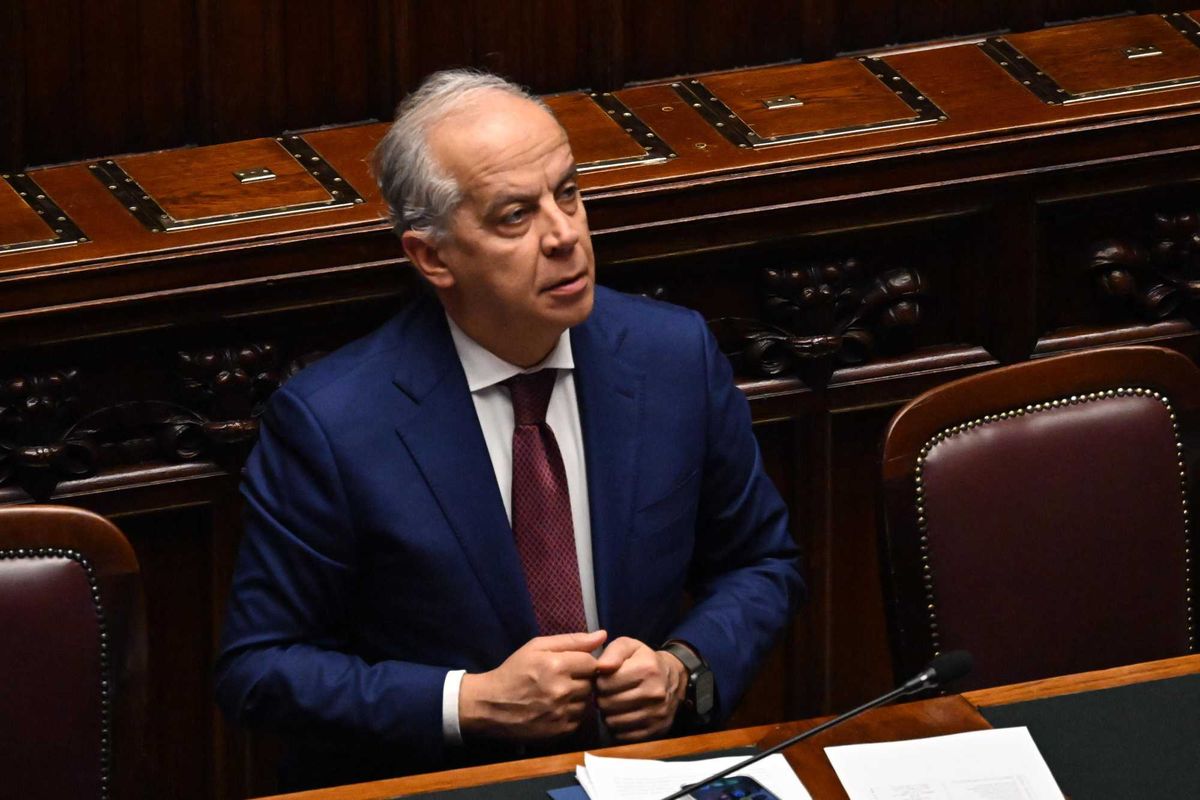Se è vero che siamo in un cul-de-sac storico, caratterizzato dalla transizione da un assetto mondiale modellato sugli Stati-nazione e sulle loro Costituzioni, a un assetto modellato sugli Stati-continente (America, Asia, Europa, resto del mondo), le dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa dalla presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra sembrano seguire docilmente la scia. In una recente intervista concessa a La Repubblica, la presidente della Consulta ha sostenuto con convinzione «l’indiscutibile supremazia del diritto comunitario su quello nazionale», perché «la nostra è un’unione di Stati e deve reggersi su questo collante». Contano di più, insomma, le leggi stabilite dal diritto europeo, in perfetta linea con i dettami politici della neonata Confederazione europea che vorrebbe soppiantare l’impalcatura stessa della vecchia Ue, limitata e costretta - a detta dei soi-disant modernizzatori - dai veti, dal voto all’unanimità e dalle istanze nazionali che alcuni Stati periodicamente osano opporre.
Sono vent’anni, in effetti, che l’Unione si avviluppa intorno al potere del Consiglio Ue, che vorrebbe rappresentare l’Unione ma al tempo stesso ognuno dei suoi singoli Stati membri, cercando di conciliarne le prerogative. E sono altrettanti anni che l’Ue chiude un occhio di fronte a qualche Stato, più uguale degli altri, che riesce a far prevalere il proprio diritto nazionale. Il principio di «supremazia del diritto europeo», insomma, è valido a correnti alternate e non è così «indiscutibile» come sostiene Sciarra: ci sono Stati che fanno valere la propria sovranità nei confronti del potere europeo, a cominciare - esempio più recente - dalla Polonia. «La Corte polacca nel 2021 ha avuto un gesto di totale ribellione nei confronti della supremazia del diritto europeo», ha segnalato Sciarra. Peccato però che quel gesto sia stato digerito senza colpo ferire dall’Ue di Ursula von der Leyen, in nome di quella ragion di Stato che ha fatto della Polonia, confinante con l’Ucraina, una nazione geopoliticamente cruciale in tempi bellici, non soltanto per l’Unione europea ma soprattutto per la Nato. È per questo motivo che l’Ue ha dovuto accettare non soltanto il «colpo di mano» sulla magistratura, ma anche la rivolta di Varsavia contro le politiche vaccinali Ue, decise sopra la testa dei Ventisette da von der Leyen insieme con l’amministratore delegato Pfizer, Albert Bourla: «Non compreremo più vaccini», ha decretato la Polonia, trascinando con sé altri nove Paesi della stessa area geografica.
Anche l’Ungheria di Viktor Orban sta giocando la sua partita con l’Unione, tergiversando sull’erogazione dei fondi per le armi destinate all’Ucraina con l’obiettivo di ottenere i finanziamenti bloccati da Bruxelles in nome del meccanismo dello Stato di diritto. Se non ci fosse stata la guerra di mezzo, Varsavia e Budapest l’avrebbero pagata cara, così come la pagò cara Joerg Haider, regolarmente eletto nel 1999 e oggetto di contestazioni in Europa e Israele: dopo il suo arrivo al governo, l’Austria fu sottoposta a sanzioni dall’Unione, revocate repentinamente qualche mese dopo. «L’Ue può fare a meno dell’Austria», dichiarò improvvidamente l’allora ministro degli esteri belga Louis Michel. Ma le prove di forza tra Bruxelles e gli Stati nazionali vanno a giorni alterni: la Germania nel 2012 ha inserito clausole nella legge di ratifica del Mes unanimemente accettate e ha vinto la partita; ed è sempre la Corte costituzionale tedesca di Karlsruhe ad aver dichiarato parzialmente incostituzionali i programmi di Quantitative easing della Banca centrale europea attuati dopo il 2015, quelli approvati sotto la presidenza di Mario Draghi. La sentenza ha sancito che l’attuazione del Qe non rispetta i criteri di proporzionalità e adeguatezza rispetto ad altri ambiti del sistema tedesco, con particolare riferimento al bilancio pubblico e al risparmio, che sarebbero penalizzati dai bassi tassi d’interesse.
Gli esempi recenti non sono gli unici: la più eclatante inadempienza è stata esercitata nei primi anni Duemila da Francia e Germania, Paesi fondatori dell’Ue: i due Stati registravano deficit eccessivo, ma la procedura d’infrazione prevista dal Trattato di Maastricht non venne applicata. All’Italia non fu riservato lo stesso trattamento: il rialzo dello spread venne considerato una patologia irreversibile del nostro Paese, e portò Silvio Berlusconi alle dimissioni e alla caduta del suo governo a novembre del 2011. Ma quando l’anno successivo, a fine luglio del 2012, anche il governo di Mario Monti oltrepassò i 500 punti di spread, Bruxelles non fiatò.
Di un diritto europeo prevalente soltanto nei giorni dispari se n’è avuta ulteriore prova ad agosto 2021, quando fu introdotto il green pass: ai cittadini che presentarono richiesta per procedura d’infrazione contro l’Italia, che applicava obbligo di green pass anche ai minori e si apprestava ad estenderlo a tutti i lavoratori, la Commissione rispose pilatescamente che la questione «non era di sua pertinenza» e atteneva alla sovranità nazionale dell’Italia.