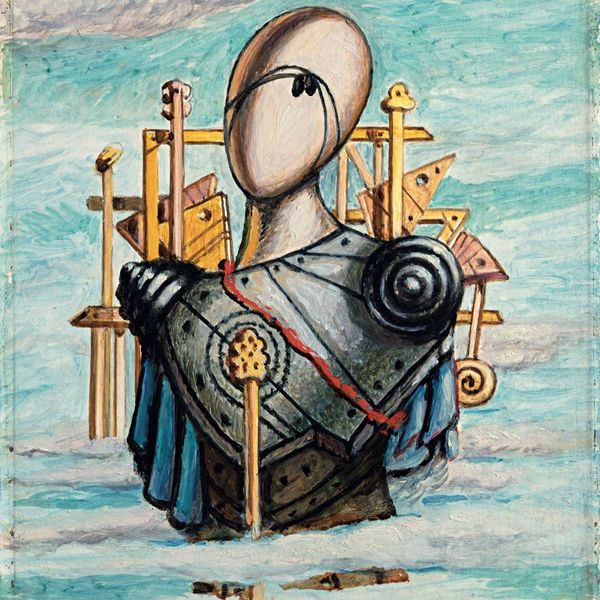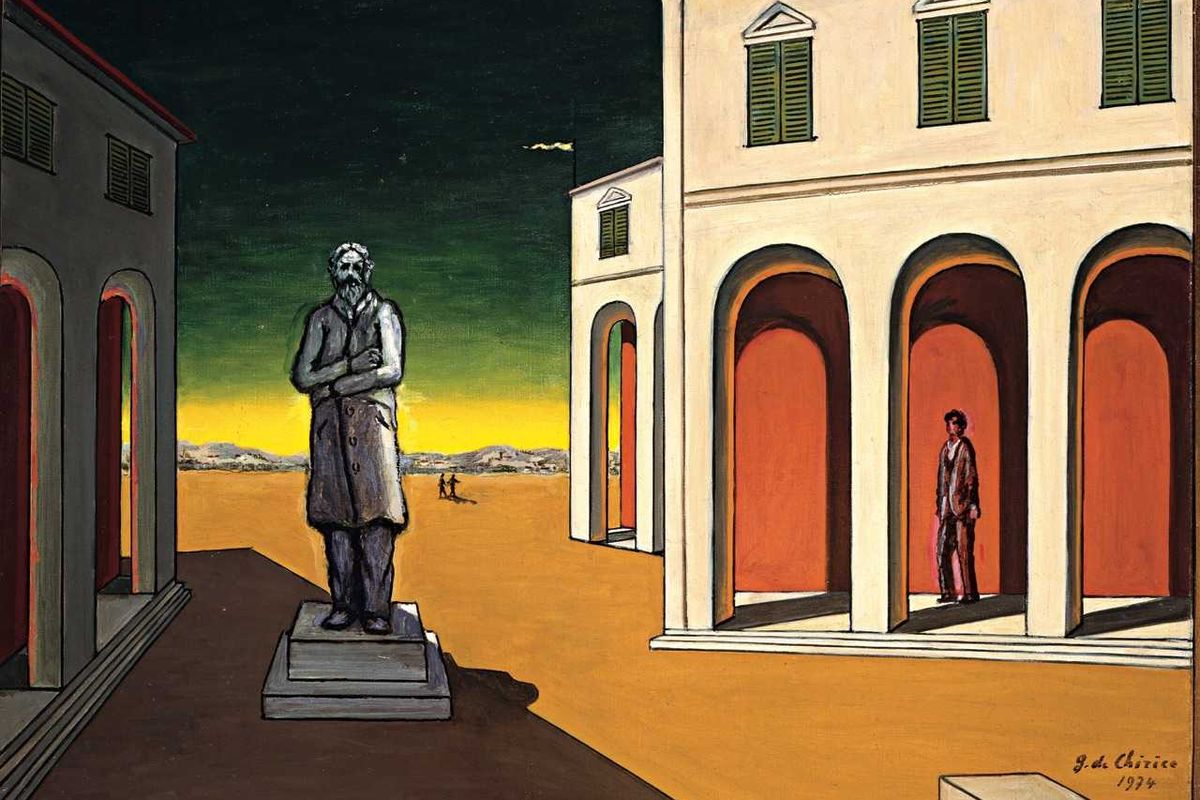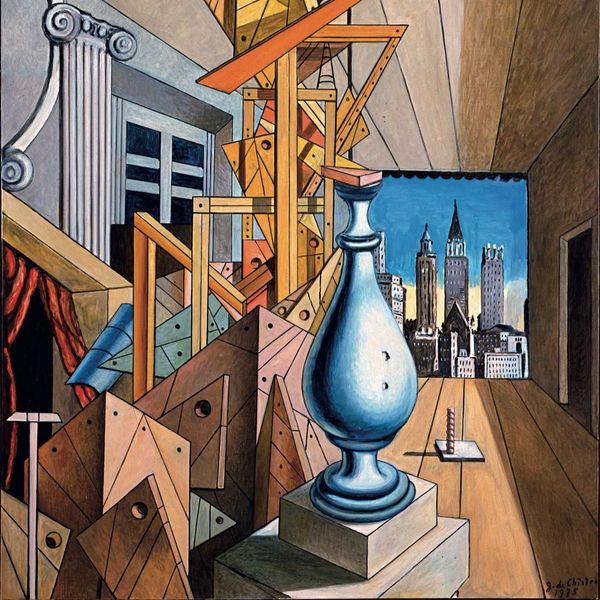Come da copione, tutto il gallinaio del politicamente corretto ha accolto con entusiasmo la recentissima sentenza delle Corte europea dei diritti dell'uomo con la quale l'Italia è stata condannata a risarcire, con la somma di 12.000 euro, il danno morale che sarebbe stato prodotto ad una donna da talune affermazioni circa i suoi comportamenti sessuali contenute nella sentenza d'appello che, ribaltando quella di primo grado, aveva mandato assolti, con la formula «il fatto non sussiste», alcuni giovani che la stessa donna aveva accusato di violenza sessuale di gruppo nei suoi confronti.
Tanto per mettere le cose in chiaro, va subito detto che la Corte europea non solo non ha minimamente contestato la legittimità della pronuncia assolutoria (cosa che, del resto, sarebbe stata estranea all'oggetto del giudizio), ma ha anche espressamente escluso che «le modalità delle audizioni effettuate nel corso dell'inchiesta abbiano esposto l'interessata ad un traumatismo ingiustificato o a delle ingerenze sproporzionate nella sua vita intima e privata». Essa ha, anzi, riconosciuto che le autorità inquirenti e giudicanti non avevano «omesso di vegliare a che l'integrità personale dell'interessata fosse correttamente protetta durante lo svolgimento del processo». Da notare, inoltre che, sempre secondo la Corte europea, in un caso come quello in discorso, la questione della credibilità della denunciante era «particolarmente cruciale», per cui «il fatto di riferirsi alle sue passate relazioni con uno od un altro degli incolpati o ad alcuni dei suoi comportamenti nel corso della serata (quella nel corso della quale sarebbe avvenuta la pretesa violenza sessuale di gruppo, ndr), poteva essere giustificato».
Quale, dunque, la ragione per la quale l'Italia è stata condannata? Una soltanto: quella costituita dalla presenza, nella motivazione della sentenza d'appello, del richiamo, oltre al particolare delle mutandine rosse che la donna avrebbe mostrato nel corso della serata, anche a fatti quali la sua bisessualità, le relazioni sentimentali ed i rapporti sessuali occasionali da lei avuti con vari soggetti prima dei fatti, la sua «attitudine ambivalente nei confronti del sesso», quale dimostrata dalla sua partecipazione, in passato, ad un cortometraggio cinematografico di carattere «violento ed esplicitamente sessuale». Tali richiami, come pure il giudizio espresso dalla corte d'appello secondo cui la decisione della donna di denunciare il preteso stupro sarebbe stata frutto del suo intento di «stigmatizzare» e di rimuovere «un momento criticabile di fragilità e debolezza», sarebbero stati un fuor d'opera, rispetto alla esigenza di valutare la credibilità della denunciante (che, si sostiene, «avrebbe potuto essere esaminata alla luce dei numerosi risultati oggettivi della procedura»), e non avrebbero comunque avuto rilievo determinante ai fini della definizione del giudizio. Di qui la ritenuta violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che garantisce ad ogni persona «il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare».
Tale conclusione, però, si pone in radicale contraddizione logica con quanto la stessa Corte di Strasburgo, come si è visto, ha riconosciuto a proposito del fatto che la denunciante non avesse subito, nel corso del processo, «ingerenze sproporzionate nella sua vita intima e privata» e avesse potuto fruire, nel corso del processo, di adeguata protezione della sua «integrità personale». Se così era stato, infatti, se ne doveva dedurre che l'acquisizione agli atti del processo di tutte le summenzionate notizie riguardanti i comportamenti e le scelte di vita della donna era stata del tutto legittima. E allora altrettanto legittimo sarebbe dovuto apparire, agli occhi della Corte europea, anche il fatto che a quelle notizie si facesse riferimento nella motivazione della sentenza assolutoria, nell'ambito di quel giudizio complessivo sulla credibilità della denunciante che come pure si è visto, la stessa Corte europea ha riconosciuto come necessario.
D'altra parte, occorre considerare che, in materia di reati sessuali, la difesa degli imputati si basa quasi sempre sul preteso consenso della vittima e che quest'ultima, a sua volta, oppone l'esistenza di un rifiuto a ciò che, altrimenti, per sua natura, avrebbe potuto essere gradito. Da ciò deriva che, dovendosi scegliere tra la parola dell'uno e quella dell'altra nel rispetto, però, del fondamentale principio di civiltà dell'«in dubio pro reo», la verifica della versione offerta dalla presunta vittima, quando non sia corroborata da altri elementi esterni, debba essere particolarmente rigorosa e quindi investire, se necessario, anche aspetti della sua personalità. Non a caso, infatti, l'art. 194 del vigente codice di procedura penale prevede l'ammissibilità di deposizioni testimoniali su fatti che servano a definire la personalità della persona offesa del reato «quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona».
Di tutto ciò la Corte europea non ha però voluto tenere il minimo conto. Il che, volendo pensar male, potrebbe spiegarsi facilmente considerando che il suo vero obiettivo, più che quello di fare opera di vera giustizia, fosse quello di cogliere l'occasione per «bacchettare» l'Italia sostenendo che, come si legge nel prosieguo della sentenza, nel nostro paese si constaterebbe (e la sentenza della corte d'appello ne sarebbe conferma), «la persistenza di stereotipi concernenti il ruolo delle donne e la resistenza della società italiana alla causa dell'uguaglianza dei sessi»; affermazione, questa, che, essa sì, appare chiaramente come un fuor d'opera rispetto all'oggetto specifico del giudizio ed agli argomenti meramente giuridici su cui si sarebbe dovuta basare la sua definizione.
Vi è tuttavia da notare che la decisione della Corte europea non è stata presa all'unanimità. Esiste, infatti, ed è stata pubblicata, l'opinione dissenziente di uno dei giudici (il polacco Krzysztof Wojtyczek), il quale, oltre a rilevare la stessa contraddizione di cui sopra si è fatto cenno, ha anche affermato che la corte d'appello italiana aveva legittimamente esercitato il proprio potere nel ritenere «che per esaminare l'affare penale era indispensabile stabilire certi elementi di fatto appartenenti ad un contesto più largo, inglobante degli avvenimenti che hanno preceduto o che hanno seguito gli atti in causa, descritti nei capi d'incolpazione».
Questo, oltre a dimostrare che anche a Strasburgo sopravvive qualche traccia del comune buon senso, dovrebbe anche costituire un incoraggiamento al Governo italiano perché proponga ricorso alla istanza superiore, costituita dalla c.d. «Grande camera» della Corte europea, contro la decisione di condanna.
Pietro Dubolino
Presidente di sezione a riposo della Corte di cassazione