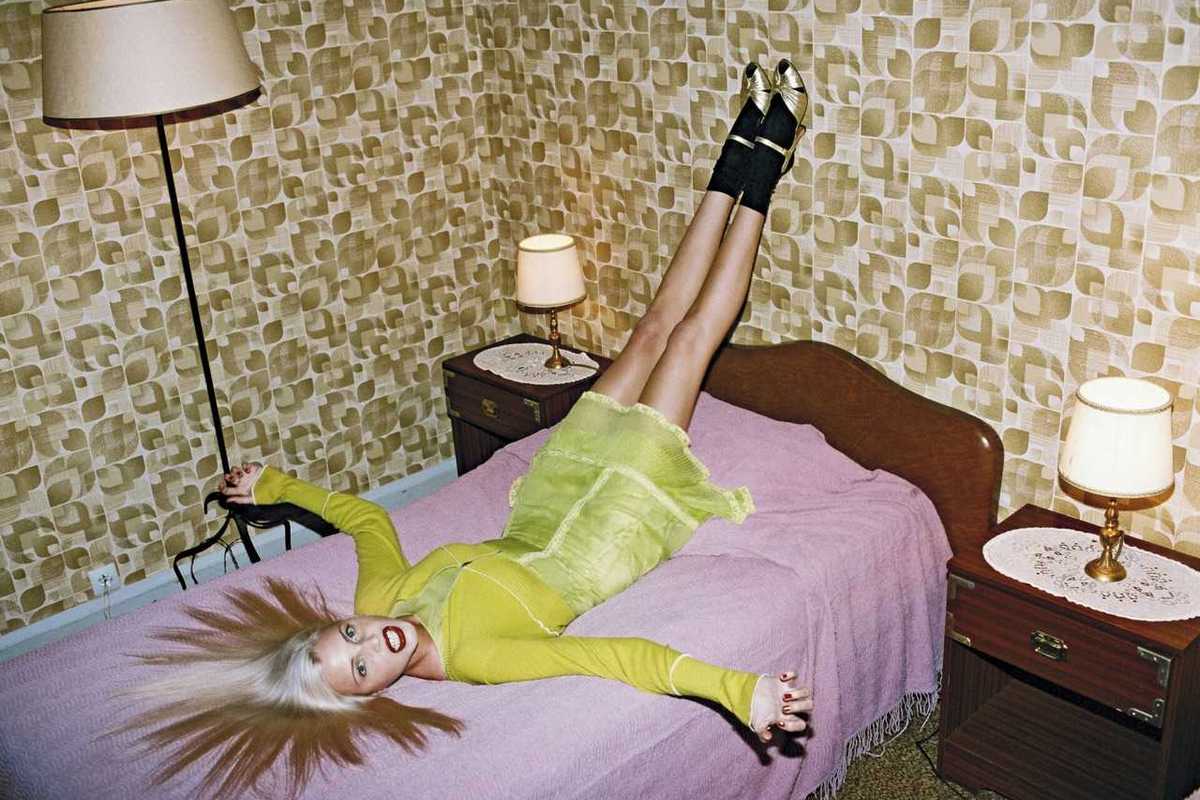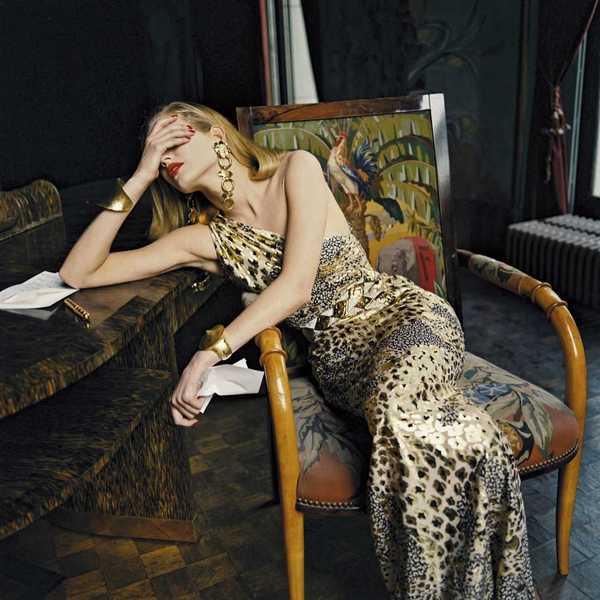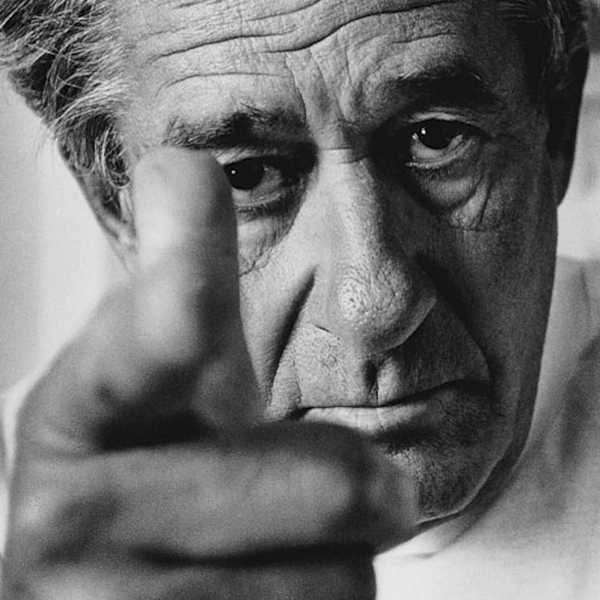Corte dei conti Ue: «Dobbiamo blindare lo Stato di diritto a colpi di sanzioni»

In un rapporto pubblicato ieri, la Corte dei conti europea critica gli strumenti economici che l’Unione ha messo a punto per la difesa del cosiddetto «Stato di diritto». La prospettiva della Corte è unicamente quella finanziaria, dunque il rapporto va alla ricerca dei punti critici che mettono a rischio il bilancio comune. Tuttavia, diverse considerazioni della relazione hanno un sapore eminentemente politico, poiché riguardano un tema spinoso come quello del blocco dei fondi nei confronti di governi che adottano politiche considerate eretiche rispetto ai principi contenuti nell’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea.
Dal 1° gennaio 2021 è in vigore il regolamento sulla condizionalità, cioè un regime di protezione del bilancio dell’Ue dalle violazioni dei principi dello Stato di diritto. Sinora, vi è stato un solo caso di applicazione del regolamento, nel 2022, nei confronti dell’Ungheria. In quel caso, la Corte ha rilevato che il regolamento è stato applicato correttamente, ovvero i fondi del bilancio destinati all’Ungheria sono stati bloccati nel dicembre 2022 sulla base di motivazioni fondate e coerenti con il regolamento. La Corte nota però che diversi aspetti del regolamento sono di difficile applicazione, riferendosi in particolare alla dimostrazione di un nesso diretto tra le violazioni dei principi dello Stato di diritto da parte di un Paese e gli interessi finanziari dell’Unione.
Inoltre, sostiene la Corte, se in forza del blocco dei finanziamenti uno Stato sanzionato non segue i programmi dell’Unione, questa si troverebbe con obiettivi non raggiunti proprio a causa del blocco che essa stessa ha attuato.
A oggi, Ungheria e Polonia sono interessate da varie misure di bilancio (cioè dal blocco dei trasferimenti da Bruxelles) correlate allo Stato di diritto, il cui impatto è di circa 22 e 134 miliardi di euro rispettivamente. Tali cifre però non sono effettive ma solo potenziali, poiché riguardano il blocco di pagamenti futuri fino al 2030.
La Corte segnala di non avere elementi per capire perché, in casi diversi da quello ungherese, la Commissione abbia usato altri strumenti. Questo perché la Commissione non ha motivato i casi in cui aveva individuato potenziali violazioni dei principi dello Stato di diritto in altri Paesi, senza però applicare le misure previste dal regolamento. La Corte, insomma, avanza il dubbio che l’applicazione del regolamento sia suscettibile di arbitrarietà.
Essendo quella della Corte del Lussemburgo una visione puramente finanziaria, la preoccupazione dei suoi funzionari è strettamente legata alla «protezione» del bilancio comune 2021-2027. In quest’ottica, secondo la Corte, «la decisione di non bloccare o di sbloccare i fondi dell’Ue dovrebbe essere basata su un’analisi tecnica e giuridica».
In realtà le considerazioni politiche hanno un ruolo determinante nell’applicazione del regolamento. L’appartenenza all’Unione comporta la partecipazione dei governi a continue trattative su tutti i fronti, dunque è normale che vi siano valutazioni più articolate da fare. L’esempio più lampante è dato proprio dalla necessità dell’unanimità in Consiglio per il pacchetto da 50 miliardi di euro di aiuti all’Ucraina nella riunione del 1° febbraio, allorché il premier ungherese minacciò il veto.
La necessità di un’applicazione uniforme di «regole» tecnico-giuridiche, in maniera asettica e senza valutazioni politiche, ritorna prepotentemente nelle dichiarazioni di Annemie Turtelboom, il membro della Corte che ha diretto l’audit: «Le nuove tutele dell’Ue in merito allo Stato di diritto rappresentano un passo avanti encomiabile. Ma si tratta di una corazza incrinata: lo Stato di diritto è un valore fondante dell’Ue, che merita senz’altro una blindatura stagna».
Sul significato di «blindatura stagna» c’è da interrogarsi. La Corte dei conti europea è formalmente un organo tecnico e non politico, ma nella realtà è organo politico, perché vigila tecnicamente sull’attuazione di regole decise politicamente. La separazione tra tecnica e politica è pretestuosa, basti pensare, in Italia, a quanto era politico il governo tecnico par excellence, quello di Mario Monti nel 2011-13.
Possiamo solo immaginare che «blindatura stagna» significhi sanzionare finanziariamente qualunque governo non si conformi a ciò che piace a Bruxelles. Perché il rischio della arbitrarietà nell’applicazione del regolamento esiste veramente.
Dunque in gioco vi è la sovranità degli Stati e l’ingerenza dell’Unione negli affari interni di questi. La questione della sovranità non ha nulla a che fare con il nazionalismo, come vorrebbe certa propaganda. Riguarda semmai la democrazia. Nel caso dell’Italia, l’articolo 1 della nostra Costituzione recita: «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Non nelle forme e nei limiti decisi da funzionari lituani o irlandesi, irresponsabili politicamente e personalmente. Sovranità popolare significa democrazia e democrazia significa responsabilità politica degli eletti. Cosa che dalle parti di Bruxelles non è, appunto, molto popolare.