Così Chesterton risolve l’equivoco del San Francesco «comunista»
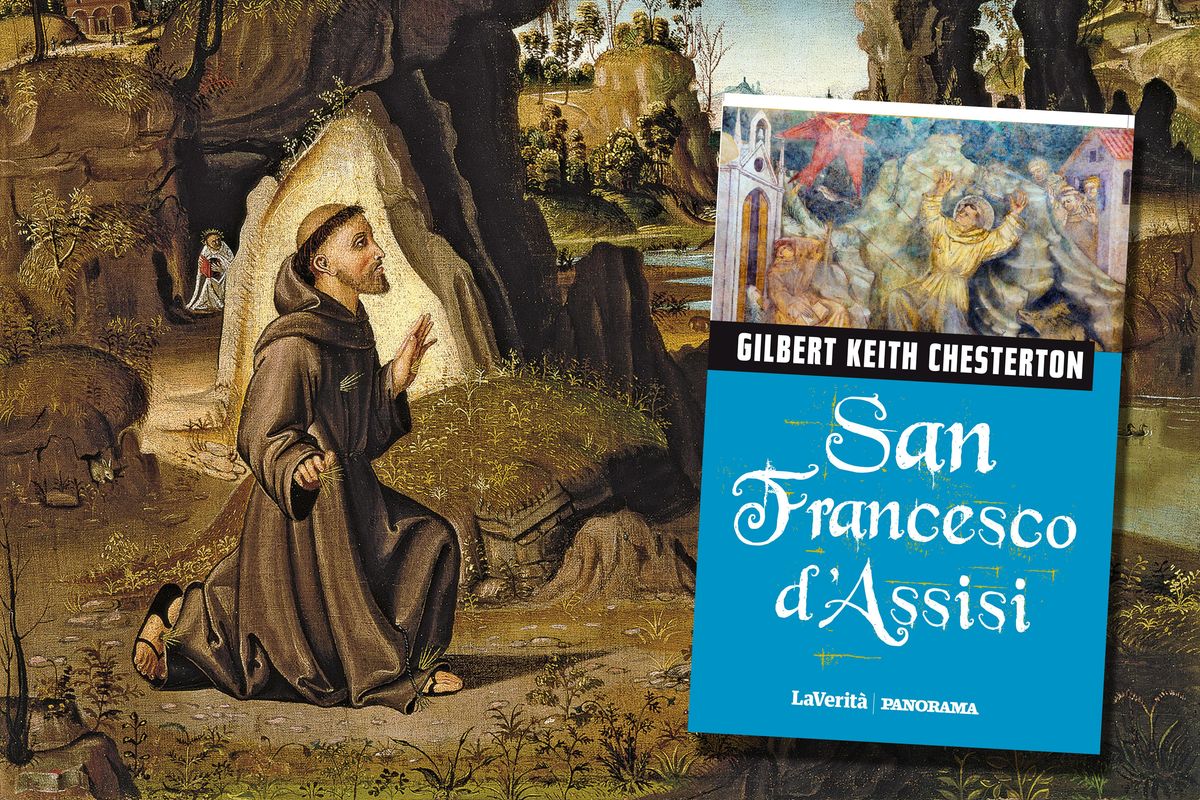
Quella di San Francesco (1181-1226) è una delle figure della storia del cristianesimo in cui la devozione popolare spesso si accompagna a una pluralità di letture e interpretazioni anche fortemente contrastanti tra loro. L’inedita scelta di assumere su di sé il nome del patrono d’Italia da parte di Jorge Mario Bergoglio ha caricato di ulteriore interesse il frate di Assisi. Con San Francesco d’Assisi di Gilbert Keith Chesterton, La Verità e Panorama (a 7,90 euro) offrono ai loro lettori una delle biografie più affascinanti e coinvolgenti mai scritte. L’autore di Padre Brown e di molti altri capolavori, come già fatto in un altro gioiello (il suo San Tommaso d’Aquino) pur non trascurando i dati essenziali della vita di Francesco traccia un ritratto spirituale e teologico che coniuga godibilità di lettura e profondità religiosa e intellettuale. Il brano qui proposto, tratto dall’ultimo capitolo del libro, punta al cuore della «eretizzazione» possibile dell’esperienza francescana: un pauperismo di stampo comunisteggiante. Una ferita che la Chiesa ha sanato con fatica , fino a portare un «Francesco» alla sua stessa guida.
Ha quasi il tono di una triste ironia il fatto che San Francesco, che per tutta la vita aveva desiderato la concordia tra gli uomini, sia morto in mezzo a crescenti discordie. Non dobbiamo tuttavia esagerare tali discordie, come alcuni hanno fatto, al punto di trasformarle in una banale sconfitta di tutti gli ideali del Santo. Alcuni presentano la sua opera come distrutta dalla malvagità del mondo o della stessa Chiesa, portatrice di una malvagità che, secondo loro, è sempre la più grande.
Questo breve libro è un saggio su San Francesco e non sull’Ordine francescano, men che meno sulla Chiesa, sul papato o sulla politica adottata nei confronti dei fraticelli o degli estremisti. L’unica cosa che dobbiamo riferire qui, in poche parole, è il carattere molto naturale della controversia che divampò negli ultimi giorni della vita del grande santo e che, in qualche modo, dovette anche turbarli. Il problema dominante era l’interpretazione del voto di povertà o del rifiuto di ogni genere di possesso. Per quanto ne so, nessuno si prefisse mai di mettere in discussione il voto individuale, per il quale ciascun frate si impegnava a rinunciare a possedere beni personali. Cioè, nessuno si prefisse mai di modificare il voto in riferimento alla proprietà privata dei singoli. Ma alcuni francescani, appellandosi alla stessa autorità di Francesco, si spinsero molto oltre e divennero sostenitori di una posizione estrema. Si prefissero di abolire non solo la proprietà personale, ma la proprietà in generale. Rifiutarono di essere, anche solo corporativamente, responsabili di qualunque cosa: edifici, provviste, attrezzi. Rifiutarono di avere queste cose in comproprietà anche quando le usavano. È verissimo che molti, soprattutto fra i primi compagni, erano uomini di spirito grandissimo e disinteressato, consacrati totalmente agli ideali del santo. È altrettanto vero però che il papa e le autorità ecclesiastiche ritennero che questa visione fosse una regola impraticabile e ne chiesero la modifica, al punto da sopprimere alcune clausole contenute nello stesso testamento di Francesco.
A dire il vero, non era facile dare il giusto valore a quella regola, se fosse davvero praticabile, o perfino se fosse davvero una regola, perché in fondo si trattava del rifiuto di ogni regola. Tutti naturalmente sapevano che i francescani erano «comunisti», ma quello che qui si rischiava era più l’anarchia che il comunismo. La cosa certa e fondamentale, da qualunque parte si guardi questa faccenda, è che qualcuno doveva pur essere responsabile del destino e della destinazione degli edifici storici e di tutti i beni mobili e immobili. Molti idealisti di stampo socialista, in particolare della scuola di Shaw o di Wells, hanno trattato questa disputa come se si trattasse di uno dei tanti casi di pontefici opulenti che contrastavano il vero cristianesimo dei socialisti cristiani. In realtà, questo idealismo estremo di cui parliamo era, in un certo senso, esattamente il contrario del socialismo, anzi della socialità. Ciò che quegli entusiasti rifiutavano era la proprietà collettiva, che è esattamente l’idea sulla quale si costruisce il socialismo. Negavano precisamente la ragion d’essere del socialismo: possedere legalmente in quanto collettività. E non è nemmeno vero che i papi si rivolgessero a quegli esaltati con un tono sempre severo e ostile. Per molto tempo il pontefice mantenne una posizione di compromesso, destinata in modo particolare a venire incontro alle obiezioni di coscienza, un compromesso per cui lo stesso papa si faceva carico delle proprietà in una specie di fondo di deposito fiduciario per conto dei veri proprietari che non volevano neppure toccarla. A dirla tutta, questo incidente rivela due cose, abbastanza usuali nella storia della Chiesa cattolica, ma poco comprese dalla storia giornalistica della civiltà industriale. Cioè che spesso i santi sono grandi uomini, mentre i papi uomini di poco valore. Ma anche che i grandi uomini alcune volte si sbagliano, mentre quelli di poco valore hanno ragione. Dopo tutto, l’osservatore onesto e sincero, che guarda le cose da fuori, non potrà negare che il papa avesse le sue ragioni quando affermava che il mondo non è fatto solo di francescani.
Qui stava esattamente il problema. Al centro di questo particolare dibattito si celava infatti qualcosa di molto più grande e importante, di cui possiamo percepire il palpitare nella controversia. Mi verrebbe da esporre il caso in questi termini: San Francesco era stato un uomo talmente grande e originale da avere in sé qualcosa che ne faceva il fondatore di una nuova religione. E, nel loro cuore, molti suoi seguaci erano disposti a considerarlo tale. Volevano che lo spirito francescano emergesse dal cristianesimo allo stesso modo in cui lo spirito cristiano era emerso dal giudaismo, cioè liberandosene. A questo francescanesimo non sarebbe per nulla dispiaciuto liberarsi dal cristianesimo come lo spirito cristiano si era liberato da Israele. Francesco, il grande incendio che era divampato per tutte le strade d’Italia, avrebbe dovuto essere per loro la scintilla di un’esplosione che avrebbe ridotto in cenere l’antica civiltà cristiana. Era questo il problema che il papa doveva risolvere: se il cristianesimo dovesse lasciarsi assorbire da Francesco o Francesco dal cristianesimo. E decise secondo ragione, al di là dei suoi doveri istituzionali: la Chiesa sarebbe stata in grado di accogliere nel suo seno tutto ciò che c’era di buono nei francescani, mentre i francescani non avrebbero potuto fare lo stesso con quanto di buono c’è nella Chiesa.
C’è un’ulteriore considerazione, già indicata con sufficiente chiarezza lungo tutta la nostra narrazione, ma forse non abbastanza evidente, soprattutto per coloro che non la sanno apprezzare per via di quel buonsenso cattolico che spesso è più forte anche del fanatismo francescano. E nonostante si tratti di qualcosa che scaturisce proprio dai meriti dell’uomo che giustamente ammiriamo. Come abbiamo detto, Francesco d’Assisi era un poeta; ciò significa che si trattava di un uomo in grado di esprimere la propria personalità. Ora, è tipico di questo genere di persone essere rese grandi proprio dai loro limiti personali. Il Santo è tale non solo per quello che ha, ma anche per quello che non ha. Ma gli ampi limiti a lui concessi non possono essere concessi a tutto il genere umano. San Francesco è uno straordinario esempio della qualità peculiare dell’uomo di genio, per il quale anche ciò che è negativo diventa positivo perché è ciò che va a comporre il suo carattere. L’atteggiamento del santo nei confronti dell’apprendimento e della cultura illustra perfettamente quel che intendo dire: lui, infatti, non teneva neppure in considerazione i libri e lo studio, e a un certo punto sconsigliò persino di servirsene; dal suo punto di vista, e da quello della sua missione terrena, non aveva affatto torto. Lo scopo del suo messaggio era di essere tanto semplici da essere comprensibili anche dal popolano più rozzo. Il nucleo della sua visione delle cose era uno sguardo fresco su un mondo nuovo come se fosse stato creato quella mattina. Tranne che per i grandi eventi dei primordi come la creazione, la storia dell’Eden, il primo Natale, la prima Pasqua, per Francesco era come se il mondo non avesse alcuna storia. Ma è cosa altrettanto auspicata e auspicabile che allo stesso modo l’intera Chiesa non abbia alcuna storia?
La tesi centrale del presente libro è che San Francesco abbia percorso le strade del mondo come se fosse lui stesso una personificazione della «misericordia di Dio». Voglio dire che la sua comparsa ha segnato l’attimo in cui gli uomini avrebbero potuto riconciliarsi non solo con Dio, ma anche con la natura e, cosa più difficile di tutte, con se stessi. La sua comparsa ha segnato infatti il momento in cui il soffocante paganesimo che aveva avvelenato il mondo antico è stato infine estirpato dal sistema sociale. Francesco aprì le porte dei Secoli Bui come se fossero state quelle della prigione di un purgatorio, nel quale gli uomini si erano purificati come eremiti nel deserto o come eroi nelle guerre contro i barbari.






