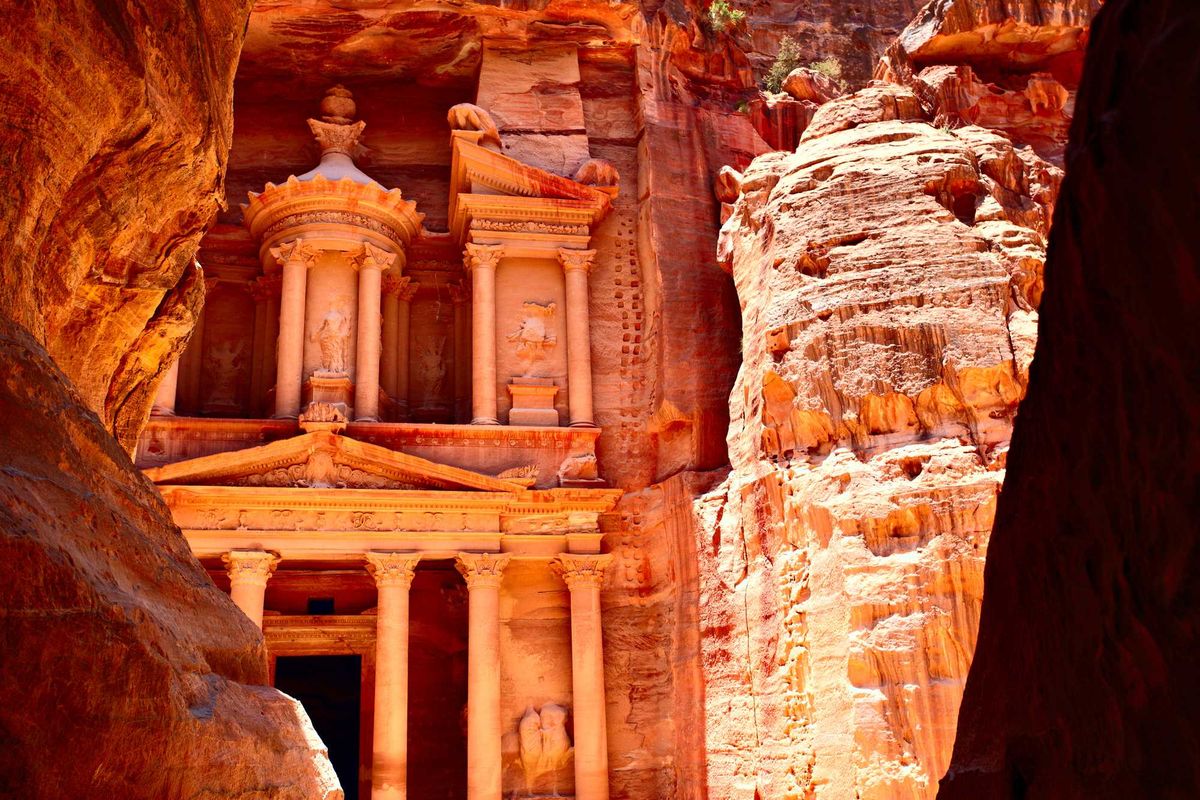Il caporalato? A sfruttare per primi gli immigrati sono i loro connazionali
«Ogni giorno alle 6 del mattino mi presentavo in via Lorenteggio a Milano e il sabato in San Siro. Qui mi aspettava il caporale con la macchina in moto, pronto a partire per il cantiere». Said (nome di fantasia) ha 30 anni, è egiziano e come tanti connazionali è uno schiavo del cemento. Una delle vittime del caporalato, quel fenomeno di cui si sente parlare al Sud, quando l'estate centinaia di braccianti raccolgono i prodotti che finiscono sulle nostre tavole. Ma lo sfruttamento del lavoro non esiste solo nel Mezzogiorno e nell'agricoltura. Si è fatto largo pure al Nord, tra la calce e la pala. Ha contagiato la Milano dei grattacieli, dove recluta i disperati all'alba, nei piazzali. Oppure tramite un messaggio su Whatsapp o un annuncio online: «Domani alle 7 al cantiere». E via verso una nuova giornata di lavoro.
Difficile dare numeri sul fenomeno perché chi ne è vittima quasi mai lo denuncia. Troppo grande è la paura di non lavorare più o, peggio, di irritare il caporale. Ma chi sono questi caporali? Sono figure intermedie, trait d'union tra manodopera e proprietà. Muratori «anziani», stranieri in Italia da tempo, cui le società in cambio di un lauto compenso affidano un preciso incarico: procacciare braccia a basso costo tra i propri connazionali. Irritarli non significa solo smettere di lavorare, ma anche rimanere tagliati fuori dal giro di aiuti reciproci tipico di ogni gruppo di emigrati. A dispetto di quello che si dice sul razzismo degli italiani, dunque, sono gli stessi stranieri il primo anello dello sfruttamento. Forse il peggiore, perché è un ricatto che arriva da vicino.
L'omertà è ancora tanta, ma qualcuno comincia a farsi avanti. Come Said, appunto, Ivan e Dimitri. Anche loro nomi di fantasia. Un tempo fantasmi, ora persone che hanno deciso di raccontare la propria storia e denunciare chi per anni ha lucrato sulla loro fatica. Ecco chi sono i caporali della Milano del mattone.
Said ha 30 anni. Quindici anni fa ha lasciato il suo paesino vicino al Cairo, in Egitto. È sbarcato in Sicilia con un gommone e poi ha sempre vissuto a Milano, lungo i viali della circonvallazione. Nel frattempo ne ha visti centinaia di cantieri. Una vita dedicata al lavoro, quello nero. Senza contratto, senza tutele, senza diritti. Senza mai riuscire a tornare in Egitto, perché solo chi ha un'occupazione regolare può richiedere il permesso di soggiorno e viaggiare. Un requisito che conosce bene chi, con la promessa di una vita in regola, sfrutta gli schiavi del cemento. «“Vuoi il permesso?", mi dicevano i caporali. “Tu lavori e fai quello che dico io"», racconta nel suo italiano un po' zoppicante. Ha fatto di tutto nei cantieri: il ferraiolo, il carpentiere. «D'altronde si sa, noi egiziani siamo i migliori nel ferro e nel legno».
L'anno più buio il 2016. Quando il fratello di un amico, egiziano come lui, lo ha reclutato per un posto da carpentiere. Ne serviva uno per una società che aveva ottenuto un appalto da una grande azienda energetica. Bisognava lavorare in tre cantieri del nord Italia: a Sannazzaro in provincia di Pavia, a Spinetta frazione di Alessandria e a Venezia. Nel mondo dell'edilizia la filiera degli appalti a «scatole cinesi» è un fenomeno noto. Un lecito ma intricato labirinto di imprese edili terziste, dove lo sfruttamento della manodopera trova terreno fertile.
L'appuntamento ogni giorno all'alba in via Lorenteggio e il sabato in San Siro. Ad attendere Said e altri operai, con il furgone acceso, sempre lo stesso egiziano che lo aveva agganciato, pronto a partire alla volta dei cantieri della provincia. Questi luoghi sono però solo due snodi del caporalato milanese. Se ne potrebbero citare molti altri.
«Piazzale Lotto, Maciachini, Corvetto, piazzale Lagosta, viale Certosa. Qui non è difficile imbattersi all'alba in capannelli di ragazzi che in tenuta da lavoro aspettano che qualcuno li venga a prendere», spiega Katiuscia Calabretta, segretario milanese della Fillea Cgil. «Un tempo il caporale sceglieva al momento le persone da portare con sé, ma il reclutamento si è evoluto con la tecnologia. Oggi basta un messaggio su Whatsapp o un annuncio sui tanti portali online di ricerca lavoro per assoldare braccia a basso prezzo», continua.
La paga di Said: 100, 150, 200 euro. In contanti e in anticipo sul mese. Cifre lontane da quelle che secondo il contratto collettivo dell'edilizia spetterebbero a un operaio di primo livello (il meno specializzato). Mentre i turni di lavoro potevano variare: dalle 8 ore di base fino a 14, 15 ore al giorno. «Quando sta arrivando la malta, non si può lasciare», confida Said. E se si verificavano incidenti, l'omertà era assoluta. «Un giorno è caduta una sega circolare sulla schiena di un mio compagno. È stato tre mesi in ospedale, ma nessuno ha mai detto nulla. Mentre lui era via, il caporale ci ha dato il suo cartellino: dovevamo timbrarlo al suo posto ogni mattina».
Quando ha deciso di interrompere i rapporti, l'azienda doveva a Said circa 16.000 euro. «Abbiamo intrapreso una conciliazione e siamo riusciti a recuperarne la metà», conclude Khalid Bouzyan, sindacalista Cgil che lo ha aiutato nella causa. «Dopodiché la società si è sciolta e ricostituita, modificando il nome per far perdere le tracce. Sarà difficile ora ottenere il resto di quanto gli spetta». «Se ricordo quanto prendeva il caporale? Molto più di noi: 14 euro all'ora», rivela Said.
Se gli egiziani sono i più esperti nella carpenteria, nessuno sa lavorare il cartongesso come gli operai rumeni. Ivan e Dimitri sono zio e nipote. I migliori nel tirare su pareti e soffitti «in pochissimo tempo», assicura Dimitri. «Ho sempre fatto questo mestiere, da prima che venissi in Italia», racconta Ivan, 60 anni, fisico robusto e allenato dai pesi. Dimitri è più esile, ha circa 35 anni e le mani ricoperte di cicatrici. Arrivati in Italia non è stato difficile per loro darsi da fare. In dieci anni, di cantiere in cantiere, hanno girato la Lombardia e non solo: Brescia, Bergamo, Como, Lodi, Piacenza. Sempre all'opera, vicino casa o in trasferta. «In nero o meno, l'importante è lavorare. E se riesci a prendere il permesso di soggiorno, sei fortunato», dice Dimitri. Ma non sempre accade.
«Come quando abbiamo lavorato per quel bastardo», esclama Ivan. Dalla sua bocca esce una zaffata di fumo. Ogni volta che ripensa a quel periodo sale la frustrazione. Il «bastardo» è un caporale rumeno. Lo ripete più volte, quasi a esorcizzare l'amarezza. «Lo conoscevamo perché ci aveva affittato casa, appena arrivati in Italia». A lui zio e nipote hanno prestato le braccia in grandi cantieri. A Milano, in piazza Duomo ad esempio, ma soprattutto a Repubblica. Il caso risale all'estate del 2016. Nell'esclusivo quartiere vicino a Porta Venezia, tra parchi, hotel e ambasciate, «eravamo tutti in nero», sorride amaro Ivan. Su 90 operai solo una quindicina era in regola. «Di un contratto neanche l'ombra», conferma Dimitri. Al punto che capitava spesso che l'ispettorato del lavoro facesse qualche visita. «Quando arrivava la sicurezza, il caporale ci telefonava e ci diceva: «Via, via, fuori dal cantiere!». Noi uscivamo e aspettavamo al bar o in strada, anche fino a sera. Se perdevamo la giornata, non venivamo pagati».
Perché nessuno mai si ribellava? «Perché non conviene. “Se non ti sta bene, vai a casa", ci diceva. E noi non potevamo permetterci di perdere il lavoro, quando devi mangiare, pagare l'affitto e le bollette». Ma alla fine dopo quattro mesi di lavoro dentro lo scheletro di quel palazzo da venti piani, zio e nipote hanno detto basta. Troppo pochi 2.000 euro in due per rischiare la vita a 50 metri d'altezza. Senza casco e imbragatura, là dove tremano i polsi e si spezza la voce. «Il caporale ce ne doveva quattro volte tanto!», quasi grida Ivan. A loro due e ad almeno un'altra dozzina di muratori che nel cantiere di Repubblica erano al suo soldo. «Per convincerci a lavorare ci scriveva: “Vieni, vieni domani che ti do i soldi". Non li abbiamo mai visti. Con le nostre paghe ha rubato 160.000 euro. E mentre noi lavoravamo, lui andava in giro sulla sua bella macchina, coi suoi bei vestiti, vantandosi con tutti».
Dopo due ore di racconto parole e sigarette sono finite. La delusione lascia per un attimo spazio alla malinconia: «L'Italia è un Paese bello», dicono. Permette a tanti stranieri di lavorare e mettere da parte quel poco che in patria vale molto. «In Romania non riesci neanche a fare la spesa: carne e verdura costano troppo. Non hai altra scelta se non partire…», spiega Dimitri. Le loro speranze però non sono cambiate: «Sogno di tornare dove sono nato e costruire lì la mia casa», dice Ivan. «Non manca molto: solo due anni. Poi andrò in pensione e potrò finalmente tornare».
Ha collaborato Andrea Boeris