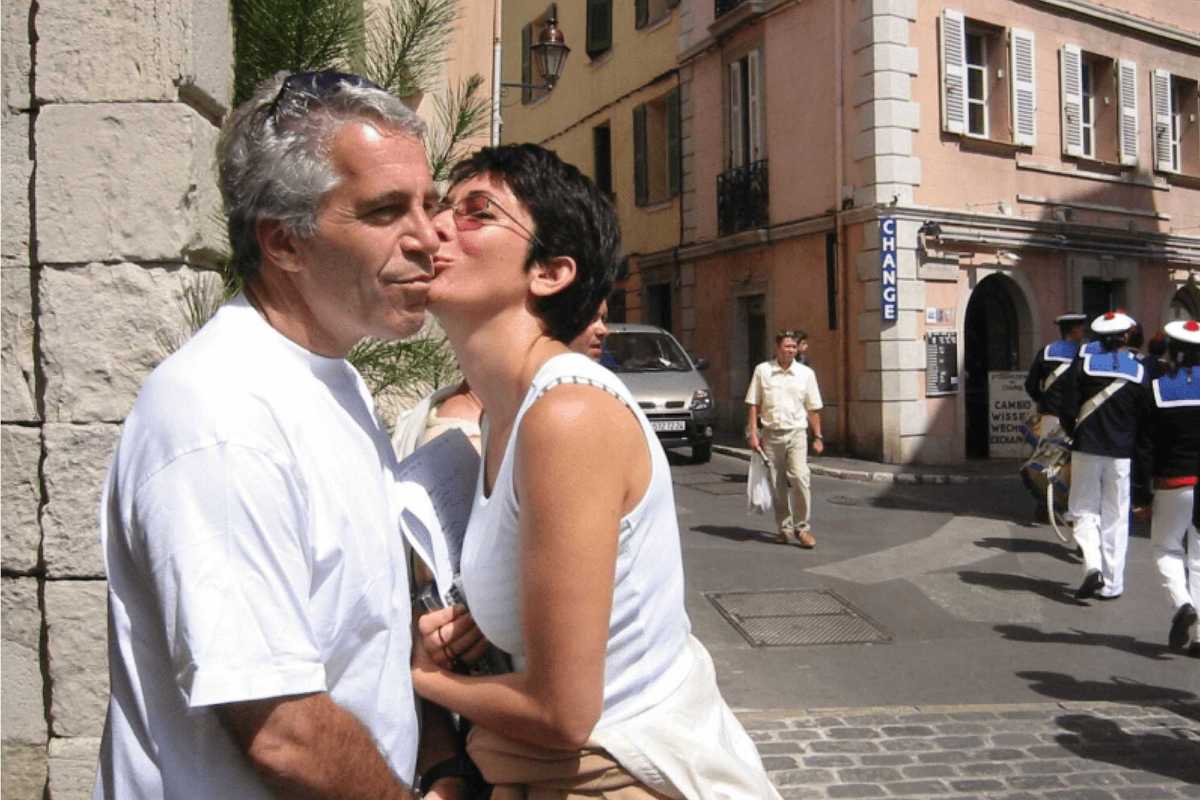Nagorno Karabakh, entra in gioco Biden. E non è una buona notizia per gli armeni

- La difficile situazione nella regione contesa tra Armenia e Azerbaigian pone l'incognita di come si muoveranno gli Stati Uniti su questa spinosa questione. Nelle scorse settimane, il nuovo presidente eletto ha emesso un comunicato stampa, criticando Donald Trump per non aver avviato un'iniziativa diplomatica, volta a risolvere il conflitto.
- Le attuali tensioni affondano le radici in una turbolenza storica che dura da circa un secolo. La partita è delicata perché si è inserita nel quadro più complesso del difficile equilibrio tra Russia e Turchia.
Lo speciale contiene due articoli.
In particolare, l'allora candidato democratico accusava il presidente di aver delegato la questione alla Russia e di non essersi minimamente impegnato nel cercare di far arrivare le parti a un accordo. Il problema è che, partendo da quel comunicato, non sia granché chiaro comprendere quale sarà la posizione della (probabile) amministrazione Biden sul tema.
Cominciamo col dire che è senz'altro vero che Trump non abbia mostrato il minimo interesse sulla questione. Una posizione, quest'ultima, che - in linea generale - è anche comprensibilmente criticabile. Una posizione tuttavia che va anche inserita all'interno di un contesto più ampio e articolato. Innanzitutto ricordiamo che il conflitto regionale è riesploso alla fine dello scorso settembre: nel pieno quindi della campagna elettorale per le presidenziali americane. In secondo luogo, vale forse la pena rammentare che l'atteggiamento di Trump possa essere spiegabile con la sua linea realista in politica estera. L'attuale presidente americano ha sempre sostenuto infatti la necessità di ripartire il globo in varie aree di influenza, con l'obiettivo di non lasciar coinvolgere direttamente gli Stati Uniti in ogni scenario problematico. In questo senso, è possibile leggere il disinteresse di Trump come un'implicita delega alla Russia, la quale - non a caso - si è a sua volta impegnata nella negoziazione del cessate il fuoco. Un cessate il fuoco che si è rivelato, sì, territorialmente oneroso per gli armeni, ma che prevede al contempo la presenza in loco di truppe russe: un elemento che funge indirettamente da deterrente nei confronti delle forze azere, spalleggiate dalla Turchia.
Alla luce di tutto questo, come si accennava, è difficile capire quale sarà la posizione di Biden sulla questione del Nagorno-Karabakh. Probabilmente l'ambiguità del suo comunicato riflette l'incertezza della sua stessa politica estera. Sono infatti almeno due i nodi che andranno sciolti. Il primo è quello delle nomine ai dicasteri chiave: nomine che, in base a quanto prescrive la Costituzione americana, dovranno essere ratificate dal Senato. Un Senato la cui maggioranza, come sappiamo, è appesa per il momento al destino dei due ballottaggi della Georgia. In secondo luogo, bisognerà vedere come l'amministrazione Biden sceglierà di muoversi nella triangolazione tra Stati Uniti, Russia e Turchia: la crisi del Nagorno Karabakh sarà infatti inserita da Washington all'interno di questa complicata cornice.
E' almeno dal 2017 che Mosca e Ankara hanno avviato un progressivo avvicinamento politico, economico e militare. I due Stati hanno collaborato su vari teatri di crisi (dalla Siria allo stesso Nagorno-Karabakh), senza poi dimenticare questioni rilevanti come quella del sistema missilistico S-400. Non che il rapporto tra Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan sia tutto rose e fiori, ma - a livello generale - la progressiva convergenza tra i due è evidente. Una convergenza che alcuni settori dell'establishment di Washington non hanno mai troppo gradito, considerandola nociva soprattutto per la Nato (di cui Ankara fa parte). Ecco che dunque, per capire come si muoverà Biden sul Nagorno, bisognerà prima capire come si muoverà per cercare di frapporsi tra Russia e Turchia.
A oggi, l'ipotesi più probabile è che il presidente entrante adotterà un atteggiamento duro nei confronti di Mosca: gran parte del Partito democratico americano nutre posizioni di profonda ostilità nei confronti di Putin e - in campagna elettorale - lo stesso Biden ha pronunciato parole particolarmente critiche verso il capo del Cremlino. Ricordiamo del resto che proprio Biden, da vicepresidente, fu tra i protagonisti della rottura tra Washington e Mosca, assumendo - nel 2014 - il ruolo di punto di raccordo tra Stati Uniti e Ucraina, nel pieno della crisi della Crimea. E' pur vero che negli ultimissimi anni dell'amministrazione Obama si fossero deteriorati i rapporti anche tra la Casa Bianca e Ankara. Tuttavia l'avversione di Biden verso la Russia rischia di essere più solida, anche alla luce delle recenti vicende politiche interne, dedicate al caso Russiagate. Senza poi contare che - come già accennato - la presenza della Turchia nella Nato possa dettare una preferenza del presidente americano entrante verso Ankara, dal momento che - almeno formalmente - Biden si è presentato come il candidato che avrebbe rafforzato l'Alleanza atlantica. Va quindi da sé che, qualora la nuova amministrazione statunitense dovesse appoggiarsi alla Turchia in funzione antirussa, sarebbero proprio gli armeni a farne le spese maggiori. Una Russia più debole e isolata, implicherebbe difatti un rafforzamento degli azeri.
Armenia e Azerbaigian, turbolenze che durano da oltre un secolo
La guerra del Nagorno Karabakh del 2020 è stata combattuta tra armeni e azeri dal 27 settembre e il 10 novembre. In particolare, a fronteggiarsi sono stati l'Azerbaigian (spalleggiato militarmente dalla Turchia) e la Repubblica dell'Artsakh (sostenuta dall'Armenia). Nonostante alcuni tentativi di negoziare una tregua, i combattimenti sono proseguiti, con significativi avanzamenti territoriali da parte degli azeri. Secondo molti analisti, il punto di svolta si sarebbe verificato il 9 novembre, quando un elicottero militare russo è stato abbattuto in Armenia a causa di un missile azero. L'evento ha scatenato una forte tensione, tanto da portare la Russia molto vicina a un intervento militare diretto. Una tensione che ha probabilmente giocato un ruolo decisivo nella stipulazione dell'attuale cessate il fuoco, di cui proprio Mosca si è di fatto imposta come principale garante.
Del resto, l'attuale conflitto affonda le sue radici in una turbolenza storica che dura da circa un secolo. Dopo la rivoluzione bolscevica del 1917, la regione del Nagorno Karabakh venne contesa tra armeni e azeri, fin quando – nel 1923 – fu creata l'Oblast' Autonoma del Nagorno Karabakh all'interno della Repubblica Socialista Sovietica Azera. La mossa fu probabilmente dettata dalla volontà dell'Unione Sovietica di mantenersi in buoni rapporti con la Turchia di Atatürk. A partire dal 1988, gli armeni hanno iniziato a richiedere nuovamente l'autonomia della regione, rimediando tuttavia il secco rifiuto degli azeri. Ne scaturirono scontri e atti di violenza, che si intersecarono con il progressivo sfaldamento dell'Unione Sovietica.
Nell'agosto del 1991, l'Azerbaigian lasciò infatti proprio l'Unione Sovietica, creando la repubblica dell'Azerbaigian. Nel settembre di quell'anno, il Nagorno-Karabakh si costituì in entità statale autonoma, incorrendo nell'ira degli azeri. Il il 6 gennaio del 1992 nacque comunque formalmente la Repubblica del Nagorno-Karabakh. Iniziò così un conflitto con l'Azerbaigian che sarebbe durato fino al 1994, con la stipulazione del cosiddetto Accordo di Biškek: un accordo che mise, sì, formalmente fine agli scontri (con un cessate il fuoco), ma che non ha comunque impedito situazioni di forte tensione tra armeni e azeri.
Le trattative di pace sono state avviate, nello stesso 1994, sotto l'egida dell'Osce, tramite il Gruppo di Minsk (la cui copresidenza è costituita da Francia, Russia e Stati Uniti d'America). Del Gruppo fanno inoltre parte rappresentanti di svariati Paesi, tra cui l'Italia, l'Armenia e l'Azerbaigian. Nel corso degli anni, i negoziati hanno portato a pochi risultati. Ciononostante, anche alla luce del nuovo cessate il fuoco, l'Armenia continua a sostenere la necessità di risolvere la controversia sul Nagorno con gli azeri tramite tale istituzione. E' questa del resto la posizione espressa, lo scorso 25 novembre, dal primo ministro armeno, Nikol Pashinyan. «I negoziati devono andare avanti nel quadro della copresidenza del Gruppo di Minsk dell'Osce», ha non a caso dichiarato. Il punto è che, a complicare la situazione odierna, ci si è messo il progetto del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan: progetto che mira a rafforzare in modo significativo l'influenza di Ankara nel Caucaso. La partita quindi è particolarmente delicata, perché l'atavico conflitto tra armeni e azeri si è inserito nel quadro più complesso del difficile equilibrio tra Russia e Turchia.