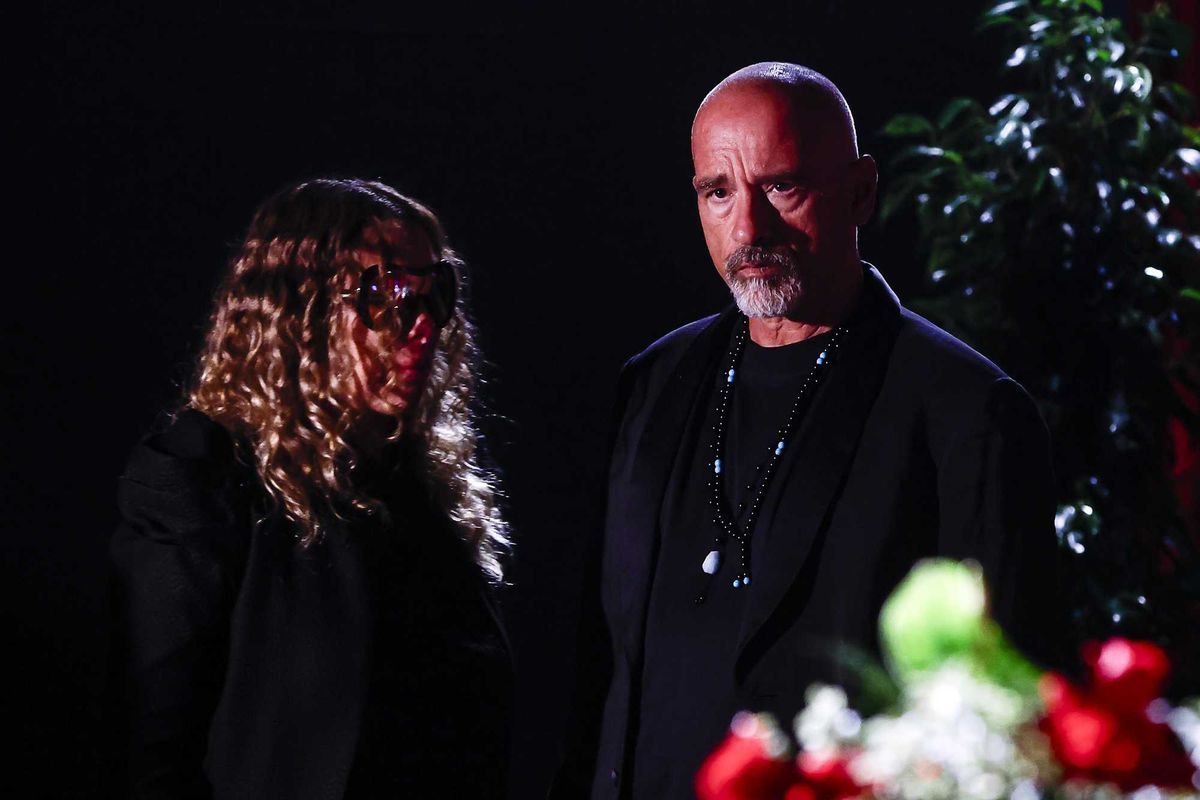Ho seguito in tv l’arrivo di Joe Biden al castello di Varsavia, nella cui piazza lo attendevano migliaia di persone. Non sembrava il viaggio di un presidente americano ai confini di un teatro di guerra, ma lo sbarco tra i fan di una star di Hollywood. Ad accoglierlo c’erano le bandiere, i bambini, le luci e la musica: una regia perfetta, certamente studiata nei minimi particolari per rubare la scena allo zar del Cremlino nel primo anniversario dell’invasione dell’Ucraina. L’inquilino della Casa Bianca sorrideva raggiante, conscio del successo dell’operazione.
In effetti, Biden ha più di un motivo per essere soddisfatto. Nonostante si moltiplichino le voci su una possibile escalation della guerra in corso, al momento tutto sembra andare per il verso giusto. Per lo meno per gli Stati Uniti. Infatti, a differenza di ciò che ci si sarebbe potuto aspettare, la resistenza ucraina si è dimostrata un osso duro per l’invasore. Al contrario di ogni previsione, Kiev è riuscita a tenere testa alle truppe di Vladimir Putin, riuscendo anche a respingerle e a mettere a dura prova perfino il controllo dei territori conquistati. Nessuno immaginava che un esercito male armato sapesse tenere botta a una delle più importanti potenze del mondo. Ovviamente, nessuno tranne gli esperti di cose militari, i quali erano a conoscenza che da anni, cioè da dopo l’invasione della Crimea, l’America stava addestrando le truppe di Kiev.
Ma a compiacere il presidente degli States non c’è solo l’incredibile resistenza ucraina. Altri e non meno secondari motivi hanno contribuito ieri sera a renderlo particolarmente allegro. Infatti, a Varsavia Biden ha potuto rendersi conto di persona non soltanto che l’orso russo era finito in gabbia, ossia intrappolato in un conflitto dal quale non sa come uscire senza perdere la faccia, ma che anche una serie di altri tasselli concorrevano incredibilmente a comporre il mosaico immaginato Oltreoceano.
Ricordate le sfuriate di Donald Trump quando sollecitava i riluttanti alleati europei a mettere più soldi nella Nato, dicendo che gli Stati Uniti erano stanchi di pagare il conto della difesa del Vecchio continente? Beh, la guerra in Ucraina ha costretto i Paesi della Ue a mettere mano al portafogli senza nemmeno che gli Usa minacciassero di smantellare le basi militari disseminate nel Vecchio continente. Dalla Germania alla Francia, passando ovviamente per l’Italia, tutti oggi stanno rivedendo il budget delle spese militari e nessuno ormai si interroga sull’utilità dell’Alleanza atlantica. Se fino a un anno fa c’era chi proponeva di smantellarla, oggi il dibattito è archiviato dai fatti.
Il cambio di scenario, non riguarda soltanto la Nato, ma coinvolge direttamente anche l’industria degli armamenti che, come noto, è una delle più importanti degli Stati Uniti. Le forniture offerte dall’America e dagli alleati alla causa di Kiev hanno contribuito a svuotare gli arsenali, al punto che l’Occidente fa i conti delle munizioni (missili, mine, cannoni, droni, eccetera) rimaste. Il prolungarsi della guerra avrà come conseguenza la necessità di rimpiazzare ciò che è stato donato o usato, con un’immaginabile conseguenza sul Pil dei Paesi coinvolti nel conflitto o quanto meno compartecipi alla resistenza di Kiev.
E quella riguardante l’industria militare non è la sola conseguenza economica del conflitto. Infatti ne esiste una che ha e avrà ripercussioni ancora più significative. Mi riferisco agli assestamenti che la guerra sta provocando sui Paesi più industrializzati e in particolare su quelli europei, a cominciare dalla Germania. Il Prodotto interno lordo tedesco ha subìto una brusca frenata, anche a causa del venir meno del combustibile a basso costo importato da Mosca. Senza il gas russo, Berlino è stata costretta a rallentare. Quella locomotiva che anno dopo anno accumulava un surplus commerciale che tanto dava fastidio agli Stati Uniti, ora arranca. Non so se ricordate quel brutto affare chiamato Dieselgate. Qualche anno fa l’America accusò la Volkswagen, ossia il primo produttore mondiale di automobili, di aver taroccato i dati sulle emissioni inquinanti delle sue vetture e per il gruppo di Wolfsburg fu una brutta botta. Seguirono ovviamente le accuse ad altri marchi automobilistici, quasi tutti made in Germany. Ora, conoscendo l’attenzione della Ue al tema delle polveri sottili, chiedo a tutti voi: è possibile che le vetture europee inquinassero più di quelle americane? La mia risposta è no. Ma l’inchiesta ha funzionato meglio di una misura protezionistica, perché ha avvantaggiato la concorrenza a stelle e strisce. Ad ogni buon conto, oggi l’industria tedesca ha altri problemi e non a caso la Germania, che fino a ieri era contraria agli aiuti di Stato, oggi pare averci ripensato. Le regole europee che apparivano ferree, all’improvviso, toccando nel profondo gli interessi di Berlino e Parigi, appaiono all’improvviso assai meno solide.
Inoltre, c’è un ulteriore motivo che deve aver reso felice il presidente americano ed è costituito dai riflessi che il conflitto ucraino ha sugli equilibri mondiali. Se fino a ieri un successo di Mosca avrebbe potuto spingere la Cina a invadere Taiwan, la sconfitta o anche solo la battuta d’arresto russa sarebbero di monito anche per Pechino, che d’ora in poi dovrebbe pensarci due volte prima di decidere l’occupazione manu militari di Taipei.
C’è infine un ultimo aspetto che non può essere sottovalutato. Compattare l’Europa in una Nato a guida americana, rimettere in moto l’industria degli armamenti, fare affari d’oro con il gas liquido che ha sostituito quello russo, dare un colpo se non mortale per lo meno decisivo alla Germania e un altolà alla Cina, sono risultati ottenuti senza sparare un colpo. Un tempo, tutte quelle sopra elencate sarebbero state ragioni per scatenare un conflitto, perché sia gli interessi economici che quelli geopolitici spesso erano difesi con le armi. In questo caso no. Gli Stati Uniti non hanno schierato le loro truppe e nemmeno hanno dovuto contare i propri morti, come avvenuto in Vietnam, in Iraq o in Afghanistan. Il gendarme del mondo ha ottenuto i risultanti senza impegnarsi in prima persona. Certo, le vittime le contano altrove. Ma questo è un altro discorso, che non ha comunque guastato il buon umore mostrato l’altra sera dal commander in chief.