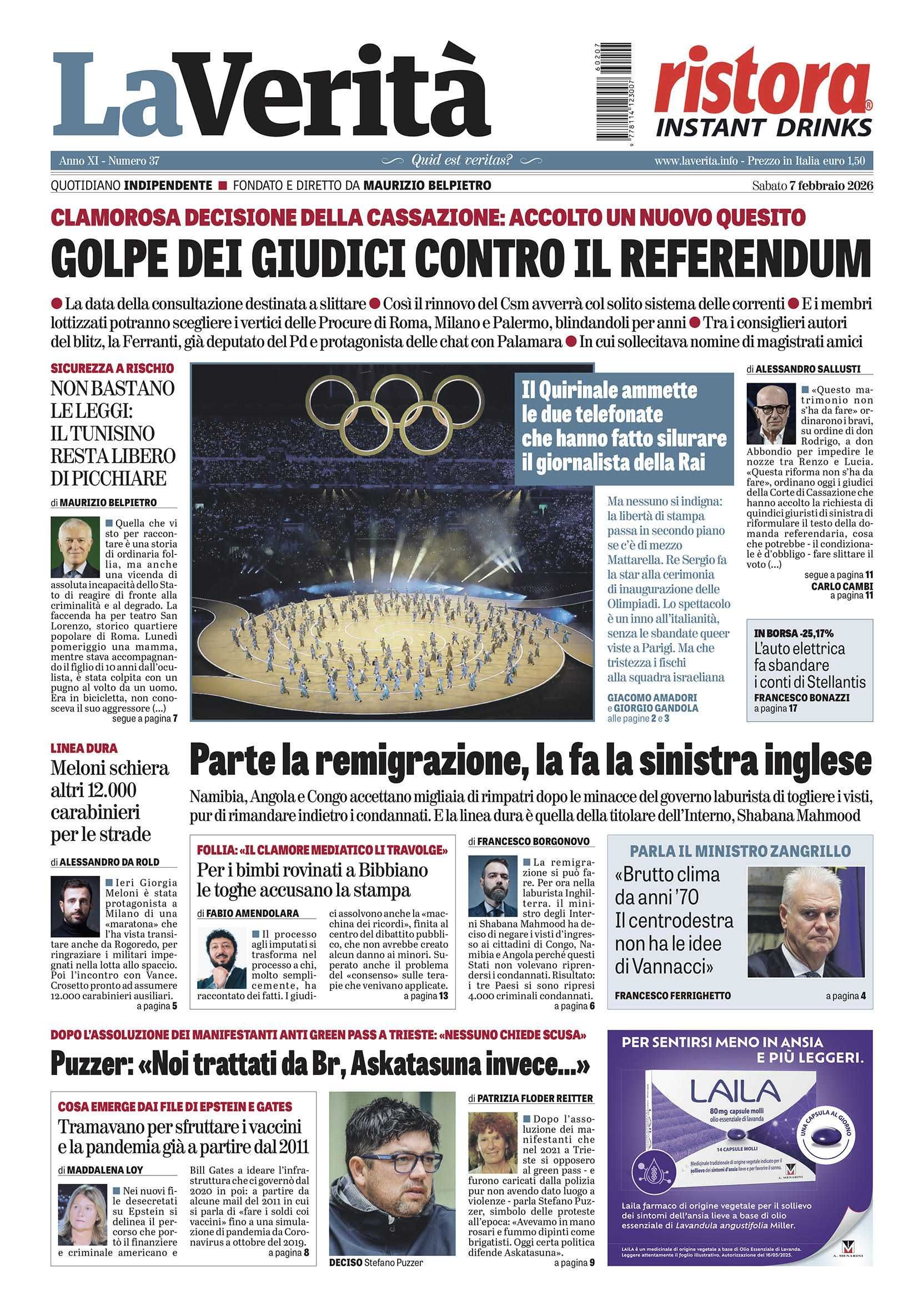Bibbiano, ora i giudici incolpano i giornali: «Il loro clamore ha travolto i bimbi»

C’è un passaggio nelle 1.650 pagine di motivazione della sentenza che chiude il primo grado di «Angeli e demoni», la maxi inchiesta della Procura di Reggio Emilia fatta a pezzi dalla trimurti della Sezione penale, Sarah Iusto (presidente), Michela Caputo e Francesca Piergallini (a latere), che scarica tutto il peso sui media.
Con una frase secca: il «clamore mediatico» avrebbe «travolto non solo le sorti dei bambini e dei loro familiari ma, con conseguenze non calcolabili, le vite degli imputati, e per quanto qui rileva, degli stessi testimoni». È il passaggio che trasforma il processo agli imputati nel processo a chi ha raccontato l’inchiesta. E che tenta di trasformare Bibbiano da caso giudiziario a cortocircuito comunicativo. Ma solo poche righe prima, il Tribunale aveva scritto che l’impianto accusatorio poggiava su «premesse davvero fragili, in quanto opinabili e poco ancorate ai fatti». Che, però, avevano retto al primo filtro, quello dell’udienza preliminare (che portò al rinvio a giudizio di 14 imputati).
Il primo cortocircuito giudiziario emerge proprio qui: ammettere che il filtro a monte non ha funzionato impatta con il clamore come causa (e non come conseguenza) del disastro. Un capovolgimento perfetto, in cui il «clamore mediatico» viene evocato come una specie di calamità naturale e non come un prodotto delle carte giudiziarie. E sarebbe stato tale da produrre addirittura una «contaminazione dei dichiarati (le testimonianze dei minorenni, ndr)». Oltre che un «danno all’immagine e alla reputazione delle istituzioni, nonché una lesione della fiducia che la collettività di riferimento riponeva in esse». Le valutazioni delle toghe attraversano trasversalmente i capi di imputazione e spiegano perché, dopo 146 udienze e richieste di condanne avanzate dalla Procura (fino a 15 anni di pena), siano arrivate solo tre condanne, tra i 5 mesi e i 2 anni, tutte con pena sospesa. Secondo i giudici, «non è stata raggiunta la prova del dolo» necessario a sostenere le accuse di falso ideologico e di induzione in errore dell’autorità giudiziaria. Le relazioni dei servizi sociali vengono ricondotte a «valutazioni tecnico-professionali», probabilmente discutibili ma non dimostrate come consapevolmente mendaci. L’errore valutativo, sottolinea infatti il Tribunale, «non coincide automaticamente con il falso penale». Particolarmente significativo il giudizio sulla posizione di Federica Anghinolfi, ex responsabile dei Servizi sociali dell’Unione Val d’Enza, individuata dall’accusa come figura apicale del presunto sistema. Le motivazioni rilevano che le contestazioni a suo carico si sono concentrate «in modo pressoché esclusivo sul ruolo dirigenziale», accompagnate da una «enfatizzazione di profili attinenti alla sua personalità e alla sua vita», fino ad arrivare a imputazioni riferite anche a relazioni che l’imputata «non risulta avere neppure firmato».
Sul fronte delle psicoterapie e delle presunte manipolazioni dei minori, la sentenza esclude che sia stata dimostrata la «provocazione intenzionale di gravi lesioni psicologiche». Anche l’uso (con tanto di applicazione di elettrodi) dello strumento noto come «Neurotek», diventata nota come «la macchinetta dei ricordi» e finita al centro del dibattito pubblico, viene ridimensionato: i giudici scrivono che «si esclude che dall’utilizzo di Neurotek siano derivati rischi per i bambini». Crollano anche le ricostruzioni sui «falsi ricordi» che secondo l’accusa sarebbero stati ingenerati nei bambini per dimostrare abusi in realtà mai avvenuti. «La debolezza sotto il profilo scientifico e metodologico degli elaborati delle consulenti tecniche del pm», scrivono i giudici, «che oltretutto si sono affidate a una teoria quale quella dei falsi ricordi che non risulta unanimemente condivisa dalla comunità scientifica, non può costituire la base su cui fondare un accertamento improntato al canone dell’al di là di ogni ragionevole dubbio».
A rafforzare la decisione sono arrivate alcune testimonianze. In aula si è sostenuto che il «dispositivo non ha una ripercussione dannosa nota sulla salute del paziente e che non vi sono studi che vertano sugli effetti dell’uso […] al di fuori del protocollo». Anche la questione legata al «consenso» rispetto a queste terapie è stata superata. In uno dei casi esaminati «è stato dimostrato che i genitori […] sottoscrissero il modulo di consenso informato con cui autorizzavano l’avvio del percorso di psicoterapia». Dopo la sospensione della potestà genitoriale fu nominato come «tutore provvisorio il Comune di Bibbiano, nella persona del sindaco pro tempore». Ed ecco l’argomentazione che risolve tutto: «All’epoca in cui fu utilizzato il dispositivo Neurotek […] il soggetto deputato a prestare il consenso informato all’utilizzo dello strumento in questione era il Comune di Bibbiano, che, in base all’ordinaria ripartizione di competenze interna all’amministrazione comunale, delegava la concreta gestione della tutela al Servizio sociale». E quindi «può trarsi la conclusione che vi fosse il pieno consenso del Servizio sociale allo svolgimento della psicoterapia». Le uniche responsabilità rimaste in piedi vengono ricondotte «a singoli episodi amministrativi o documentali», ma escludono l’esistenza di un sistema illecito nella gestione degli affidi. L’istruttoria, secondo i giudici, avrebbe dimostrato come gli operatori dei servizi sociali finiti sotto accusa «abbiano sempre agito su specifico mandato del Tribunale per i minorenni, che rendeva quindi doverosa la loro azione (come per gli allontanamenti e le successive collocazioni etero-familiari), oppure nell’ambito di quanto dallo stesso Tribunale loro delegato (come di prassi si prevedeva per l’avvio e la gestione degli incontri protetti)». Un metodo che ora viene completamente riabilitato: «Gli stessi (operatori dei servizi sociali, ndr) hanno sempre, costantemente, aggiornato l’autorità giudiziaria», ovvero quei giudici del Tribunale per i minorenni che, stando alla Procura, avrebbero invece voluto ingannare. «Sebbene molte di queste siano state tacciate di falsità», valuta il collegio, «non ci si può esimere dal rilevare come anche tali contestazioni risultino smentite, o comunque indimostrate, all’esito della complessa istruttoria svolta». E alla fine, quindi, i servizi sociali «si basavano, a ben vedere, su valutazioni tecnico-professionali, di competenza propria degli operatori, di cui non si è provata né l’abnormità né l’erroneità, così come neppure si è dimostrata la falsità dei dati di fatto su cui si fondavano». Un cortocircuito giudiziario perfetto.