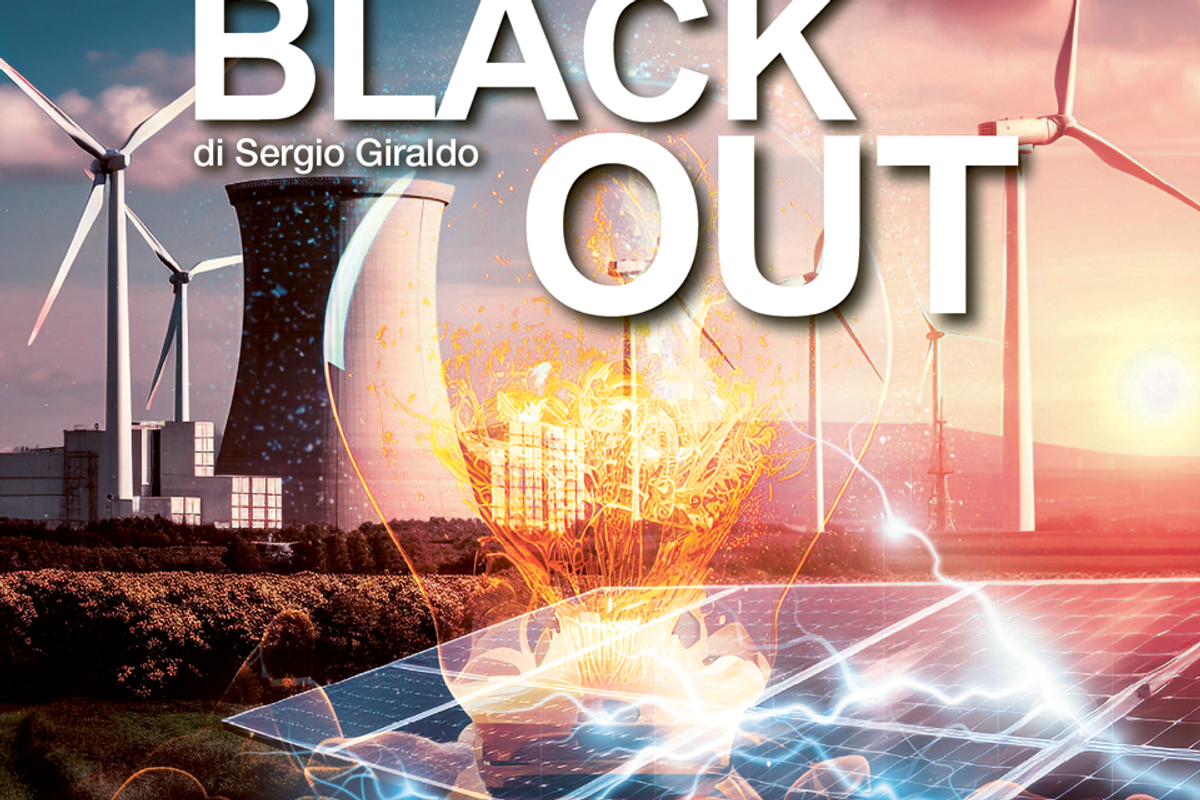Esiste, in Italia, come negli Stati Uniti, il diritto di detenere armi? Tecnicamente, no. Ma c'è un limite all'arbitrio di cui possono godere le autorità di pubblica sicurezza nel regolamentare la materia? Certamente sì. Lo dimostrano numerose sentenze e, forse, lo prova la vicenda accaduta di recente a Padova.
Alcuni mesi fa, il questore Isabella Fusiello aveva fatto recapitare ai collezionisti di armi una singolare comunicazione. Un ordine con il quale si imponeva un «limite massimo di armi detenibili complessivamente»: non più di 100 pezzi. Ai cittadini che ne avevano di più, veniva intimato di disfarsene entro 90 giorni. Tutti ricorderete, però, qual era la situazione epidemiologica del Paese in quei mesi invernali e quali regole vigevano: era proibito uscire dalla propria Regione, a volte dal proprio Comune, quando scattavano le zone arancioni. Per quasi tutti i padovani interessati dalla disposizione della Questura, le nuove regole significavano dover destinare alla distruzione le proprie armi. Spesso, veri e propri pezzi d'antiquariato.
Ma la normativa vigente, secondo la quale si possono detenere solo tre armi da fuoco classificate come «comuni», 12 classificate come «sportive» e un numero illimitato di fucili da caccia, non fissa alcun numero massimo di esemplari che si possono custodire a scopi collezionistici. Certo, nel nostro Paese, la facoltà di detenere armi è una sorta di gentile concessione delle autorità, le quali, dunque, possono imporre criteri più stringenti, in caso di necessità. Le restrizioni, tuttavia, non devono essere del tutto arbitrarie. E nel caso di Padova, era difficile scorgere una qualche ragione di pubblico interesse nell'imposizione del limite di armi collezionabili.
Il questore avrebbe sostenuto che non è «ammissibile che un singolo cittadino possa detenere centinaia di armi». Ma perché? La sicurezza pubblica è forse in pericolo? E allora, cosa cambia tra possedere 100 pistole o 200? Tra l'altro, i collezionisti non sono autorizzati a detenere il relativo munizionamento, a meno che l'arma in collezione non sia dello stesso calibro di un'altra già detenuta per scopi sportivi o di caccia.
Fortunatamente, i cittadini non hanno accettato supinamente un ordine tanto illogico. E dopo i ricorsi Tar, hanno ottenuto almeno la sospensione del provvedimento della Questura. La vicenda, peraltro, è stata portata all'attenzione del Parlamento, con un'interrogazione firmata dai senatori di Fdi, Giovanbattista Fazzolari, Adolfo Urso e Luca De Carlo. Il documento degli onorevoli tocca esattamente il punto, nel momento in cui chiede al ministro Luciana Lamorgese se «i questori abbiano il potere di interpretare a proprio piacere le leggi dello Stato italiano e, in particolare, quelle relative al legale possesso di armi da sparo». E la verità è che, questo potere, non ce l'hanno. La discrezionalità e l'arbitrio delle autorità di pubblica sicurezza incontrano certamente dei limiti, anche se la nostra Costituzione non ammette nulla di lontanamente paragonabile al secondo emendamento della Carta fondamentale americana, nel quale si legge: «Essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero una ben organizzata milizia, il diritto dei cittadini di detenere e portare armi non potrà essere infranto».
Fazzolari, Urso e De Carlo, peraltro, colgono alla perfezione cosa c'è davvero dietro la mossa del questore Fusiello: motivazioni «non riconducibili a fatti contingenti o a situazioni emergenziali ma solamente di tipo ideologico». Curiosamente, il questore di Padova, anni prima, a Reggio Emilia, aveva adottato lo stesso, irragionevole provvedimento. Ma stavolta, la crociata anti armi non filerà così liscia.