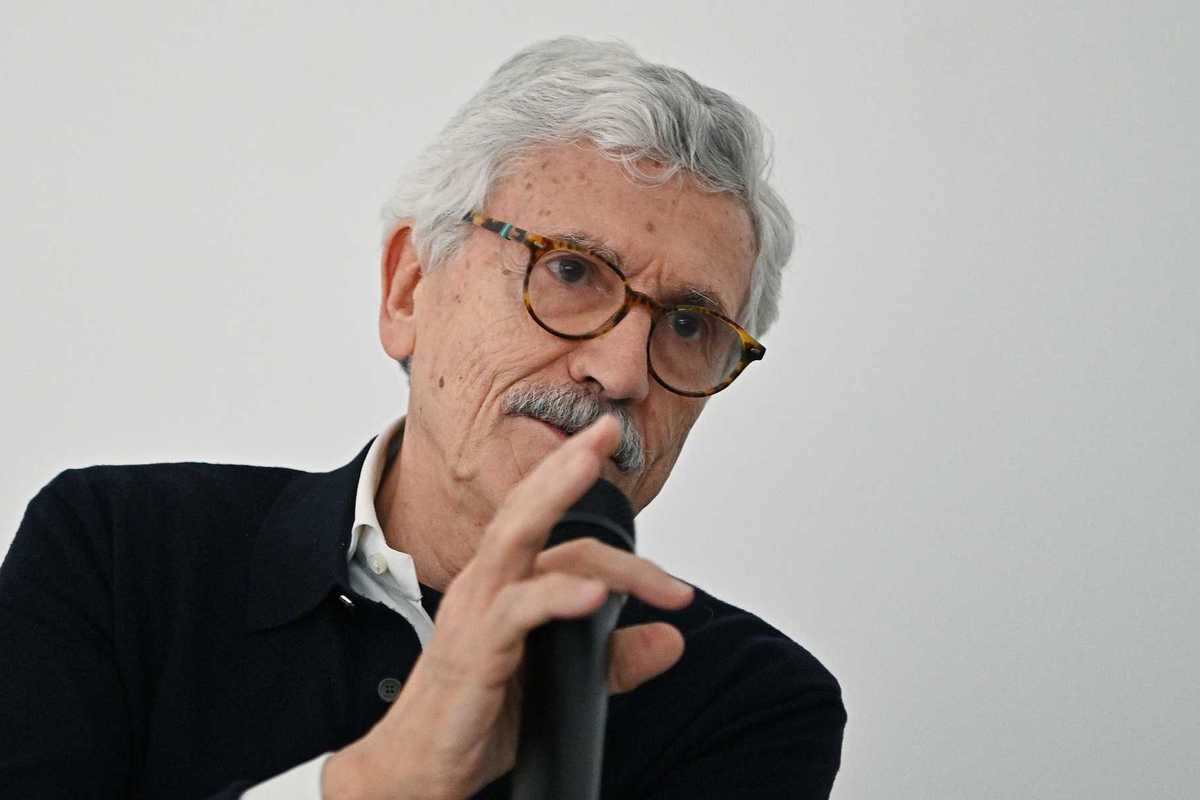Nei giorni scorsi sono tornato a Roma. Il solito traffico isterico, i Fori imperiali, le battute taglienti dei romani. I viali a platano, il corso del Tevere, la cupola di Michelangelo e le macchie di pino che compaiono e scompaiono a lato strada. Ma questa volta non sono qui per restare, per visitare e giudicare lo stato di degrado della città eterna, no, sono qui per ripartire immediatamente alla volta di uno dei nostri santuari naturali.
In tre ore raggiungiamo il cuore del Parco d’Abruzzo, il secondo dei nostri parchi nazionali, fondato nel 1922 per iniziativa privata di un manipolo di proto-ecologisti e alcuni sindaci coraggiosi dei comuni interni di una delle più isolate e forestali aree del Paese, e riconosciuto dallo Stato il 1 gennaio dell’anno successivo. Una manciata di mesi prima un decreto regio aveva istituito il Parco del Gran Paradiso. Un secolo fa iniziava dunque ad emergere questo paese altro, capace di tutelare animali, piante ed ecosistemi e che oggi noi possiamo finalmente vedere, ma che al tempo era frutto della fantasia di pochissimi, un atto di fede, se vogliamo, una scommessa, forse anche imitazione di quel che era già accaduto ad esempio mezzo secolo prima in Nordamerica.
I boschi che ammiriamo passando il confine tra Lazio e Abruzzo sono appesi ai fianchi dei monti, incastonati come gioielli preziosi e colorati. Macchie di gialli di varia tonalità, acero riccio e acero montano, faggi (gli alberi più diffusi), frassini e sorbi, soprattutto, e poi verdoni scuri, cerri e roverelle, pino mugo e pino nero, e alcuni rosa, ma sono i rossi vivaci degli opali che strabiliano, catturando l’attenzione e te ne innamori subito. Chi guida mi dice più volte: che bello, ne vorrei avere uno a Roma. Nei boschi del Nord Italia l’acero opalo non c’è, lo si vede molto in Appennino e in alcune zone, come questa. Non so se riuscirebbe a sfavillare in un giardino di città come fa qui, sotto questo cielo vasto e avvolto da questo silenzio cantato.
Nel corso delle ultime stagioni diverse faggete italiane sono state riconosciute dall’Unesco per il loro alto valore naturalistico e sono diventate parte del Patrimonio dell’Umanità. Ad oggi ci sono 13 faggete riconosciute nei parchi del Pollino, Gargano, Foreste Casentinesi, Aspromonte, Monte Cimino e diverse proprio qui, nel cuore del Parco d’Abruzzo. Noi siamo diretti a Villetta Barrea, la nostra strada risale tra le pinete e si avventura verso il passo Godi, ma un’altra strada sarebbe proseguita nei comuni di Opi, Pescasseroli, Lecce dei Marsi e Villavallelonga, dove sorgono questi importanti boschi - Moricento a Lecce nei Marsi, Coppo del Morto e Coppo del Principe a Pescasseroli, Cacciagrande a Opi e Val Cervara a Villavallelonga.
A Villetta Barrea seguiamo la strada per Scanno che risale per mezz’ora fino al passo Godi, dove ci attende il meritato ristoro. Al ristorante Lo Scoiattolo trangugio una zuppa di fagioli davvero buona, il sole è scomparso e un vento tagliente nasconde i visi dei pochi turisti fuori stagione. Ritorniamo verso Villetta per un chilometro e 400 metri circa, ad una curva parcheggiamo e ci inoltriamo lungo un sentiero che conduce in faggeta, dove si trova il più annoso e grande faggio del Parco Nazionale: il celebre faggio del Pontone. Non è la mia prima visita, l’ho già ammirato in precedenza. Una volta ho anche accompagnato un piccolo gruppo di appassionati, qui in studio da qualche parte c’è la foto che ci scattarono. Le misure: otto metri e mezzo di circonferenza del tronco, due grossi rami che salgono fino ai 15, 16, forse 18 metri. Il faggio del Pontone è stato stimato dai 500 agli 800 anni di età ed è l’insieme di diversi faggi concresciuti e oramai fusi.
Ho cercato notizie riguardanti il suo nome, ma non ne ho trovate. Credevo si trattasse del nome della località o del bosco stesso, ma le mappe non lo confermano. Esiste una fonte qui vicino, chiamata del Pantone, su alcuni documenti, e del Pontone, su altri, ma come sopra la sua origine non viene definita.
Una novità: guardandolo dal sentiero che si percorre e ci inoltra nella prima parte della faggeta la grossa branca che si innalzava alla sua destra è precipitata, e ora giace appoggiata per una lingua di legna al resto dell’albero, e a terra, quasi un albero a sé. Nonostante questa perdita la sua mole resta immensa, e la si può constatare girandoci intorno, perché il braccio poderoso che tiene ancora innalzato verso la calotta della faggeta è ovale, o meglio, mostra una sua monumentalità soltanto girandoci attorno. In queste prime ore di pomeriggio la luce che penetra dall’alto va a sbattere contro la parte retrostante del faggio, ed è qui che fotografandolo si possono ottenere gli esisti di luce più interessanti.
Tante muschiature sparse, colonie di licheni, e segni, molteplici, di una presenza massiccia di funghi nella sua esistenza. Diversi carpofori compaiono sui legni, e altre parti sono intrise di umidità. Anche le altre volte mi pareva un albero sì vasto ma fragile, ma questa volta direi molto di più. Potrebbe abitare questi boschi ancora a lungo ma potrebbe anche accadere qualcosa e non mi stupirei di ricevere una notizia triste. Si vedrà, o vedranno coloro che ci saranno. Dal mio taccuino estraggo una natura miniata e la leggo a voce sommessa: ogni tanto restituisco ai boschi quel che mi hanno generosamente donato ispirandomi, e placando gran parte delle mie turbolenze d’animo; ho restituito tante parole nei boschi e nelle foreste dove sono stato, e ora tocca anche a questa faggeta sui rilievi del monte Godi.
A proposito, una notizia di carattere storico: questo grande albero oggi è diventato simbolo del Parco Nazionale, ma soltanto dal 1976, anno in cui questi territori sono entrati a far parte della gestione e quindi della protezione dell’ente, in precedenza ne erano al di fuori. Questo è bastato affinché l’albero venisse adeguatamente censito, studiato e ne divenne, in mezzo secolo, uno dei simboli più amati. In Abruzzo metà del territorio ricade nei confini di una riserva naturale, ospitando 73 piante monumentali.
Mentre ci orientiamo alla ritrovata luce del pomeriggio, le nebbie iniziano a tagliare le cime dei monti, carambolando verso altitudini più prossime alla nostra. Vediamo dei cavalli che scalciano lungo la strada e poi autonomamente rientrano oltre una fune e scompaiono nei pianori, e poi due daini che si rincorrono tra i banchi di faggio sui rilievi opposti. In cielo non si vedono grandi rapaci, l’autunno sembra sul filo di spezzarsi.