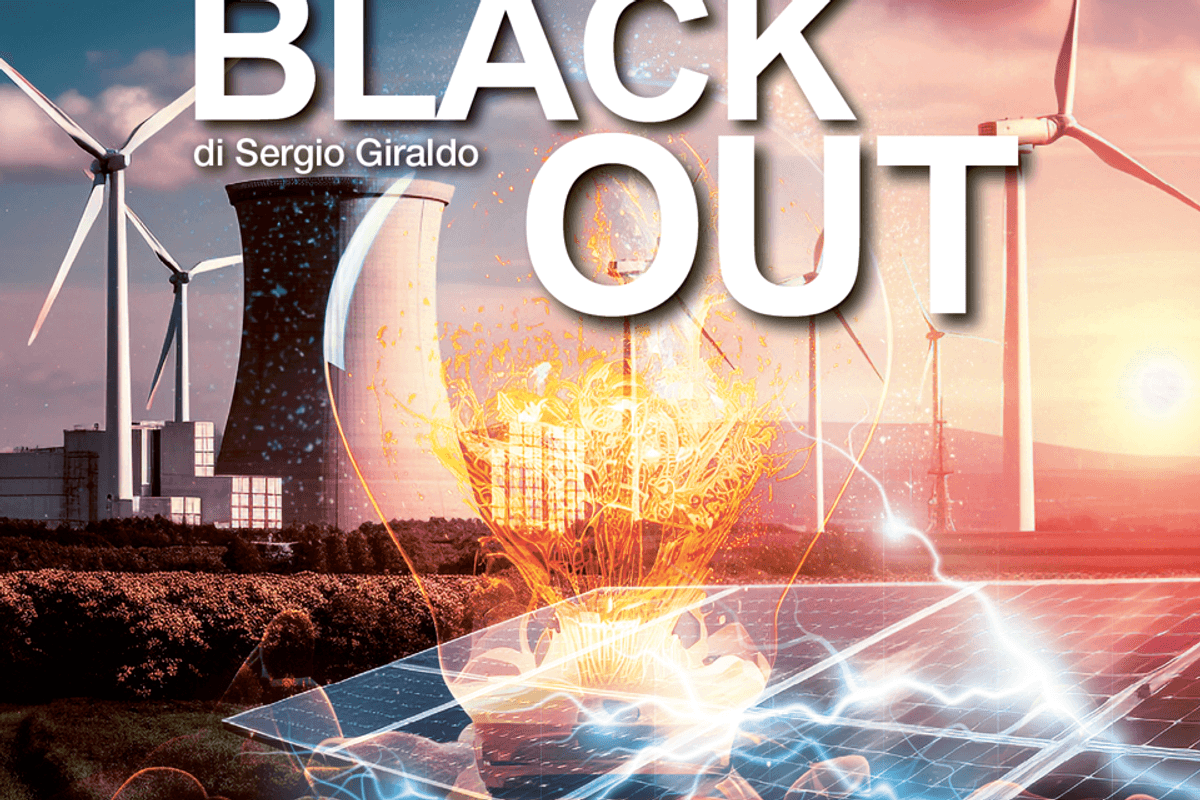La cucina dell'Urbe ha avuto diversi ambasciatori che l'hanno resa meta golosa nella memoria collettiva. Pensiamo ad Alberto Sordi in Un americano a Roma in cui Nando Mericoni, dopo aver inutilmente tentato di ingurgitare piatti yankee, si riappropria della propria identità davanti a dei maccheroni: «m'hai provocato, e io ti distruggo adesso, e te magno». Origini che partono da lontano, come ha ricordato recentemente su queste pagine Gemma Gaetani nella sua rubrica «Salute e benessere», con un richiamo neanche tanto velato a un tempo in cui la cucina quotidiana doveva fare i conti con la realtà e solo pochi potevano permettersi quei pranzi luculliani che hanno segnato un'epoca, che però poi ha portato ad una lenta decadenza. In questa puntata di «Storia in tavola» proviamo quindi a ricostruire quel lungo percorso della cucina romana che è arrivata ai nostri giorni, fra tradizione (molta) e innovazione, (non sempre) ben temperata.
Nella Roma repubblicana erano le stesse leggi a richiamare a una certa morigeratezza, limitando ad esempio i giorni in cui si potevano allestire banchetti; cercando di regolare eccessi di spesa alimentare; scoraggiando i giudici in carica ad accettare inviti a cena. Con lo ius osculi era proibito alle donne di dedicarsi ai piaceri di Bacco tanto che il pater familias aveva la facoltà di baciarle a fior di labbra per capire se avessero trasgredito. Le pene potevano essere pesanti. Gli scenari infatti erano cambiati con la vittoria su Cartagine così che Roma assunse praticamente il controllo sulle rotte, anche commerciali, del Mediterraneo e l'arrivo nella capitale di svariate merci, alcune necessarie, frumento, altre decisamente voluttuarie, privilegio di pochi. Tanto da divenire, con una felice sintesi di Valentina De Felice, «il ventre ingordo del mondo». I fornai aprirono le loro botteghe e quindi si ampliò l'offerta di un prodotto che prima era a dimensione domestica. Vi erano pani specificatamente dedicate a certi abbinamenti, quali ad esempio l'ostearus per fare la scarpetta con le ostriche. Un curioso piatto estivo rinfrescante il sala cattabia. Mollica messa a bagno nella posca, una miscela di acqua e aceto. A parte una salsa con menta e coriandolo cui si aggiungevano miele, formaggio fino ad ottenere una crema. Strizzato il pane si ricopriva con questa e si impiattava con una decorazione finale di neve conservata nelle ghiacciaie.
Lucullo è sempre stato abbinato alle sue sontuose performance luculliane, ma pochi sanno che, in realtà, è stato un militare di vaglia, persona di profonda cultura. Fu lui a portare in Italia, dopo una vittoriosa spedizione in Asia minore, le ciliegie. Una volta ritiratosi e deposta lorica (corazza) e spada si dedicò alla pescicoltura di specie pregiate quali aragoste, murene, molto in voga a quel tempo. Vi fu chi, come Cicerone, volle metterne alla prova la fama conquistata tra i fastosi triclini dell'epoca, equivalenti alle sale da pranzo. Lo sfidò ad invitarlo seduta stante nella sua villa per vedere cosa poteva trovare. Lucullo mandò un messaggio alla servitù: «Tra poco arrivo con degli ospiti nella sala d'Apollo». Cicerone e il suo seguito trovarono degni vassoi ad attenderli: pasticci d'ostrica, pernici, murene farcite con spezie esotiche. Il generale aveva ben allenato i suoi. «Lucullo cena da Lucullo» disse un giorno a una giovane recluta dei fornelli. Negli annali risulta che il suo piatto preferito fosse il tordo.
Di tutt'altro spessore Apicio, che Catone amava bollare come «il più grande scialacquatore e crapulone di tutti i tempi» in quanto se è vero che gli storici ricettari romani si rifanno a sue spesso fantasiose invenzioni culinarie, avvenne poi che dilapidò tutto inseguendo le sue bizzarre fantasie. Era un illusionista del piatto. Gli piaceva giocare tra sculture edibili e sostanza vera, tanto che i suoi invitati, stesi sui lecti triclinaries (i divani golosi) spesso tiravano a indovinare cosa gli venisse servito, ad esempio cosa si nascondesse dietro il patina de apua sine apua, ovvero il piatto di acciughe senza acciughe. Ebbe degni epigoni, come Vitellio, ottavo imperatore (che durò solo pochi mesi) il quale si deliziava con lo scudo di Minerva, in cui le papille dei commensali dovevano confrontarsi con fegati di pesce pappagallo (ricercatissimo all'epoca), cervella di fagiano e pavone, lingue di fenicottero e latte di murena.
Nulla a che vedere con il morigerato Augusto, primo imperatore, la cui dieta era essenziale: pane e fichi. Fichi ben radicati nella tradizione romana. Lo stesso Catone un giorno portò in Senato un cesto di questi.
Certi eccessi della nomenklatura capitolina non passarono inosservati all'occhio ironico degli autori dell'epoca tanto che Petronio, nel suo Satyricon, descrivendo la cena di Trimalcione, racconta di determinate invenzioni culinarie che non si distaccavano poi troppo da certe realtà che si potevano incontrare nelle notti romane. La servitù apre le danze con una gallina di legno con grandi uova di struzzo appoggiate sulla paglia. All'interno un beccaccino condito con salsa piccante. A seguire un asinello di bronzo con due sacche di olive ai lati e, sulla groppa, grandi vassoi con ghiri al miele conditi con il papavero. Ghiri molto in voga e ricercati, tanto da venire allevati nelle glirarie con tecniche diverse come racconta Varrone. Dentro orci di terracotta con dei fori per poter respirare, oppure in apposite botti con coperchio, nutriti con noci, ghiande o castagne.
Ma forse la massima creatività dei cuochi, prevalentemente di origine greca, si realizzava con il maiale, non solo come siamo abituati anche oggi a gustarlo in polpetta o arrosto, ma con ben più sofisticate preparazioni. Come appetizer si iniziava con mammelle di scrofa condite con salamoia di tonno. Poi vi era il maiale ortolano, eviscerato e lasciato intero, farcito come uno zoo a quattrozampe con tordi, beccafichi, lumache, datteri ed erbe assortite. Passato in forno veniva infine decorato con l'immancabile garum, miele, olio, vino passito, giusto per non farsi mancare nulla. E che dire del porcellum laureatum, che non era una goliardata d'antan, quanto la farcitura con alloro, ovvero il laureum, anche se, forse, un tocco ironico c'era, posto che laureatum, all'epoca, stava anche a significare Imperatore, il quale nell'iconografia classica risultava incoronato con una ghirlanda d'alloro.
Si potrebbe continuare a iosa con altre citazioni lungo una carta dei menù senza confini, non solo di fantasia, ma anche geografiche, vista l'estensione cui giunse l'impero dei Cesari e quindi anche con l'arrivo delle componenti più diverse, come ad esempio le tartarughe che dovevano essere rigorosamente di origine arabica. Spezie ricercate da ogni dove con un mercato dedicato, la horrea piperatoria, espressamente voluta da Domiziano. Studi archeologici hanno permesso di calcolare che, nei suoi magazzini, venissero custodite spezie per complessive 5.800 tonnellate. Tanto che, quando i Visigoti saccheggiarono Roma, per invogliarli a riprendere la via delle paludi gli venirono offerte 5.000 libbre d'oro, 3.000 d'argento e altrettante di pepe. Spezia molto ricercata il silfio, ora estinto. Una specie di finocchio gigante. Era il volano economico di Cirene, tanto da esserne il simbolo, e ricordato ancora oggi in stemmi importanti, uno su tutti quello dei nostri paracadutisti della Folgore.