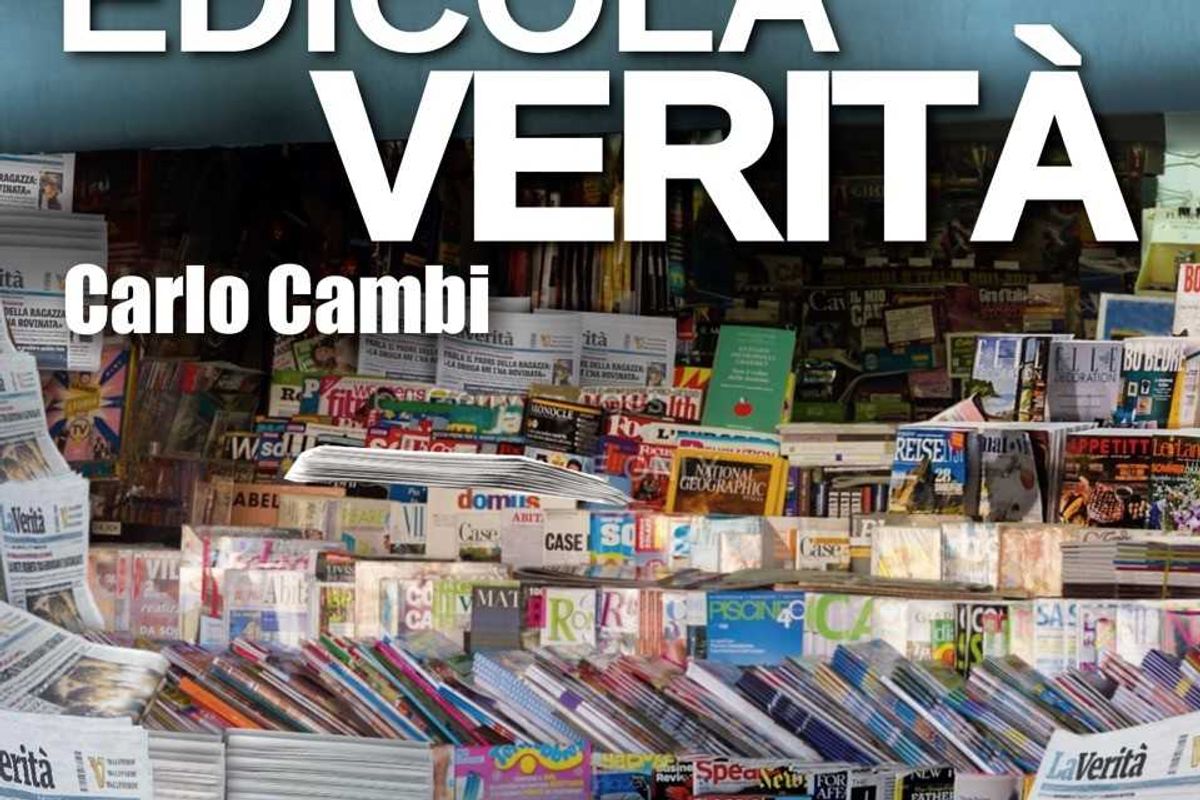La climatologia richiede il concorso di una moltitudine di competenze: dalla statistica alla fisica, dalla chimica alla geologia, perfino la storia e l’arte e, infine, ma non ultime, le scienze agrarie. E Luigi Mariani è, appunto, professore di Agronomia all’Università di Brescia, con anni di ricerca in agrometeorologia, della cui omonima società è stato per dieci anni presidente. Ha anche diretto il servizio agrometeorologico regionale della Lombardia, in stretta collaborazione col Wmo, (Organizzazione meteorologica mondiale).
Professor Mariani, può l’agricoltura adattarsi al clima che cambia?
«Nell’ultimo secolo l’agricoltura mondiale ha affrontato mutamenti socio-economici che non hanno precedenti nella storia umana: la popolazione mondiale, dalla notte dei tempi al di sotto del miliardo d’abitanti, è passata nel solo ultimo secolo agli 8 miliardi odierni. Una popolazione, peraltro, sempre più urbana, lontana dalle fonti di cibo. A fronte di tutto questo, il sistema agricolo globale, se ci pensiamo, ha fatto miracoli: oggi è il 10% della popolazione che vive al di sotto della sicurezza alimentare, mentre era il 50% nel 1945 (dati Fao)».
A cosa il merito di tanto successo?
«Alla disponibilità senza precedenti di nuove tecnologie nei settori della genetica (varietà geneticamente migliorate con tecniche sia tradizionali che Ogm) e delle tecniche colturali (meccanizzazione, concimi di sintesi, fitofarmaci sempre più efficaci, nuovi sistemi d’irrigazione)».
Il cambiamento climatico d’oggi?
«Intanto, va detto che il cambiamento climatico d’oggi non ha nulla di speciale rispetto a quello del passato: il cambiamento climatico è una costante della storia della Terra, e lamentarsi per esso è come lamentarsi che fra qualche mese arriva l’estate. Per il clima che cambia, allora, non ci saranno problemi se lasceremo aperte le porte all’innovazione evitando di farci forviare dai miti degli “antichi saperi” e delle “agricolture naturali”».
Ma come, l’agricoltura non è naturale?
«Se “naturale” significa senza l’intervento dell’uomo, allora no, l’agricoltura non è natura. Ma la domanda può essere derubricata come ozioso dibattito: l’aereo che vola senza cadere è natura? Certo che lo è: esso vola seguendo precise leggi della natura, che però l’uomo col suo ingegno sa mettere a proprio vantaggio. L’agricoltura è una delle più geniali invenzioni dell’uomo, che con la rivoluzione neolitica ha creato una inedita simbiosi con piante coltivate e animali domestici. Sono occorse profonde modificazioni, sia nell’uomo sia in animali e piante».
Per esempio?
«Nell’uomo, si pensi all’acquisita tolleranza al lattosio negli adulti. Per le piante, cito l’antenato selvatico dei frumenti coltivati che ha 14 cromosomi, mentre il grano tenero ne ha 42. Questo aumento nel numero di cromosomi è avvenuto grazie ad incroci con graminacee del genere Aegilops che i nostri antenati hanno selezionato oltre 6.000 anni fa, creando in sostanza degli Ogm ante litteram. Il pane e i biscotti che mangiamo, ci piaccia o no, sono Ogm».
I Verdi sono contro gli Ogm...
«Forse dovrebbero studiare di più. Il rifiuto degli Ogm in agricoltura è frutto di una temperie ideologica. Peraltro, è da decenni che mais e soia Ogm sono regolarmente importati in Europa e, consumati dai nostri animali di allevamento, giungono sulle nostre tavole senza provocare, di tutta evidenza, alcun effetto negativo sulla salute umana. Suona paradossale che a paladino delle “agricolture naturali” si sia posto il movimento ambientalista, il quale non si è reso conto che se non vi fosse stata l’innovazione tecnologica in agricoltura le rese per ettaro delle colture sarebbero la metà di quelle odierne, il che ci costringerebbe oggi a impegnare in arativi il doppio dei terreni impegnati oggi, e questo a spese di boschi e praterie naturali. Per esempio, se la superficie a bosco in Italia è passata in 100 anni da meno di 6 a più di 11 milioni di ettari è merito dell’innovazione in agricoltura, che ha portato le rese del frumento dai 10 quintali per ettaro del 1900 ai 60 quintali per ettaro odierni».
Sempre gli ambientalisti ci dicono di tornare al biologico...
«Il passaggio generalizzato ad agricolture presunte naturali - come il biologico o il biodinamico - porterebbe ad una crisi alimentare mondiale senza precedenti. Bisogna comprendere che la resa del frumento tenero convenzionale è dell’ordine di 70 q/ha (quintali per ettaro) e che quella del biologico non arriva a 30 q/ha. A questo proposito, è illuminante l’esempio dello Sri Lanka, ove due anni fa il governo abolì per legge i concimi di sintesi e i fitofarmaci, col risultato di far crollare le rese del riso e del tè, prodotti cruciali per l’economia di quel Paese. A fronte di tali evidenze trovo a dir poco curioso che l’Unione europea stia pianificando di aumentare la porzione di superficie agricola europea coltivata a biologico dall’attuale 9% al 25%».
Parliamo di siccità...
«È indubbio che a partire da dicembre 2021 abbiamo avuto in Italia, al confronto col contiguo passato, scarsissime precipitazioni rispetto ai nostri desideri. Il fenomeno va affrontato. Esso è il risultato di un promontorio anticiclonico subtropicale di blocco che si ripresenta con anomala frequenza sulla nostra area impedendo l’accesso alle perturbazioni atlantiche. L’area più colpita è stata il Nordovest, seguita dal Nordest; invece Centro e Sud sono stati fin qui indenni, salvo limitate aree del Lazio, della Sicilia e della Calabria. Tutto ciò indica la necessità per l’agricoltura di tecnologie innovative che favoriscano l’uso più efficiente dell’acqua piovana ed irrigua: varietà di piante coltivate resistenti alla siccità, metodi di irrigazione più efficienti, sistemazioni del terreno che favoriscano lo stoccaggio dell’acqua piovana nel semestre invernale, agricoltura conservativa che eviti perdite di acqua dal terreno per evaporazione».
Ma in Italia piovono ogni anno più di 200 chilometri cubi d’acqua, a fronte di un fabbisogno totale di meno di 20 chilometri cubi...
«Infatti. In Italia piove un ben di Dio, oggi in gran parte sprecato se consideriamo che solo l’11% dell’acqua piovana viene trattenuta per i diversi usi, mentre il resto finisce in mare. S’impone oggi un ripensamento complessivo del sistema di stoccaggio delle acque (a partire dalle grandi dighe) e del sistema di distribuzione dell’acqua raccolta. In termini di ritorno degli investimenti in opere di stoccaggio e distribuzione delle acque irrigue è illuminante il fatto che solo il 25% degli arativi mondiali è irriguo, eppure produce il 40% del cibo».
E dissalare l’acqua di mare?
«Il costo energetico dell’operazione è molto alto e, nel nostro caso, è superfluo. Dissalare può avere un senso sulle piccole isole che oggi sono rifornite dalla terraferma. Oppure in territori ove piove pochissimo, come accade in Israele. È irragionevole dissalare l’acqua, che so, del mar Ligure, con alle spalle di Genova una zona appenninica copiosamente piovosa: basterebbe creare degli invasi artificiali per raccogliere l’acqua piovana».
In agricoltura si vedono oggi effetti di una qualche crisi climatica?
«Direi proprio di no: è dal 1961 che le quattro principali colture - frumento, mais, riso e soia, che oggi coprono il 64% del fabbisogno calorico globale del genere umano - hanno incrementi di rese del 3% l’anno».
Ma come, +3% l’anno... e gli allarmi continui?
«In agricoltura vale la legge che l’economista Adam Smith enunciò nel 1776: «In un Paese ove commercio e comunicazioni sono libere, la scarsità di grano in annate sfavorevoli non può portare alla carestia, perché la siccità e l’eccesso di pioggia saranno dannose a una parte del Paese ma favorevoli all’altra». Una legge applicabile oggi all’Italia, ove la penuria d’acqua d’oggi è compensata dall’abbondanza d’acqua di ieri. Bisognava raccogliere quest’ultima e usarla oggi».
Che impatto hanno, in agricoltura, le emissioni antropiche della CO2, additata come un pericoloso inquinante?
«Macché inquinante: la CO2 è il mattone fondamentale della vita sul pianeta! Essa interviene nella fotosintesi, che è la meravigliosa reazione, alimentata dall’energia solare, ove sei molecole di CO2 e sei molecole di acqua danno una molecola di glucosio (da cui deriva tutta la materia organica che compone gli esseri viventi) e sei molecole di ossigeno (altrettanto importante per i viventi)».
V’è crisi climatica?
«Dai dati globali non si vede alcuna crisi climatica. Le catastrofi naturali di origine meteo-climatica sono stazionarie o addirittura in lieve calo da oltre un ventennio, la mortalità associata a tali catastrofi è in calo rilevantissimo, e le stesse rese globali delle colture, come abbiamo già detto, sono in rilevante aumento. Secondo l’ultimo Rapporto dell’Ipcc, le piogge violente (volgarmente note come bombe d’acqua, sempre più spesso additate all’opinione pubblica come causa di disastri senza precedenti) sono stazionarie nel 90% delle 8.000 stazioni pluviometriche analizzate a livello globale, aumentano nell’8% delle stazioni e calano nel 2%. Il Rapporto ci informa anche che sul Mediterraneo le piogge violente sono stazionarie nel 92% delle stazioni, aumentano nel 4% e diminuiscono nel restante 4%. Come vedere in questi dati i prodromi di una “crisi climatica” in nome della quale si fanno marciare gli studenti di mezzo mondo? Al contrario, davanti a noi c’è un futuro di prosperità e un mondo libero dall’insicurezza alimentare. A patto di conservare la fiducia nell’innovazione».