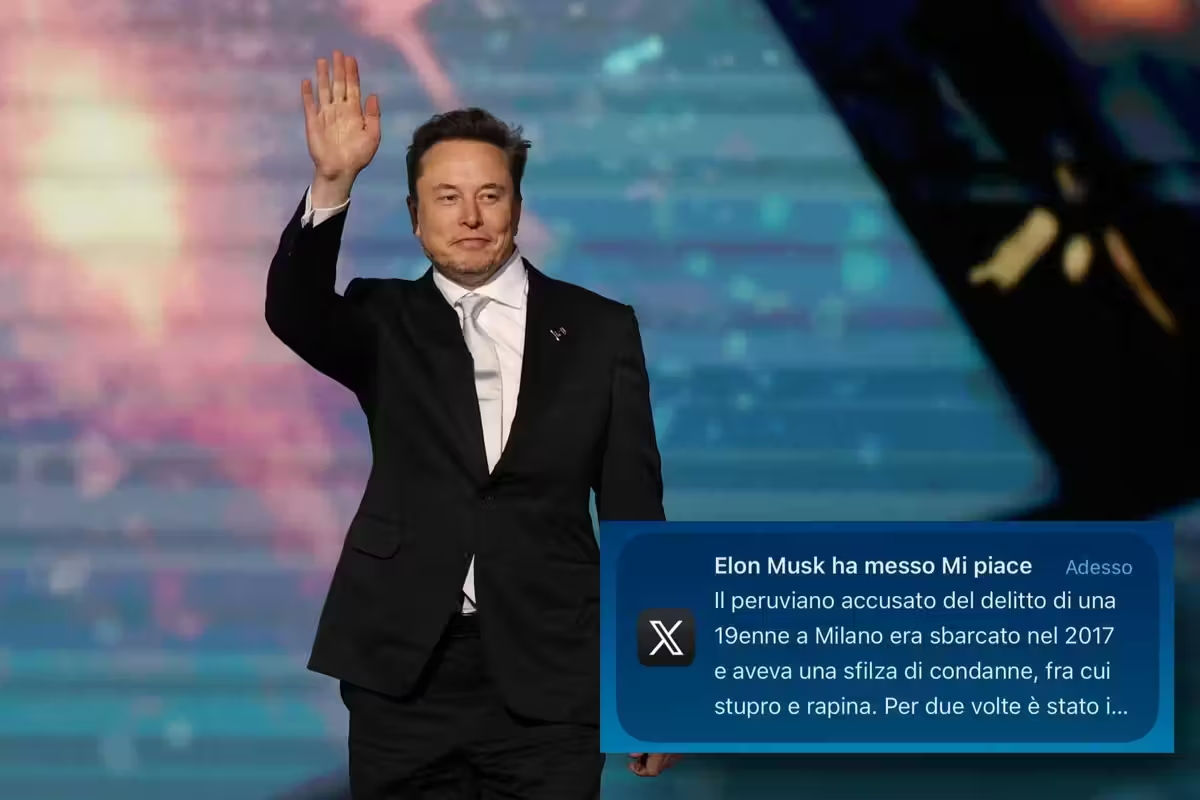Troppe regole e restrizioni sui voli: così l'Ue rimane a terra

Mentre la mano di Bruxelles si fa sempre più pesante su molte aree produttive (dall'alimentare fino al farmaceutico), il mondo dell'aviazione soffre le eccessive norme europee, che hanno impoverito e depresso il settore senza neppure ridurre la percentuale di incidenti. A causa delle lungaggini burocratiche sono crollate le ore di volo ed è diminuito il numero di aeromobili privati con conseguenze per tutto l'indotto, a partire dalle assicurazioni e dalle officine.
Troppi incidenti: l'aviazione va regolamentata, firmato Bruxelles. Dietrofront: troppe regole, l'aviazione sta soffocando tra le normative, le ore di volo calano e in percentuale gli incidenti non diminuiscono. È quanto appreso durante Aero 2018, il salone aeronautico di Friedrichshafen, in Germania (18-21 aprile). Non stiamo parlando dell'aviazione commerciale, delle compagnie aeree e dei vettori cargo, bensì dell'aviazione generale, ovvero di quella fatta dalle scuole di volo, dai privati e dai praticanti degli sport dell'aria. Così, mentre in tutti i settori produttivi, dall'alimentare fino al farmaceutico, l'Unione europea sforna regole sempre più severe, in campo aeronautico l'Easa (European aviation safety agency, con sede a Colonia) è stata subissata di critiche. E da un calo degli utili derivanti dai servizi erogati alle aziende del settore - e stante che impiega circa 900 funzionari - si è finalmente accorta che i regolamenti e le norme emanati negli ultimi dieci anni hanno impoverito e depresso il settore che costituisce la proprio la base dell'aviazione maggiore.
A cominciare dai costruttori di piccoli aeromobili, dalle scuole di volo e dai club di appassionati che li usano, sodalizi ormai investiti dagli stessi adempimenti burocratici che hanno le compagnie di trasporto aereo. Ma è calato anche il numero degli aeromobili privati in linea di volo: ciò ha come causa diretta il calo dei proventi per le assicurazioni, per chi offre l'hangaraggio e l'accessoristica, nonché la chiusura di molte officine specializzate. Tutto questo in un momento nel quale l'aviazione maggiore ha invece bisogno di piloti e sono stati aperti centri di addestramento con standard europei negli Emirati e negli Stati Uniti d'America, contro i quali le scuole continentali non riescono a competere né per tempi di conseguimento dei titoli né per costi. Del resto, diventare pilota privato costa oggi circa 15.000 euro, per divenire pilota professionista ne servono anche 60.000. E pensare che negli anni Settanta lo Stato italiano offriva attraverso gli aeroclub il 50% del costo del brevetto. Altri tempi.
Qualche numero può dare l'idea del disastro europeo: raddoppio delle autorità aeronautiche, perché - seppure esista Easa - ogni Paese Ue mantiene anche la propria istituzione nazionale, che per noi italiani è Enac; calo del 25% delle ore di volo nell'ultimo decennio, del 15% del numero di licenze di pilotaggio attive e del 18% del numero di aeromobili registrati nell'Ue; raddoppio dei costi di gestione delle flotte, fatto al quale noi italiani siamo riusciti anche ad aggiungere le tasse imposte da Mario Monti e ancora non tolte, causando un'emorragia di mezzi verso Germania e Regno Unito, unito a una persecuzione fiscale insensata verso i possessori di mezzi (beni mobili registrati) che non possono essere «nascosti» e generano un grande indotto. Risultato, l'intero comparto ha un volume paragonabile a quello del 1997 seppure a livello di vendite mondiali di aeroplani nuovi di categoria monomotore (i più piccoli) si sia passati da -9,7% del 2016 a +3,3% del 2017 (fonte: Associazione costruttori www.gama.aero).
Ecco allora che Easa corre ai ripari e dando ascolto alle associazioni degli operatori ha messo in atto una semplificazione normativa mai vista prima che prende il nome di General aviation implementation roadmap. Niente più costosi manuali approvati e aggiornati di continuo dalle autorità aeronautiche per certificare le scuole che formeranno piloti privati di aeroplano, aliante e mongolfiera, per aprire le quali basterà l'autocertificazione a garanzia dell'osservanza di poche regole; niente più Certificato di operatore aeronautico per fare alcuni tipi di lavoro aereo e per le operazioni specializzate come il traino striscioni, l'osservazione e l'aerofotogrammetria. Più facile anche per i piloti privati affrontare abilitazioni superiori come quella al volo strumentale e ai dispositivi di sicurezza più moderni. Oltre i provvedimenti politici ce ne sono poi alcuni strettamente tecnici ma di grande importanza, come l'aumento del peso massimo dei velivoli ultraleggeri da 472,5 a 600 chilogrammi, cercando anche di uniformare la categoria alla norma Light sport con più permissività sul piano dei requisiti psicofisici per chi volesse conseguire la licenza di pilotaggio leisure comunitaria, in sigla Lapl. Chi possiede un piccolo aeroplano, per esempio un monomotore a quattro posti, potrà anche presentare e farsi approvare dall'autorità aeronautica locale un proprio manuale di manutenzione potendo quindi svolgere personalmente parte dei controlli obbligatori previsti su quel tipo di aeromobile.
Per trovare un esempio storico simile a questo nel campo aeronautico bisogna ritornare all'atto di rivitalizzazione dell'aviazione generale scritto dalla senatrice repubblicana Nancy Kassebaum e firmato nel 1994 dal presidente Usa Bill Clinton, poi ratificato da George W. Bush. Quindi arrivò Barack Obama e anche l'aviazione popolare Usa, la più grande del mondo, cominciò a soffrire: oggi perde l'1,7% annuo sul numero di piloti attivi. Perché l'aviazione generale sia così importante per la società è presto detto: senza i piccoli aeroplani non c'è porta d'ingresso né palestra per neo piloti, ingegneri e tecnici che poi transiteranno nel comparto maggiore, incluso quello dell'industria aerospaziale, settore da oggi e per i prossimi trent'anni considerato trainante stante la crescita a due cifre dell'aviazione commerciale, l'aumento della ricerca e della spesa militare causato dall'instabilità geopolitica attuale e l'arrivo dei mezzi a pilotaggio remoto che ha di fatto creato un nuovo importante ramo del settore. Le modifiche europee entreranno in vigore nel 2019, speriamo non sia troppo tardi.
- Aero 2018 Opens: Electric Airplanes Dominate - AVweb flash Article ›
- EASA at AERO 2018 | EASA ›
- EBACE2018 - 2018 European Business Aviation Convention ... ›
- WAITING FOR AERO 2018... WE WILL BE THERE! - FlyEurope.TV ›
- Aeronautica Militare ›
- VFR AVIATION - porta in quota la tua passione | Magazine di Volo ... ›
- Aero Friedrichshafen 2018 ›
- AERO | April 18 – 21, 2018 ›
- 2018 Shadow Aero Overview - Honda Powersports ›
- AERO | April 18 – 21, 2018 ›