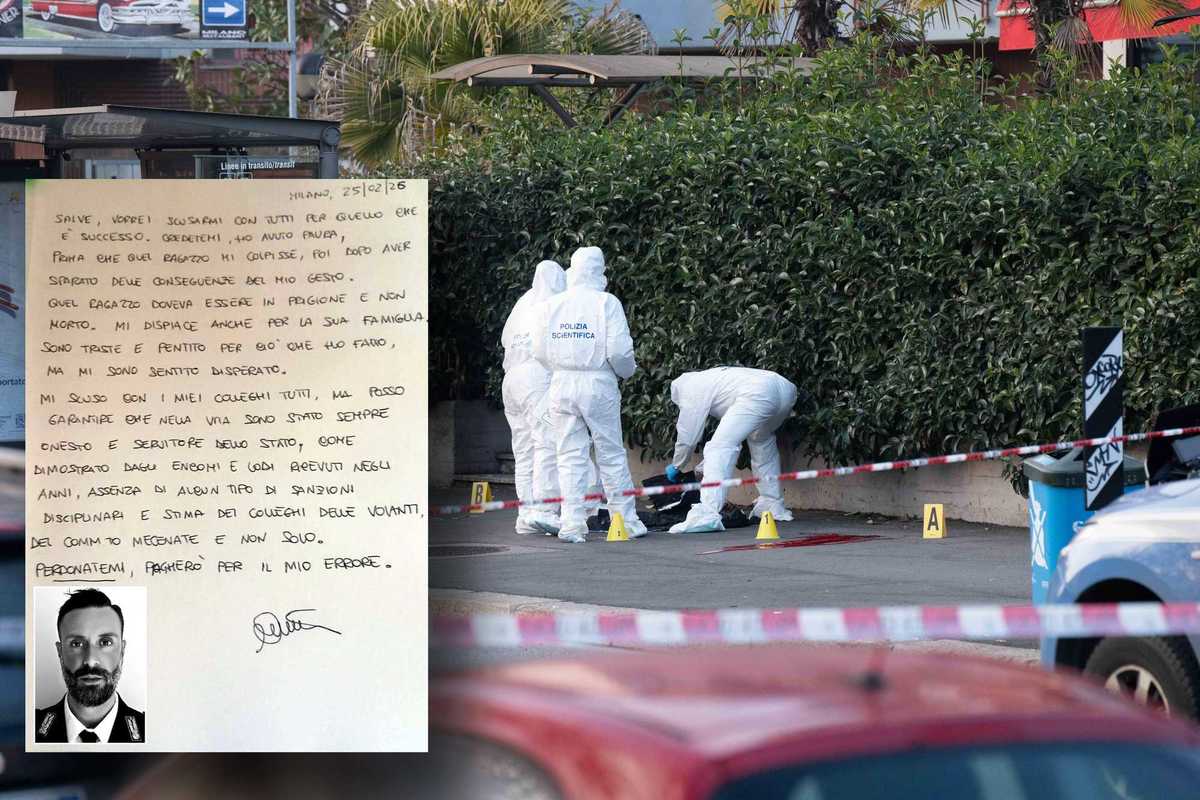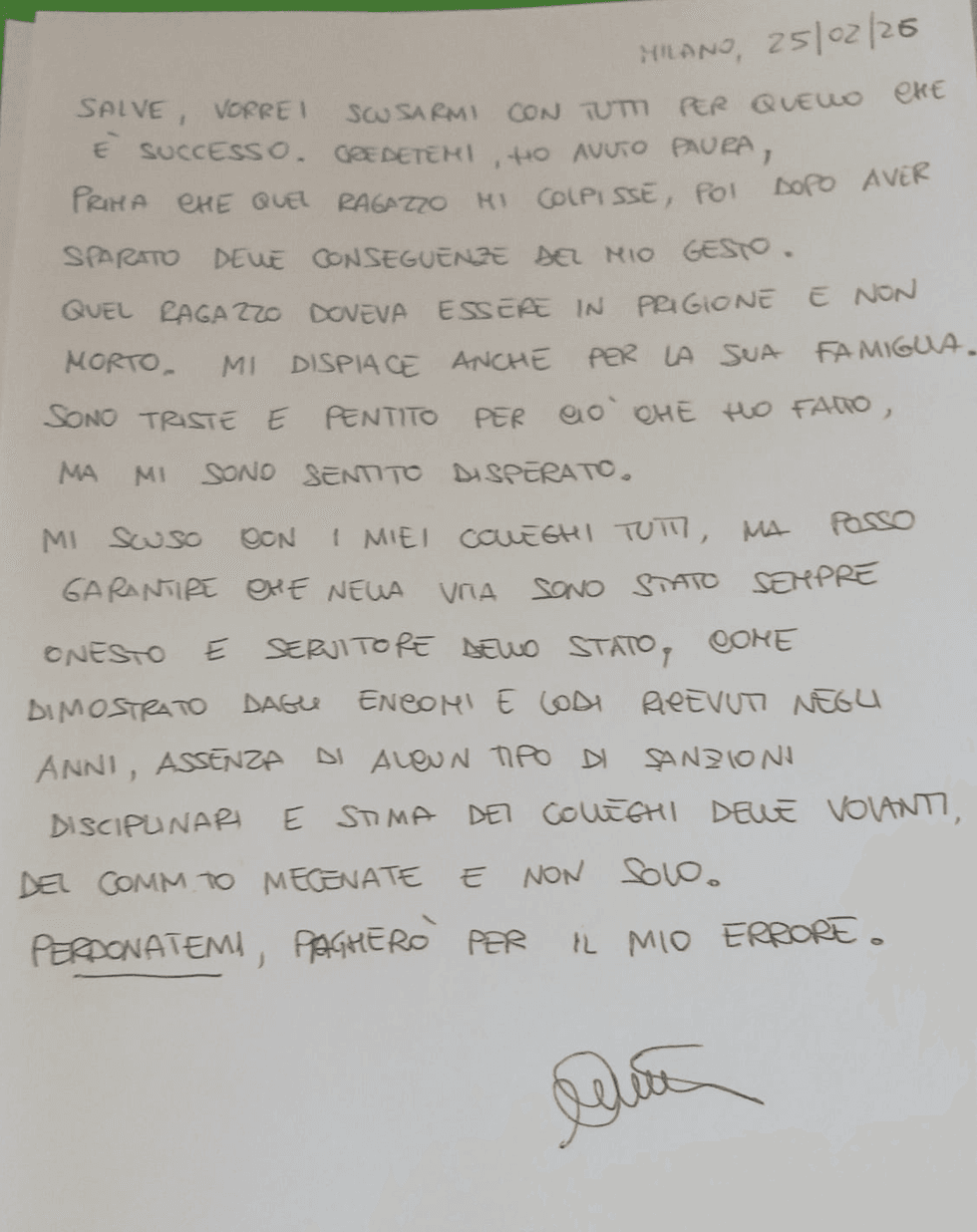- Mosca e Kiev, con l’aiuto di Ankara, trovano un’intesa di massima sui corridoi per far uscire le navi da Odessa. Il Sultano si impegna sugli sminamenti. Dmytro Kuleba semina dubbi: «Putin potrebbe attaccare». L’Ue insulta: «Cremlino ladro e codardo».
- Il petrolio fa riabilitare pure Nicolás Maduro. L’embargo è un autogol e i tabù cadono: Stati Uniti e Francia chiedono all’Arabia.
Lo speciale contiene due articoli.
Più che per arginare l’ormai inevitabile controllo di Vladimir Putin di buona parte del Donbass, è sul grano che si stanno svolgendo le vere trattative diplomatiche. Ucraina e Russia, con la mediazione della Turchia, avrebbero raggiunto un accordo preliminare per sbloccare le spedizioni di prodotti agricoli ucraini da un porto chiave sul Mar Nero. Lo riferisce il quotidiano di Mosca Izvestija, poi ripreso dai media ucraini, citando fonti autorevoli.
I militari turchi saranno impegnati nello sminamento e scorteranno le navi in acque neutrali, dove la flotta russa le seguirà sul Bosforo. Finora, lo schema è stato concordato solo per Odessa. La Turchia, dove domani sarà in visita il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha in mente di realizzare un centro a Istanbul, che coordinerà e monitorerà l’attuazione della missione e confida che l’approvazione di questo piano, da parte delle Nazioni Unite, ne garantisca l’attuazione in sicurezza.
La Russia, ricordiamo, si era offerta di aprire un corridoio attraverso il Mar Nero per le spedizioni di generi alimentari, in cambio di un allentamento delle sanzioni. Dall’Ucraina arrivano comunque segnali di scetticismo. Il presidente Volodymyr Zelensky ha fatto sapere di non essere stato invitato ad Ankara l’8 giugno a discutere e di non essere pronto «a esportare grano dalla Bielorussia». Mentre su Twitter, il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha scritto: «Putin dice che non utilizzerà le rotte commerciali per attaccare Odessa. Questo è lo stesso Putin che ha detto al cancelliere tedesco Scholz e al presidente francese Macron che non avrebbe attaccato l’Ucraina, giorni prima di lanciare un’invasione su vasta scala del nostro Paese. Non possiamo fidarci di Putin, le sue parole sono vuote».
Sta di fatto che le trattative avanzano, e proprio sul fronte del grano fermo da inizio conflitto in tutti i principali porti sul Mar Nero, in particolare stoccato nell’area di Odessa. L’Ucraina, uno dei maggiori esportatori al mondo di questo cereale, assieme a orzo e mais, sa che 22 milioni di tonnellate stanno deperendo, bloccate nei silos della città portuale, dove le acque sono state minate. Secondo quando ha dichiarato il presidente, Volodymyr Zelensky, entro l’autunno potrebbero esserci 75 milioni di tonnellate di grano bloccate nel suo Paese.
In un briefing a Kiev, ha confermato che l’Ucraina ha discusso con la Gran Bretagna e la Turchia l’idea di richiedere alla Marina di un Paese terzo di garantire il passaggio delle esportazioni di grano ucraino attraverso il Mar Nero, controllato dalla Russia. La migliore garanzia per il loro passaggio, ha però aggiunto, sarebbe l’armamento ucraino.
Prima del 24 febbraio, quando iniziò l’invasione russa, nei Paesi dell’Unione europea arrivavano dai porti gestiti da Kiev più di 700.000 tonnellate di grano l’anno, il 4% delle importazioni totali, 65.000 tonnellate di grano duro, che secondo la Coldiretti rappresentano poco più dell’1%, quasi 9 milioni di tonnellate di mais (25% del totale) e circa 2 milioni di tonnellate di olio di girasole (45% del totale dell’import).
«Ci sono gravi turbative nel commercio dei cereali a seguito della guerra. I blocchi dei porti, l’incapacità di trovare vie alternative per il trasporto dei prodotti agricoli dall’Ucraina e verso l’Ucraina. Tutto questo ha determinato una spirale dei prezzi e una forte instabilità con una forte pressione sulle catene di approvvigionamento alimentare», ha dichiarato ieri a Strasburgo il presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in apertura del dibattito in occasione dei 60 anni della Pac, la Politica agricola comune della Ue. Sottolineava che «c’è bisogno di una forte reazione da parte nostra», gli approvvigionamenti sono indispensabili. «Il Cremlino prende di mira i depositi di grano e lo ruba dalle aree che ha occupato, scaricando la colpa su altri. Questo è codardo», ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, con un intervento a gamba tesa nel corso del suo intervento all’Onu, precisando di aver visto con i suoi occhi «la situazione a Odessa: tonnellate di grano sono bloccate in container a causa delle navi da guerra russe nel Mar Nero e per gli attacchi della Russia alle infrastrutture di trasporto». Per tutta risposta l’amasciatore russo ha abbandonato l’aula.
Ma grano e orzo di Ucraina e Russia vengono venduti pure ai Paesi africani, che importano il 40% del loro fabbisogno. Ruanda, Tanzania e Senegal arrivano al 60%, l’Egitto all’80% e il blocco effettuato dai russi sta preoccupando enormemente il Continente nero. Anche l’esclusione delle banche russe dal sistema Swift per le transazioni interbancarie rappresenta un problema, ha denunciato il presidente dell’Unione africana, Macky Sal, perché non si possono acquistare cereali dalla Russia. Lo spettro della fame è sempre più reale. Lo stesso papa Francesco ha lanciato un «accorato appello» affinché «non si usi il grano, alimento di base, come arma di guerra». La crisi alimentare, vero o strumentalizzato che sia il pretesto, sta spingendo sempre più migranti a raggiungere le nostre coste come sta accadendo a un ritmo che preoccupa tutti, tranne il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Perciò sul grano, la diplomazia appare più determinata a raggiungere degli accordi.
Il greggio fa riabilitare pure Maduro. Via libera degli Usa a Eni e Repsol
L’embargo europeo sul petrolio russo non è ancora entrato in vigore, ma i suoi effetti si fanno già sentire. Al contrario di quanto vorrebbe chi ha caldeggiato le sanzioni, però, il divieto contenuto nel sesto pacchetto Ue non sta influenzando l’industria petrolifera russa, quanto piuttosto le filiere di approvvigionamento europee.
È di domenica la notizia che il Dipartimento di Stato americano avrebbe autorizzato nel mese di maggio due compagnie petrolifere, l’italiana Eni e la spagnola Repsol, a importare in Europa greggio dal Venezuela, aprendo così una breccia nel rigido quadro sanzionatorio applicato da anni al Paese sudamericano governato da Nicolás Maduro. I quantitativi che le due compagnie potranno portare in Europa non sono molto significativi e non potranno dare luogo a pagamenti, ma solo ad abbattimento dei debiti. Inoltre, il petrolio non potrà essere rivenduto altrove. Non ci si aspetta che questa apertura possa avere un effetto particolare sui prezzi del greggio. Ma il dato è importante perché segnala che la ricerca di alternative al petrolio russo da parte dell’Europa gode del supporto degli Usa, che sono disposti anche a rivedere alcune posizioni sui rapporti con Stati giudicati sino a ieri «canaglia». Un indice molto chiaro del fatto che l’obiettivo dell’isolamento economico della Russia è giudicato prioritario da Washington.
Nella narrazione della Casa Bianca, l’apertura alle esportazioni di greggio dovrebbe servire anche a favorire il dialogo tra il governo Maduro e l’opposizione capeggiata dall’autoproclamato presidente Juan Guaidó. L’economia del Paese sudamericano, che dipende in gran parte dall’estrazione del petrolio, è assai provata dai lunghi anni di isolamento. A causa dell’embargo in vigore da diversi anni la produzione di greggio è scesa dagli oltre 3 milioni di barili al giorno a circa 500.000. In difficoltà sul fronte interno, la Casa Bianca sta mutando radicalmente la propria diplomazia energetica: prima annuncia l’intenzione di sospendere per due anni i dazi all’importazione sui pannelli solari dal Sudest asiatico, poi fa sapere che si sta dedicando al delicato dossier Arabia Saudita. Il presidente, Joe Biden, dovrebbe recarsi in visita a Riyad entro fine mese. Il rapporto tra Usa e Arabia Saudita si era gravemente incrinato nel 2018 dopo la vicenda dell’omicidio di Jamal Khashoggi, giornalista del Washington Post. Secondo le indagini dei servizi americani, sarebbe stato il principe saudita Mohammed bin Salman a ordinare l’assassinio. Biden, allora candidato alle presidenziali americane, durante un dibattito del 2019, aveva affermato che «avremmo dovuto far loro pagare il prezzo e renderli di fatto i paria che sono». Ora però il prezzo della benzina, giunto negli Usa a livelli record, spinge Biden a più miti consigli. Le elezioni di midterm previste per novembre impongono all’amministrazione dem di accelerare sul contenimento del prezzo della benzina, un elemento cui gli elettori sono assai sensibili. All’apertura dei mercati di ieri il petrolio è tornato sopra i 120 dollari al barile, dopo che la stessa Arabia Saudita ha aumentato i prezzi di vendita ufficiali. Il listino di luglio per il greggio Arabian Light diretto in Asia è salito di 2,1 dollari al barile. L’aumento segue la decisione della settimana scorsa a livello di Opec+, che ha stabilito un aumento della produzione per i mesi di luglio e agosto a 648.000 barili al giorno.
Anche la Francia nel frattempo si muove. Da Parigi filtra la notizia di trattative in corso con un altro Paese controverso. «Ci sono discussioni con gli Emirati Arabi Uniti. Dobbiamo trovare alternative al petrolio russo», ha detto il ministro delle Finanze, Bruno Le Maire. La diplomazia della necessità cancella i peccati.